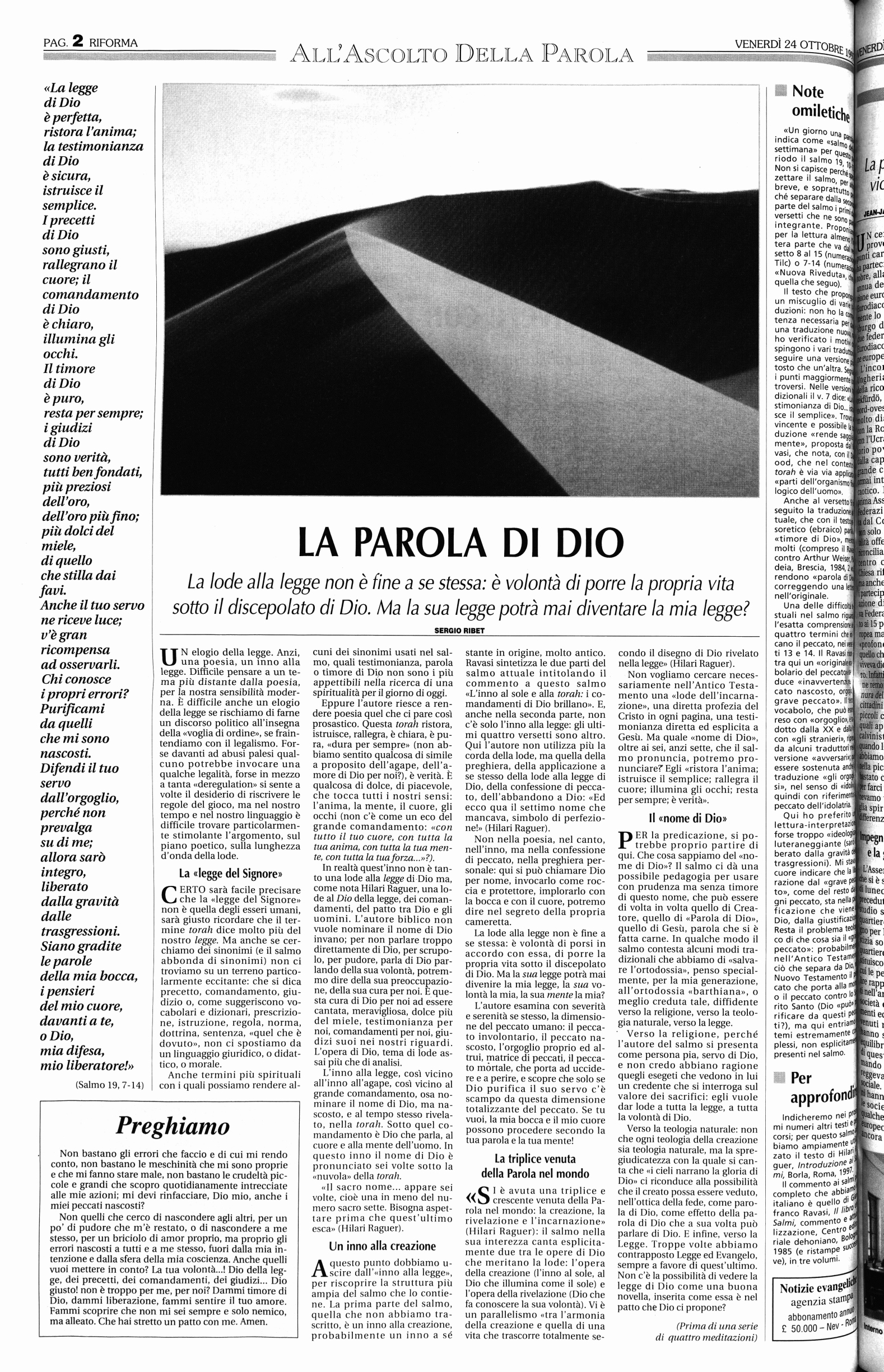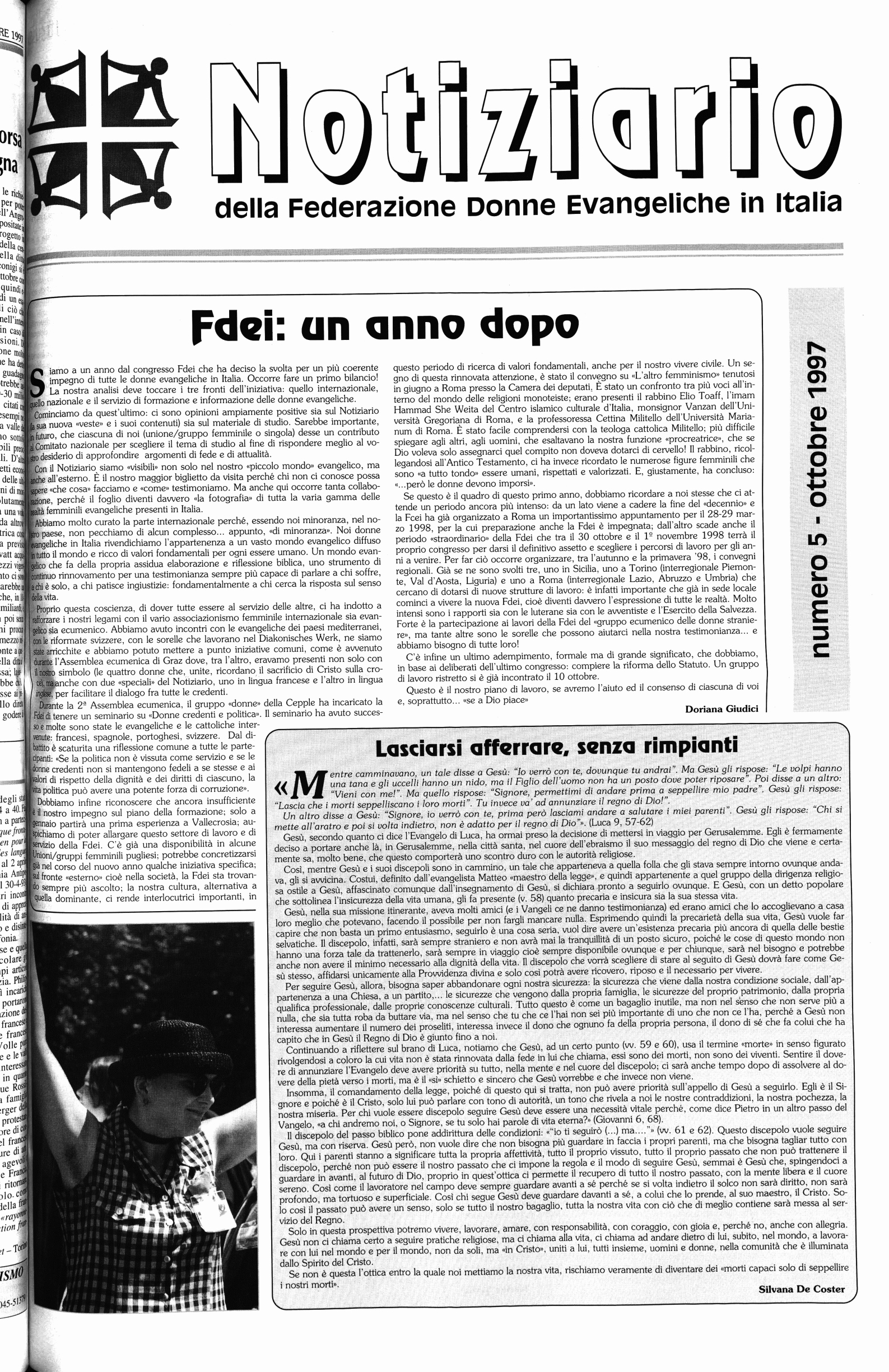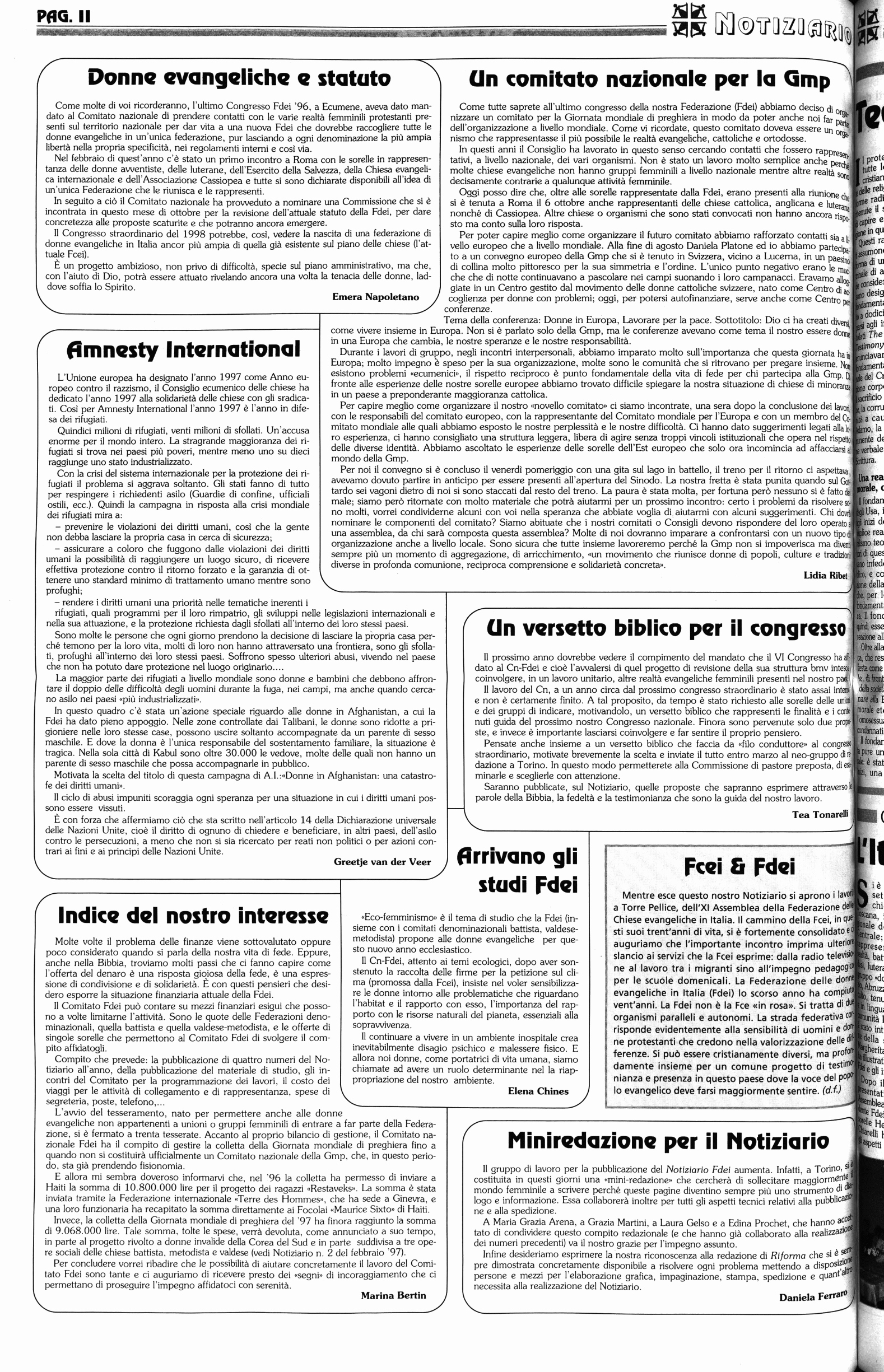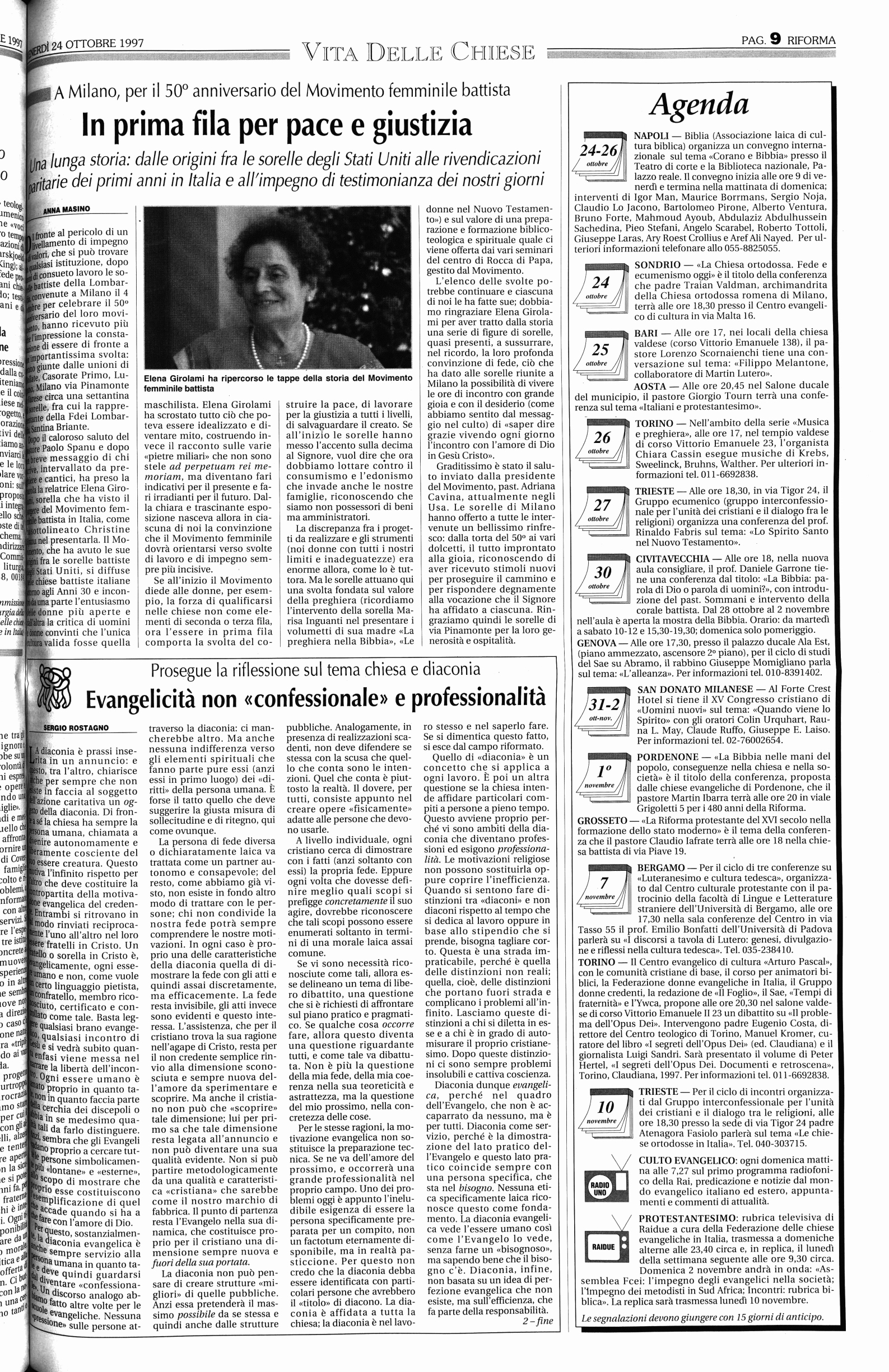1
1
tpedìiionem 1 .> comma- : fii.aie di Torin * a. p. 45% !0/B legge 662/ illlillilHiil
^ io caso di nian prega restìi 3 1 Ufficii cato recapita aire al mittente > PT Torino CM
creato,, .
dipartilanitaarrivare
attività
:olare a
I il pere orga
rsidenti
ixandei
;sato
iuropea,
rn bloctrte, in.
otrebbe
to sigili’
tiraenti
ncessio-,
;i, indiare Falca dell
to nei
3, noni
1 regi
perty
lice-®
iielor»
DeiM
0 le dm
) ortanti
e. È e#
5sia pio
1 è molto
i giugM
europeoy
ione
ione
3russiat
irograinnviataal
ko,
àonecot
, che pi'
^iovanit
intedelh
ssa di Iti'
a Cem
iell'Asso
anitad^
\s\
ionici'®
lollaborajrtodoss*
ae "Hf
Ud”,
irogetti
ivorew'
itegucrj
enonW
neanclj ,
Ü diffi®
di forf
ai proj
za
1 minisi’!
riuniti’
? e 23 se,
deciso
mento
i a Mos^
ichéiPÌ,
lici, SI
ÍV
li chiosf,
ma if"
0 ecuif!
ull»
ELOGIO
pELLA DEBOLEZZA
„la mia grazia ti basta, perché la
mia potenza si dimostra perfetta nella
debolezza»
II Corinzi 12, 9
ynOLTANTO chi vive nella propria
; J esistenza realtà di grandi difficoltà
può valutare in profondità il valore li'berante di queste parole. L’apostolo
paolo prega Dio di liberarlo dalla malattia che lo tormenta, ma al posto delia guarigione riceve delle parole. Sono
parole che esprimono una promessa
non coincidente con le attese umane, e
suonano alle nostre orecchie come una
■'non risposta: tuttavia l’apostolo acco'i}ie il discorso di Dio e lo elegge a nuovo e stabile fondamento della propria
vita. La forza di Dio non si manifesta
’con le modalità universalmente accet'iate del Dio onnipotente che scende
dall’alto e mette a posto le cose che
non vanno, soprattutto le nostre. Dio
'^unge a noi attraverso una via stretta
e tormentata: la via difficile dell’incar'Mione in Gesù di Nazaret che esige
mfaticoso viaggio fra le contraddizioni della storia delle donne e degli uoràni. Di conseguenza ciò che appare
evidente nella potenza di Dio è la sua
déolezza: ciò che appare evidente
InA^^solutezza di Dio è la sua discuticiò che appare evidente nella
imlità eterna di Dio è la sua precarietà nel mondo.
/valdesi medievali avevano cornpreso
questo paradosso: alle grandi cattedrali contrapponevano le loro modeste
e ospitali scholae, case di preghiera, di
studio e di accoglienza. Lutero indica il
superamento della teologia della gloria
mediante la teologia della croce che
esalta il paradosso di Dio che manifesta la sua potenza nella debolezza della croce. La Grazia soltanto deve bastare, la Grazia soltanto costituisce la promessa del regno di Dio che si realizza
ogni giorno nella parzialità della nostra vita. Però, quanto e difficile per
noi comprendere e accettare questa decisione di Dio, questa sua pedagogia
.ohe non ci permette fughe mistiche verso il cielo ma ci chiede di attendere sullo terra l’avvento del Regno. Nel frattempo noi ci ammaliamo, soffriamo, ci
laceriamo e spesso sentiamo di andare
alla deriva. Tutti sono più forti di noi e
più sicuri di noi: tutte le altre religioni
offiono sicurezze consolanti, guarigio
ni miracolose, equilibrio e potere della
mente: quasi tutti i movimenti religiosi
vivono un periodo di incremento numerico. Noi invece no, e in Italia c’è chi
prevede per le nostre chiese una scom
parsa o quasi, e per i movimenti reliSlosi in sviluppo un fulgido avvenire.
Cvero, non siamo mai stati così deboli come in questi anni: anche la
^flessione teologica si confìtta come
V'Ua realtà debole e piena di incertezze
0 incontriamo notevoli difficoltà a
coinvolgere le giovani generazioni in
^n comune cammino di fede. Certamente abbiamo commesso degli errori
c nella nostra storia di protestanti itahani ci sono delle zone d’ombra. Forse,
^\di là delle buone intenzioni, non
^iamo stati capaci di vivere fino in
fondo l’Evangelo della grazia di Dio,
che è la sola risposta efficace alle sfide
ùel mondo. Sono convinto che la forza
“Oiia testimonianza sia un dono di
^‘0 e non il frutto delle nostre doti, ma
me convinzione non deve diventare
^^ ulibi che celi alla nostra coscienza
mfedeltà e pigrizia spirituale. Non è
'^^f^tnente il caso di vantarsi della
mjflcile crisi in cui versiamo: infatti
elogio della debolezza può avere sen
0 se è riferito alla decisione di dare
to il primato nella nostra vita senza
fendere a facili compromessi con la
Vitalità dominante nel mondo.
^ Antonio Adamo
SKTTIM VNALK DKU.K ( HIKSi: KVANC'.KLICHK BAiTiSl K, MKIODISTK, VAI.DKSl
Nelle Marche e in Umbria la terra continua a tremare facendo aumentare le sofferenze
Vivere con il terremoto infinito
Bisogna cambiare mentalità, bisogna aumentare la prevenzione, bisogna investire nella
protezione civile, nella normativa antisismica e nel riassetto idrogeologico del territorio
EUGENIO BERNARDINI
Luigi Padovan, membro della
Chiesa battista di via Elvo a Torino, volontario della Croce Rossa
di Santena (un Comune nei pressi
del capoluogo piemontese), è arrivato nelle zone terremotate delle
Marche il 30 settembre e ci è rimasto fino al 17 ottobre.
«Sono stato mandato nella provincia di Macerata, nelle Marche,
col gruppo della protezione civile
del Comune di Santena perché durante l’alluvione del 1994 che aveva
colpito il Piemonte avevamo ricevuto aiuto da quella città - racconta Padovan E stato quindi naturale che il sindaco si mettesse in
contatto con la protezione civile di
Macerata per offrire il nostro aiuto.
Purtroppo abbiamo notato subito
le carenze organizzative perché la
centrale dell’unità di crisi di Macerata ci ha messo un giorno intero
per decidere in quale zona inviare
la nostra unità operativa».
- Dove vi hanno inviato?
«A Muccia, un Comune di 905
abitanti, vicino a Serravalle, Taverne, Cesi, Colfiorito, insomma vicino all’epicentro del sisma. Quando
siamo arrivati abbiamo pensato
che ci avessero preso in giro perché
le case erano tutte in piedi. Poi ci
hafmo fatto vedere da vicino; crepe
dappertutto, intere pareti crollate,
insomma quasi tutte le abitazioni
inagibili. È stato shoccante, perché
il terremoto non è solo la scossa, la
paura, i dolori, i lutti, ma vedere
anche tutte le proprie cose distrutte, disperse, inservibili. E poi le
scosse continue. Insomma, molto
difficile, anche emotivamente».
- Quale è stato il vostro compito?
«La nostra unità di 7 persone era
autosufficiente, avevamo la nostra
tenda, viveri, tutto. Solo che abbiamo messo a disposizione anche
questo perché siamo stati tra i primi
ad arrivare. Il Comune ci ha dato un
localino nella scuola materna che
era chiusa. Poi abbiamo dato una
mano nella viabilità, abbiamo visitato tutte le frazioni dei dintorni,
che sono molte, abbiamo montato
45 tende, e fatto i mille piccoli servizi di supporto, come portare l’acqua potabile, di collegamento e organizzazione e poi di contatto umano con le persone, tutto ciò che è
necessario in questi casi. Il Comune
è stato d’accordo con la nostra proposta di non creare una tendopoli
perché quello è un paesino di montagna in cui molti hanno le bestie,
per cui abbiamo montato le tende
nelle varie frazioni, vicino alle stalle
in modo da consentire ai contadini
di poter accudire agli animali».
- Prima ha accennato a ritardi
organizzativi...
«Ritardi e anche una notevole disorganizzazione vera e propria. Sicuramente molti dei soccorritori non hanno aiutato come avrebbero potuto proprio per le carenze
organizzative e di comunicazione
fra i vari enti preposti ai soccorsi».
- Ma anche da parte dei Comuni
c’è stata impreparazione, nel senso
che non c’erano i piani di protezione civile che pure sono obbligatori
per legge?
«Certo, benché quella sia una zona soggetta a scosse telluriche non
abbiamo trovato gruppi locali di
protezione civile, né c’erano dei
piani predisposti. Almeno nella zona in cui ho operato io. Ora, invece, si sono resi conto che è necessario fare qualcosa nella prevenzione. D’altra parte la stessa cosa è
successa in Piemonte. Nel 1994
neanche noi a Santena eravamo
pronti a far fronte a un’alluvione».
- Abbiamo sentito che sono rimaste lesionate anche le case che erano
state ristrutturate secondo le norme
antisismiche, è vero?
«Vero. Non sono stati sufficienti
gli interventi fatti sulle case vecchie, come le solette di cemento
armato, che legano la casa e il tetto; ho visto pareti crollate lo stesso
o case gravemente lesionate e
quindi inagibili. Forse sulle case
nuove hanno effetti maggiori. Non
so se dipenda dalle norme antisismiche insufficienti o dal numero
e intensità delle scosse, che sono
state veramente impressionanti.
C’erano soprattutto le persone anziane con i nervi a pezzi».
- In generale come ha reagito la
popolazione?
«In modo composto e operoso,
compatibilmente con la situazione, naturalmente. Tra tutto il male
che ha portato il terremoto ha almeno portato un bene: le persone
si sono sentite più vicine, si sono
aiutate, parlano insieme, erano loro stessi a notarlo. E poi hanno dato tanto a noi. Noi abbiamo ricevuto più di quello che abbiamo dato.
La solidarietà umana fa crescere
anche la fraternità».
- Abbiamo sentito di polemiche
sull’eccessiva attenzione dei mezzi
di informazione ai monumenti di
Assisi, Foligno...
«Quando è caduta la cupolina
della torre campanaria di Foligno
la gente ha detto con una certa
soddisfazione: finalmente parleranno più delle persone che dei
monumenti».
- Ha incontrato evangelici in
quella zona?
«No, nel mio gruppo operativo di
Santena c’era anche un valdese
della chiesa di Torino, ma evangelici del posto non ne abbiamo incontrato; nella nostra zona si intende».
- La Federazione delle chiese
evangeliche in Italia ha lanciato
una sottoscrizione a favore delle
popolazioni colpite...
«E ha fatto bene perché i danni
sono estesi e ingenti. Per esempio
il sindaco era preoccupato non solo per la ricostruzione delle case di
abitazione ma anche della Casa di
riposo per anziani che è da ricostruire completamente».
Jerzy Buzek di Solidarnosc
Un premier protestante
nella «cattolica» Polonia
Molto scalpore ha suscitato la designazione a
primo ministro del nuo-vo governo polacco di
Jerzy Buzek, 57 anni, do-cente universitario di
chimica, piuttosto sconosciuto anche se attivo
in Solidarnosc sin dal
1980. Il primo ministro
dovrà farsi carico della
politica sociale. Inevitabilmente però la coalizione di destra dell’attuale premier dovrà allearsi con l’Unione della
Libertà, politicamente
del centro-sinistra, partito di Leszek Balcerowicz,
già vicepremier nel governo del 1989 e architetto del cosiddetto «mo
dello economico polacco» nel passaggio dal sistema sovietico a quello
occidentale. Un fatto poco noto nella stessa Polonia è l’appartenenza di
Buzek alla Chiesa della
confessione di Augusta,
la più antica e numerosa
chiesa evangelica in Polonia. La fondazione di
questa chiesa luterana
che attualmente conta
intorno a 70.000 membri
risale al XVI secolo. Alla
stessa chiesa apparteneva anche, convertitosi
dal cattolicesimo, il maresciallo Pilsudski, padre
dell’indipendenza polacca nel 1918 ed eroe
nazionale, (p.g.)
FEDERAZIONE DELLE CHIESE
EVANGELICHE IN ITALIA
XI Assemblea
Giovedì 30 ottobre 1997-Torre Pellice
«Allarga le tue tende e rafforza i tuoi paletti»
(Isaia 54, 2)
Fra storia e speranza: vivere l’attesa
Serata pubblica nel tempio valdese, ore 21, su
LA LIBERTÀ DEGLI ALTRI
dibattito sulla libertà religiosa oggi in Italia
Modera Franco Becchino, pastore metodista. Intervengono Domenico Maselli, pastore e parlamentare,
Gianni Long, membro della Commissione consultiva
del Consiglio dei ministri, Dora Bognardi, dell’Unione awentista. Franco Monaco, parlamentare, e Domenico Tomasetto, presidente della Fcei.
Speciale Protestantesimo
domenica 2 novembre 1997, ore 10,05 - Raidue
CULTO DELLA RIFORMA
in diretta eurovisione
dal tempio valdese di Luserna San Giovanni
LA MORTE DI MONSIGNOR
LUIGI DI LIEGRO
«La Federazione delle chiese evangeliche in Italia esprime cristiana simpatia per la scomparsa di monsignor Luigi di Liegro, amico degli ultimi, uomo
di giustizia, cristiano ecumenico». Così
ha scritto alla Caritas di Roma il pastore Domenico Tomasetto, presidente
della Federazione evangelica (Fcei), in
ricordo di Di Liegro, scomparso il 12
ottobre a Milano per una crisi cardiaca, col quale da anni lavorava in stretto
contatto il Servizio rifugiati e migranti
della Fcei. Uomo senza pregiudizi,
aperto verso tutti, convinto sostenitore
della collaborazione ecumenica concreta fra cristiani, appartenenti alle diverse fedi religiose e laici, il direttore
della Caritas romana aveva dato un
forte impulso alla nascita di una rete di
associazioni laiche e religiose per il sostegno delle politiche sociali pubbliche
e per gli interventi a favore dei più indifesi, in particolare dei senza casa e
degli immigrati e rifugiati.
 2
2
PAG. 2 RIFORMA
All’A;
Della Pai
VENERDÌ 24 OTTORPt
.._..........
«La legge
di Dio
è perfetta,
ristora l’anima;
la testimonianza
di Dio
è sicura,
istruisce il
semplice.
I precetti
di Dio
sono giusti,
rallegrano il
cuore; il
comandamento
di Dio
è chiaro,
illumina gli
occhi.
Il timore
di Dio
è puro,
resta per sempre;
i giudizi
di Dio
sono verità,
tutti ben fondati,
più preziosi
dell’oro,
dell’oro più fino;
più dolci del
miele,
di quello
che stilla dai
favi.
Anche il tuo servo
ne riceve luce;
v’è gran
ricompensa
ad osservarli.
Chi conosce
i propri errori?
Purificami
da quelli
che mi sono
nascosti.
Difendi il tuo
servo
dall’orgoglio,
perché non
prevalga
su di me;
allora sarò
integro,
liberato
dalla gravità
dalle
trasgressioni.
Siano gradite
le parole
della mia bocca,
i pensieri
del mio cuore,
davanti a te,
o Dio,
mia difesa,
mio liberatore!»
(Salmo 19,7-14)
LA PAROLA DI DIO
La lode alla legge non è fine a se stessa: è volontà di porre la propria vita
sotto il discepolato di Dio. Ma la sua legge potrà mai diventare la mia leggeì
SERGIO RIBET
UN elogio della legge. Anzi,
una poesia, un inno alla
legge. Difficile pensare a un tema più distante dalla poesia,
per la nostra sensibilità moderna. È difficile anche un elogio
della legge se rischiamo di fame
un discorso politico all’insegna
della «voglia di ordine», se fraintendiamo con il legalismo. Forse davanti ad abusi palesi qualcuno potrebbe invocare una
qualche legalità, forse in mezzo
a tanta «deregulation» si sente a
volte il desiderio di riscrivere le
regole del gioco, ma nel nostro
tempo e nel nostro linguaggio è
difficile trovare particolarmente stimolante l’argomento, sul
piano poetico, sulla lunghezza
d’onda della lode.
La «legge del Signore»
CERTO sarà facile precisare
che la «legge del Signore»
non è quella degli esseri umani,
sarà giusto ricordare che il termine torah dice molto più del
nostro legge. Ma anche se cerchiamo dei sinonimi (e il salmo
abbonda di sinonimi) non ci
troviamo su un terreno particolarmente eccitante: che si dica
precetto, comandamento, giudizio o, come suggeriscono vocabolari e dizionari, prescrizione, istruzione, regola, norma,
dottrina, sentenza, «quel che è
dovuto», non ci spostiamo da
un linguaggio giuridico, o didattico, o morale.
Anche termini più spirituali
con i quali possiamo rendere al
Preghiamo
Non bastano gli errori che faccio e di cui mi rendo
conto, non bastano le meschinità che mi sono proprie
e che mi fanno stare male, non bastano le cmdeltà piccole e grandi che scopro quotidianamente intrecciate
alle mie azioni; mi devi rinfacciare, Dio mio, anche i
miei peccati nascosti?
Non quelli che cerco di nascondere agli altri, per un
po’ di pudore che m’è restato, o di nascondere a me
stesso, per un briciolo di amor proprio, ma proprio gli
errori nascosti a tutti e a me stesso, fuori dalla mia intenzione e dalla sfera della mia coscienza. Anche quelli
vuoi mettere in conto? La tua volontà...! Dio della legge, dei precetti, dei comandamenti, dei giudizi... Dio
giusto! non è troppo per me, per noi? Dammi timore di
Dio, dammi liberazione, fammi sentire il tuo amore.
Fammi scoprire che non mi sei sempre e solo nemico,
ma alleato. Che hai stretto un patto con me. Amen.
cuni dei sinonimi usati nel salmo, quali testimonianza, parola
o timore di Dio non sono i più
appettibili nella ricerca di una
spiritualità per il giorno di oggi.
Eppure l’autore riesce a rendere poesia quel che ci pare così
prosastico. Questa tomh ristora,
istmisce, rallegra, è chiara, è pura, «dura per sempre» (non abbiamo sentito qualcosa di simile
a proposito dell’agape, dell’amore di Dio per noi?), è verità. È
qualcosa di dolce, di piacevole,
che tocca tutti i nostri sensi:
l’anima, la mente, il cuore, gli
occhi (non c’è come un eco del
grande comandamento: «con
tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza...»?).
In realtà quest’inno non è tanto una lode alla legge di Dio ma,
come nota Hilari Raguer, una lode al Dio della legge, dei comandamenti, del patto tra Dio e gli
uomini. L’autore biblico non
vuole nominare il nome di Dio
invano; per non parlare troppo
direttamente di Dio, per scmpolo, per pudore, parla di Dio parlando della sua volontà, potremmo dire della sua preoccupazione, della sua cura per noi. E questa cura di Dio per noi ad essere
cantata, meravigliosa, dolce più
del miele, testimonianza per
noi, comandamenti per noi, giudizi suoi nei nostri riguardi.
L’opera di Dio, tema di lode assai più che di analisi.
L’inno alla legge, così vicino
all’inno all’agape, così vicino al
grande comandamento, osa nominare il nome di Dio, ma nascosto, e al tempo stesso rivelato, nella torah. Sotto quel comandamento è Dio che parla, al
cuore e alla mente dell’uomo. In
questo inno il nome di Dio è
pronunciato sei volte sotto la
«nuvola» della torah.
«Il sacro nome... appare sei
volte, cioè una in meno del numero sacro sette. Bisogna aspettare prima che quest’ultimo
esca» (Hilari Raguer).
stante in origine, molto antico.
Ravasi sintetizza le due parti del
salmo attuale intitolando il
commento a questo salmo
«L’inno al sole e alla torah: i comandamenti di Dio brillano». E,
anche nella seconda parte, non
c’è solo l’inno alla legge: gli ultimi quattro versetti sono altro.
Qui l’autore non utilizza più la
corda della lode, ma quella della
preghiera, della applicazione a
se stesso della lode alla legge di
Dio, della confessione di peccato, dell’abbandono a Dio: «Ed
ecco qua il settimo nome che
mancava, simbolo di perfezione!» (Hilari Raguer).
Non nella poesia, nel canto,
nell’inno, ma nella confessione
di peccato, nella preghiera personale: qui si può chiamare Dio
per nome, invocarlo come roccia e protettore, implorarlo con
la bocca e con il cuore, potremo
dire nel segreto della propria
cameretta.
La lode alla legge non è fine a
se stessa: è volontà di porsi in
accordo con essa, di porre la
propria vita sotto il discepolato
di Dio. Ma la sua legge potrà mai
divenire la mia legge, la sua volontà la mia, la sua mente la mia?
L’autore esamina con severità
e serenità se stesso, la dimensione del peccato umano: il peccato involontario, il peccato nascosto, l’orgoglio proprio ed altrui, matrice di peccati, il peccato mortale, che porta ad uccidere e a perire, e scopre che solo se
Dio purifica il suo servo c’è
scampo da questa dimensione
totalizzante del peccato. Se tu
vuoi, la mia bocca e il mio cuore
possono procedere secondo la
tua parola e la tua mente!
condo il disegno di Dio rivelato
nella legge» (Hilari Raguer).
Non vogliamo cercare necessariamente nell’Antico Testamento una «lode dell’incarnazione», una diretta profezia del
Cristo in ogni pagina, una testimonianza diretta ed esplicita a
Gesù. Ma quale «nome di Dio»,
oltre ai sei, anzi sette, che il salmo pronuncia, potremo pronunciare?' Egli «ristora l’anima;
istruisce il semplice; rallegra il
cuore; illumina gli occhi; resta
per sempre; è verità».
Il «nome di Dio»
La triplice venuta
della Parola nel mondo
. O I è avuta una triplice e
\\ ^
Un inno alla creazione
A questo punto dobbiamo uscire dair«inno alla legge»,
per riscoprire la struttura più
ampia del salmo che lo contiene. La prima parte del salmo,
quella che non abbiamo trascritto, è un inno alla creazione,
probabilmente un inno a sé
crescente venuta della Parola nel mondo: la creazione, la
rivelazione e l’incarnazione»
(Hilari Raguer): il salmo nella
sua interezza canta esplicitamente due tra le opere di Dio
che meritano la lode: l’opera
della creazione (l’inno al sole, al
Dio che illumina come il sole) e
l’opera della rivelazione (Dio che
fa conoscere la sua volontà). Vi è
un parallelismo «tra l’armonia
della creazione e quella di una
vita che trascorre totalmente se
PER la predicazione, si potrebbe proprio partire di
qui. Che cosa sappiamo del «nome di Dio»? Il salmo ci dà una
possibile pedagogia per usare
con prudenza ma senza timore
di questo nome, che può essere
di volta in volta quello di Creatore, quello di «Parola di Dio»,
quello di Gesù, parola che si è
fatta carne. In qualche modo il
salmo contesta alcuni modi tradizionali che abbiamo di «salvare l’ortodossia», penso specialmente, per la mia generazione,
all’ortodossia «barthiana», o
meglio creduta tale, diffidente
verso la religione, verso la teologia naturale, verso la legge.
Verso la religione, perché
l’autore del salmo si presenta
come persona pia, servo di Dio,
e non credo abbiano ragione
quegli esegeti che vedono in lui
un credente che si interroga sul
valore dei sacrifici: egli vuole
dar lode a tutta la legge, a tutta
la volontà di Dio.
Verso la teologia naturale: non
che ogni teologia della creazione
sia teologia naturale, ma la spregiudicatezza con la quale si canta che «i cieli narrano la gloria di
Dio» ci riconduce alla possibilità
che il creato possa essere veduto,
nell’ottica della fede, come parola di Dio, come effetto della parola di Dio che a sua volta può
parlare di Dio. E infine, verso la
Legge. Troppe volte abbiamo
contrapposto Legge ed Evangelo,
sempre a favore di quest’ultimo.
Non c’è la possibilità di vedere la
legge di Dio come una buona
novella, inserita come essa è nel
patto che Dio ci propone?
(Prima di una serie
di quattro meditazioni)
Note
omiletìchi
«Un giorno una p,,j
indica conne «saim”j
settimana» per
riodo il salmo 19
Non si capisce per'^gi’'''
zettare il salmo^pg^
breve
ché separare dalla“¡.tj
parte del salmo i “
versetti che ne so^l
integrante. Propo„
per la lettura almep»'
tera parte che va (JaiL
setto 8 al 15 (numeras ¡Dticar
Tile) o 7-14 (numeras
«Nuova Riveduta»,5 ,¡,}e,all!
1 de
quella che seguo).
Il testo che propo,
un miscuglio di varie'
duzioni: non ho iap
tenza necessaria per
una traduzione nuova'
ho verificato
motivi
spingono 1 vari tradui
seguire una versione^
tosto che un'altra. Se^
i punti maggiormente!
trovarsi. Neiie versioni]
dizionali il v. 7 dice:t
stimonianza di Dio...
sce il semplice». Trovai
vincente e possibile lai
duzione «rende saggi
mente», proposta d,
vasi, che nota, con il
ood, che nel contesti
torah è via via applia
«parti dell'organismoS
logico dell'uomo».
Anche al versetto®
seguito la traduzione]
tuale, che con il testq
soretico (ebraico) pai
«timore di Dio», me|
molti (compreso
contro Arthur Weisei,l|
deia, Brescia, 1984,2
rendono «parola dUi]
correggendo una lette
nell'originale.
Una delle difficoltìt
stuali nel salmo rigai
l'esatta comprensioni
quattro termini ctieif
cano il peccato, neivB
ti 13 e 14. Il Ravasir»
tra qui un «originaltis
boiario del peccatff I
duce «inavvertenifi
cato nascosto, orgi^;
grave peccato». Ili»
vocabolo, che puòB
reso con «orgoglio»,il
dotto dalla XX e dsllìji
con «gli stranieri», ii|*
da alcuni traduttori«'
versione «avversari»;!
essere sostenuta ancia
traduzione «gli orgo|
si», nel senso di «idoli
quindi con riferimenti
peccato dell'idolatria. ¿3 jpjj.
Qui ho preferito!
iettura-interpretazio
forse troppo «ideologi upppn
luteraneggiente (saio ' " o
berato dalla gravitali I eia;
trasgressioni). Mi sta* .
cuore indicare che lai bAssei
razione dal «gravep« ™siès
to», come del resto di ilUnec
gni peccato, sta nellaP icedui
ficazione che viene mjjg g
Dio, dalla giustificazlj ^artieri
ineeun
diact
itelo
d
leféder
idiacc
i'europe
,'incoi
igherii
rico
do,
:d-ovei
lolto dii
in la Re
inl’Ucr;
iorio po’
Ila cap
de c
lai int
ideo. 1
laAss
erazi
’ÌTiial C(
in solo
Ita offe
ineilia
tro c
lesa rii
anche
ipartecip
^one di
vaFeden
toailSp
topea ma
npiofoni
quello eh
viveva dii
IO. Matti
ne remo;
nuradeì
cittadini
piccoli c
quali ap
ilvinisi
lando 1
ibiamo
lUa pie
¡tato c
ir farci
Resta il problema teoi joper]
co di che cosa sia il
------------- ’t iziaso
peccato»: probabiim
nell'Antico Testami ¡,
ciò che separa da Dia
Nuovo Testamento I ,
cato che porta alla i"* i.-uPP
o il peccato contro lo Mll ai
rito Santo (Dio «pui" f^Ma i
rificare da questi pe» ®ntie(
ti?), ma qui entriai”* Snuti i
temi estremamente ri anno ^
plessi, non esplicita"' quilibr
presenti nel salmo. «iques'
tuisco
Per
FSgeva
iciale.
approt
Indicheremo nei
mi numeri altri testi cq
corsi; per questo 1
biamo ampiamente f
zato il testo di
guer. Introduzione^ 1
mi. Boria,
Il commento ai salali
Asocie
falche
«opee
®cora
completo che abbifi^J
italiano è quello oi 1
franco Ravasi, Il 1'^ .,
Salmi, commento e
lizzazione, li
riale dehoniano, Do
1985 (e ristampe
ve), in tre volumi
, suctq
Notizie evange^
agenzia stan^P*
raKhrtnompntO 3^^
 3
3
¡BRE]
24 OTTOBRE 1997
PAG. 3 RIFORMA
tichel
una Pi
«saltilo
fiuesto
°19.10.Ì
perché
Po, p5f
■attutto
J3lla
i Priiiiii
le sono
Propor,
almeno
e va dal
numera,
numera;
duta»,
juo). '
' propoi
di variai
ho la c(
aria per
ae nuov)
i motivi:
ri tradut
Ungheria: Assemblea annua della «Federazione europea per la diaconia»
Dalla parte dei deboli e degli esclusi
 4
4
PAG. 4 RIFORMA
LA
VENERDÌ 24 OTTQBRf ■
312
Un libro prezioso di Mister McGrath tradotto dalla Claudiana
La riscoperta della spiritualità
Per il protestantesimo è importante riappropriarsi dei principi ispiratori
della Riforma in una fase in cui l'ecumenismo rilancia una questione trascurata
GIUSEPPE PLATONE
T T O tutte le ragioni per
«jT.
, pensare che l’attuale
debolezza nella spiritualità
condurrà, neH’evangelismo, a
una ricerca impegnata e prolungata per sopperire a tale
carenza. Nel mondo della spiritualità il protestantesimo è
un gigante assopito: è necessario che si svegli. Se lo farà, il
prossimo millennio potrebbe
recare con sé degli sviluppi
molto interessanti. Siamo debitori al nostro futuro di cominciare subito»*. E in effetti
il contributo di McGrath raccolto nel recente volume edito dalla Claudiana costituisce
un prezioso impulso a muoversi nella direzione di un recupero, una riattualizzazione
dei grandi temi della Riforma
protestante; sola fide, sola
Gratia, sola Scriptura, solus
Aiister .McGiaili
Le radici della
spiritualità protestante
Christus. Lo stile asciutto e
chiaro, caratteristica della
migliore scuola letteraria anglosassone, capace di presentare questioni complesse in
rtiodo comprensibile, facilita
enormemente la lettura che
diventa presto coinvolgente
facendoci progressivamente
scoprire ciò che prima conoscevamo per frammenti: la
spiritualità protestante.
Certo il termine spiritualità
è stato preso a prestito dal
mondo cattolico, noi storicamente preferiamo parlare di
pietà. Ma questo termine evoca assistenzialismo, rimanda con la mente a un pietismo che qui da noi è compreso come moralismo di
bassa lega, associazione di
bacchettoni ipocriti. Sicché
vada pure per questo ulteriore cedimento alla religione di
massa purché ci si capisca.
Del resto, che piaccia o meno, stiamo andando in cam
po ecumenico verso un mix
di spiritualità che ha trovato
il suo più alto momento espressivo nell’Assemblea
ecumenica europea di Graz,
dove protestanti, cattolici e
ortodossi pregavano nei culti
mattutini davanti a un enorme icona della Madonna,
con mille ceri accesi mentre
dal pulpito tuonava un pastore riformato con le belle
facciole inamidate. L’ecumenismo ha comunque rilanciato il tema della spiritualità
nelle singole chiese. Non è
dunque un caso che nella
Culto battesimale in una chiesa battista di Torino
prossima assemblea triennale della Federazione delle
chiese evangeliche in Italia,
che si aprirà a giorni a Torre
Pellice, i delegati troveranno
nella loro cartellina alcuni
numeri di «Rete di liturgia»,
un periodico che vuole collegare le varie esperienze, che
traduce testi, preghiere, confessioni di fede da varie parti
del mondo. La spiritualità è
diventato un argomento che
fa presa. Forse dopo tante
parole, tanto impegno sociale, occorre un po’ di silenzio,
preghiera, ascolto, canto, gesti simbolici.
Nel lento risveglio dal letargo della nostra spiritualità la
riflessione storica e teologica
di McGrath che si raccomanda almeno per due ragioni. La
prima è che finalmente la
materia viene ordinata collegandola con l’identità storica
del protestantesimo in chiave
attualizzante. La seconda è
che il libro è integrato da un
bel capitolo su «La spiritualità
protestante in Italia» di Aldo
Comba, che rende tutto più
vicino e comprensibile. Insomma un libro importante
che ogni membro di chiesa
dovrebbe leggere anche perché può servire da stimolo
per lanciarci, come chiese, in
nuove direzioni di spiritualità
(un po’ di creatività in questo
campo è più che consigliabile) senza perdere di vista
quell’identità protestante che
nella sua sobrietà e ricchezza
teologica costituisce un infinita ricchezza nel panorama
cristiano.
(*) Auster McGrath: Le radici
delia spiritualità protestante, a
cura di Aldo Comba. Torino,
Claudiana, 1997, pp. 272, lire
32.000.
Dio e il dogma in un singolare «romanzo ideologico»
Quando la fede lascia spazio all'intolleranza religiosa
SERGIO RONCHI
VI ricordate in quali guai
andò a cacciarsi lo strano
personaggio (un angelo) della Visita meravigliosa di Herbert George Wells quando
decise di scendere sulla terra
nel tentativo di portarvi un
po’ di ordine morale? Venne
«invitato» a andarsene: si rivelò elemento di disturbo.
Per certi versi, ma con risvolti
drammatici, è quanto si può
leggere in Quel che sanno gli
angeli, di Jill Paton Walsh, in
edizione italiana presso Garzanti*. Liberamente ispirato
alla storia vera della Vergine
di Chalons [Epitre II sur V
Homme di Rousseau), il romanzo vede tutti i protagonisti lottare intorno ai grandi
temi della fede (dalla questione di Dio al libero arbitrio); e l’interpretazione che
essi danno dei dogmi mette a
nudo la loro propria realtà
umana, in continua e irrisolvibile tensione, come si sottolinea nelle parole di presentazione dell’editore, «tra
la tolleranza e la certezza
morale, tra la tenerezza e
l’istinto omicida».
Le vicende si svolgono intorno al 1450 a Grandinsula,
remota terra del Mediterraneo «lontana da tutto, dove la
vita era priva di sorprese o avvenimenti eccezionali». Un
giorno, però, le cose cambiano. Sui monti intorno a Ciudad viene rinvenuta nella
grotta una bambina-lupo,
che il giovane pastore Jaime
sottrae a morte certa per mano dei suoi stessi compagni (è
solo un animale, non un essere umano; quindi, l’omicidio
non sussiste); lungo la spiaggia alcuni pescatori trovano
svenuto un naufrago. Entrambi trasformano radicalmente la vita in quei luoghi.
La bambina-lupo, a cui suc
cessivamente sarà dato il nome di Amara e amministrato
il battesimo, viene affidata alle suore del convento di Santa
Clara; di lei si occuperà la novizia Josefa. L’uomo dichiara
di chiamarsi Palinor e si qualifica come ingegnere, architetto e ateo. Le storie dei due
inaspettati e inopportuni sconosciuti corrono parallele, intrecciandosi narrativamente
senza mai sovrapporsi; i problemi che essi pongono con
la propria specifica presenza
potranno risolversi, alla fine,
solo con la soppressione fisica di uno di loro.
Il prefetto imprigiona quello strano individuo, perché
«un uomo senza religione
potrebbe fare qualsiasi cosa»;
a maggior ragione se proviene da un paese (Aclar) nel
quale la libertà di coscienza
è di casa. Poi la sua pratica
passa a un chierico della cittadina, per finire nelle mani
del cardinale e signore dell’isola, Severo. Il quale protegge la piccola allevata dai
lupi sino a quando, civilizzata, non tornerà per sempre
sui monti per aiutare i pastori; e instaura con il sedicente
principe un colloquio intenso. Severo, tale in tutto, è un
uomo di chiesa che crede e
ragiona cercando di non ridurre le categorie teologiche
a gabbie dogmatiche. Accetta
l’altro: «Trasferite immediatamente il presunto ateo sotto scorta», recita l’ordine
dell’ufficio del concistoro che
sconcerta il prefetto.
Adesso Palinor gode di una
libertà vigilata; va a abitare
nella casa di Severo, dove si
incontra con lui e con un
grande maestro, Beneditx,
così obbligato a interrompere
un importante trattato sugli
angeli. A lui si rivolge il cardinale per consigli. «Il problema è questo; è possibile che
un ateo sia in buona fede? Mi
sembra di capire che conosce
le Sacre Scritture ma le ha rifiutate.» È quanto si deduce
dalla trascrizione dell’interrogatorio da parte del tribunale del concistoro. Per lui «il
vangelo è come uno dei tanti
testi sacri».
Il saggio uomo di studi instaura un dialogo con l’ingenere-architetto privo di fede
e comincia a distinguere tra
non credente (dubbi sull’esistenza di Dio), convertibile, e
ateo (di due specie: o contro
Dio o «Dio non esiste»), costoro a Ciudad vengono messi al rogo. Poi vanno avanti
citando entrambi Tommaso,
Agostino... Palinor è stringente nelle argomentazioni; non
accetta il Dio di Beneditx,
Motore immobile. Essere
sommo e perfetto. Causa non
causata, il Dio della metafisica. Tale è il dio che deve immaginarsi. E fa un tentativo a
occhi chiusi. È inutile. «Vorrei tanto avere un simile potere», esclama Tabitante di
Aclar «cioè quello di far esistere qualcosa semplicemente immaginandolo. Questa è
una prova seria?»
Alla fine Beneditx vede nel
suo interlocutore «un ottimo
motivo per dubitare» e dice:
«Prima di conoscervi pensavo che tutti i non credenti
fossero frivoli. Adesso vedo
che il dubbio può essere
profondo e serio come la fede». Si reca da Severo e alla
domanda di questi «Lo avete
convinto?» risponde, stringendo la testa tra le mani:
«No, lui ha convinto me». Il
protettivo «mantello della fede», che sino a quel momento tutto avvolgeva bene bene,
è ormai lacerato. Severo è
sconvolto. Reagisce con rabbia e consegna Palinor nelle
mani dell’odioso e spregevole inquisitore fra Damaso
Murta, sbarcato nell’isola
perché a Roma era giunta voce sulla presenza di un irriducibile eretico a Ciudad.
Poi, si pente. Troppo tardi,
però: Palinor viene consegnato all’Inquisizione.
Comunque, Severo non demorde, cerca di convincere
Tirriducibile frate: ogni tentativo risulta vano. Secondo
Damaso Murta «la tortura è
l’unico modo per piegare la
volontà di un uomo ostinato». Risponde Severo: «Quella
che chiamate ostinazione è la
condotta di un uomo che segue la sua coscienza, che per
quanto in errore è sempre la
sua coscienza». Per l’uno la
coscienza deve conformarsi
agli insegnamenti della Chiesa; per l’altro, in tal caso la
coscienza vera potrebbe in
realtà rivelarsi accidentalmente falsa.
Interrogato sotto tortura,
Palinor non cede; invoca
però la maledizione divina
sul capo del proprio aguzzino. È quanto basta per far
esultare quest’ultimo di
gioia; «Sia lode a Dio! Vi abbiamo in pugno!». «Non posso salvarvi, adesso che avete
confessato», si rammarica Severo. E Palinor finisce sul rogo. E Beneditx? Invoca Dio
con il salmista; «Signore,
ascolta la mia preghiera». Ma
«dal remoto confine dello
spazio e del tempo, il suo Dio
non riusciva a sentirlo». E Severo? Viene abbandonato dal
suo fido cappellano Rafal,
che gli confessa di non credere più in Dio. Tremando si
sdraia presso l’altare per pregare. Non vi riesce: «Il suo
Dio rifiutò quella tacita preghiera, ma la sua presenza lo
oppresse per tutta la notte e
non voleva andarsene».
cinque fondamenti della Riforma ^2
Sola Gratia
Il pensiero della Riforma
si può riassumere in cinque
frasi, ciascuna delle quali
comincia con la parola latina «solus», declinata in
«sola» o «soli».
ALDO COMBA
PAROLA estremamente
semplice: siamo salvati
per la sola grazia di Dio. Ma
qui naturalmente cominciano le questioni. Grazia,
perdono, cancellare i debiti
(ricordate il Padre Nostro:
«Rimettici i nostri debiti... »)
sono tutte espressioni equivalenti. Ma ci sono due modi di perdonare un debito.
Il primo è di dire: «Il tuo debito non esiste più, io straccio la cambiale». Questo è il
concetto protestante della
grazia; Dio cancella il nostro peccato, Gesù lo ha
preso su di sé, esso non esiste più. Molte persone non
riescono a pensarlo e continuano a vivere come se dovessero «pagare» qualche
cosa. Alcuni addirittura ci si
angosciano psicologicamente. Non dobbiamo pagare proprio niente: siamo
liberi, siamo perdonati, siamo «nuovi» al cento per
cento. Così grande è l’amore di Dio in Cristo.
C’è un altro modo di vedere il perdono, più tradizionale tra i cattoÙci. Certo,
essi dicono, siamo tutti sal
vati per grazia, ma perw
la grazia consiste nel fati!
che Dio, per sua bontà, !■
mette in grado di contribuì,
re a pagare il debito. LacKf!
fetenza è evidente: in
caso Tessere umano coUj,'
bora alla propria sai
le sue «opere buone» soi
necessarie (anche se noi
sùfficienti) perché sia s¿
vato. Nell’altro caso Dio ¡
perdona totalmente, seni
riserve, per pura bontà. Sii
come noi siamo moiri
spesso incapaci di perdo!
nare davvero al nostra
prossimo (pensate alla frj
se ambigua: «Ti perdoni
ma non posso dimentico]
re...»), così ci pare cheDj
non possa perdonarci tot.
mente senza una qualchi
sia pur minima contropar
tita da parte nostra. In(|
modo rendiamo Dio sinj|
a noi, il che significa si
nuirlo assai.
Ma, dirà qualcuno,
«buone opere», la moraliti
il discepolato dove vanno
finire? Se Dio ci salva sei
contropartita che bisogni
c’è di fare il bene? Non e'
nessun bisogno, ness
obbligo, ma c'è la chiamai
di Dio rivolta a noi cob
persone libere e responsi^
bili. A noi di decidere se?
come rispondere al si
amore. La Bibbia ci imita
farlo e ce ne indica anchi
modi possibili.
,glL
kont
PAOI
Studi del Sae a Genova
Ricerche intorno a Abram«
«AVAMC
0l96!
jmilitan
io, tesi,
le lotte ri
intratt
leccai
erava
io Fo e !
jesett
itte d’
ivato 1
a
icacon
iriapres'
ilo che (
iroblei
iultapp'
»tica
laordi
¡ferire
Itàproi
irl del
iraoj
0 Fo !
lensai
jenep
|àa citata
lei pren
ti chi
io è ai
ie è altre
igram
Ito una c
lagosi I
liare la
ÌBdiridi
,tcompr
iitìvazii
lochi
^conpo
Iii.i, Paton Wai.sh: Quel che
sanno gli angeli. Milano, Garzanti, 1997, pp 276, lire 28.000
A cura del gruppo genovese
del Segretariato per le attività
ecumeniche ha avuto inizio
presso il Palazzo ducale il
XVII Incontro interreligioso di
cultura e di formazione al
dialogo, sul tema «Abramo».
Il prof. Daniele Garrone,
docente di Antico Testamento presso la Facoltà valdese
di teologia, ba introdotto
questo ciclo con una conferenza dal titolo «Ur dei Caldei». Dopo avere collegato la
figura di Abramo con il termine Ur dei Caldei, l’oratore
ha affrontato un problema
scottante ponendosi la domanda: Abramo è veramente
esistito? Parecchi sostengono
infatti che non sia una figura
storica ma solo simbolica,
dal momento che nei testi
antichi non se ne parla.
Garrone, per dimostrare la
consistenza storica dell’esistenza di Abramo, ha citato
due passi molto significai
Uno, Nehemia 9, 7: «Tu
l’Eterno, l’Iddio che scegli!
Abramo, lo traesti fuori dai
dei Caldei, e gli desti il noi
Abramo», per dimostri
l’importanza che aveva qi
sto avvenimento per i posi
di Abramo; l’altro, Isaia 51
«Considerate Abramo vosi
padre, e Sara che vi parton;
lo chiamai, quand’egli era
lo, lo benedissi e lo moltipl
cai», a considerazione del
to che Abramo era un rii
mento consistente per gli
mini di tutti i tempi.
Garrone ha concluso
mando che Abramo,
roe, molto umano, ha ricff
to una chiamata e una
messa di dimensioni univi
salistiche, e come personi
gio contraddittorio ès
chiamato fuori da Ur dei
dei per raggiungere la tei»
Canaan.
natuigo e
khaasiut
micouilpc
ni),maanc
cialis^iù
Questadi
le cause eh
Icufliuom
làecr
itivame
idemii
sonò
strett:
¡ciare
gnosa.
pazio!
aio rilie
^0, cons
antil
co pi
Ques
'ile me
cl
ichi. P(
leites
lento
pii
stai
m
lapi
JUGI
I disegni di Umberto Stagnaro
Bonhoeffer e il nazismo
L’editrice Claudiana ha
pubblicato in veste autonoma Dietrich Bonhoeffer. Un
cristiano contro il nazismo,
tavole a fumetti realizzate da
Umberto Stagnaro e uscite
per la prima volta con inserto
di Riforma. La nuova veste
(22 pagine di tavole, con copertina a colori, £ 8.000)
comprende anche una cronologia del pastore e teologo
tedesco e un’introduzione
curata dal pastore Fulvio Terrario che colloca la sua figura
nel quadro della Germania
nazista e dell’atteggiamento
delle chiese tedesche in quel
periodo. Chiude il fascicolo la
Dichiarazione teologica di
Barmen, che nel maggio 1934
divenne un vero e proprio
manifesto dell’opposizione
evangelica al nazismo. Stagnaro, con il suo tratto, coniuga il racconto drammati
co degli eventi alla
dità e radicalità delle moti
zioni che spinsero
Bìm
fer all’opposizione a ^
prendendosene le respoj’*
bilità fino alTincarcerazi
e alla morte.
Ili ini
I^Per
Dietrich Bonhqe
ON CKXSTXAtK> CtMTBO Xt>
Vi«'
 5
5
ì 24 OTTOBRE 1997
PAG. 5 RIFORMA
Jerlotu
fatto
>ntà,ci
ntribÿ.
■ Udif.
in m
n colla.,
tlvez^
e» sono'
se noni
sia sali
A Dario Fo il Premio Nobel per la letteratura
La coerenza della ribellione
Ili «giullare» che ha sempre difeso la dignità dellhndividuo
¡contro i meccanismi repressivi di ogni forma di potere
PAOLO FABBRI
sei
ità.Si(
molli
perdi
nostri
allaftaì
erdoHi
enticì
che Dii
citotl
inaici^
rtropi
a. In
0 simi
ca si
uno,
lorallt!
vanno j]
rasei
aiso^i
Non ci
nessi
hiamat
)i coni
spensi
ere seej
al SI
invita,
anche!
m
unificati
7: «lui
: sce^ii
uori '
Iti il noi
mostri
veva qi
ir i posti
Isaia 51j
tuo vosi
parton;
igli era
) moltipi
ne del
un rifa
per gli
luso affi
IO, antii
ha ricci
una pi®
ÌbaVAMO nell’ormai lon*‘¿01969. Una cinquantifliilitanti del Movimento
lio, tesi, eccitati e stanchi
’le lotte relative al rinnovo
contratto nazionale dei
oeccanici nell’autunno
eravamo ad aspettare
loFo e Franca Rame in
Jesetta sconsacrata di
lette d’Ivrea (l’unico lobato libero). Dario non
a arrivare e arrivò
icacon un gruppetto di
presentarci uno spetjo'che entrava nel vivo
oblematica politica aitappeto. Fu una serata
lenticabile per la capajaordinaria degli attori
iferire sul palcoscenico
Ità proiettata in uno spari del tempo, dove rejcoraoggi.
& Fo lo vidi in seguito,
insando ad allora camene perché Franca Rasiacitata nella motivaziolel premio e suo marito
i chiaramente che il
lío è anche di lei. Così
le è altrettanto chiaro che
logramma marxista ha
Ito una divisione nella soità'^osì profonda da an]l)i¿e la mente di chi non
individeva, impedendo(li comprendere le profonÌÉtivazioni ideali che guiivano chi lo accettava, macón posizioni di grande
ìiertà critica, come il dram»aturgo e attore varesino,
diehaayuto scontri durissiàconilpotere democristiano, ma àidie con quello socíaiisíaíi'Éraxi e con il Pd.
Questa divisione è una dellecause che hanno indotto
Icufliuomini politici, intellali e critici a considerare
itivamente la scelta delidemia svedese, mentre
i sono complimentati a
Stretti senza trattenersi
dare qualche frecciata
®osa. Diverse sono le
trazioni dei critici che
lO rilievo soprattutto al
tu, considerato in Dario
wo più di un canovacQuesto aspetto della
'Ile merita un approfonnto che ci auguriamo si
ichi. Per parte mia ritenni testi contengano due
elementi originali sufficienti
a giustificare il premio, al di
là delle straordinarie interpretazioni personali dell’autore e di sua moglie.
Il primo consiste nell’aver
individuato nel Medio Evo e
nei giorni nostri una vasta
gamma di soprusi del potere
costituito sugli umili, i deboli,
gli emarginati, facendone una
grande metafora della lotta
condotta in ogni tempo dal
povero (il «poer nano») contro il potente che vuol diventare sempre più ricco e calpesta tutto, amore, umanità, fede, onestà, legalità. C’è nei testi di Dario Fo una tensione
etica, un rispetto per l’uomo,
per la sua libertà, per la sua
dignità, che sono spiegati da
un legame profondo con la
Bibbia e con il suo messaggio.
Il secondo elemento consiste nella sua ricerca di un linguaggio autenticamente legato alla tradizione popolare
italiana nei secoli. L'accostamento di diversi dialetti nel
Mistero buffo dà luogo a un
insieme che diventa espressione linguistica del tutto originale. Ricordo un operaio
piemontese dalla vivace mimica, che parlava con un catalano intendendosi benissimo con lui che rispondeva
nella propria lingua. Dario Fo
ha portato tutto questo nei
suoi testi ottenendo un risultato analogo. A questi due caratteri della sua opera si deve, io credo, l’enorme successo dei suoi lavori all’estero,
che non va attribuito solo alla
grande tradizione della commedia dell’arte.
Certamente al successo del
teatro di Fo in gran parte del
mondo, fino a farlo diventare
il drammaturgo italiano più
rappresentato nel mondo, ha
contribuito la possibilità di
utilizzare le videocassette degli spettacoli italiani; d’altra
parte viviamo nell’era della
comunicazione e le cassette
finiscono per diventare parte
integrante del testo, insieme
con le note di scena. Il premio va anche all’uomo: ma
quando mai con il Nobel non
è stato così? Dario Fo è stato
coerente con il suo teatro
non lasciandosi asservire da
nessun tipo di potere. I risultati sono stati la censura della
Rai nel 1962 e circa 40 processi. Chi ha talento e rinuncia a soldi e carriera per le
sue idee capirà che cosa significa questo atteggiamento. Il Nobel a Fo non significa
che nella grande tradizione
letteraria italiana non ci siano altri scrittori altrettanto o
più meritevoli, significa però
sicuramente che uno di loro
si è fatto intendere meglio.
SCHEDA
Le tappe dì una carriera
Dario Fo è nato a Valtravaglia (Varese) nel 1926. Si è diplomato all’Accademia di Brera e ha compiuto studi di Architettura. È sposato dal 1954 con Franca Rame e ha un figlio, Jacopo, nato nel 1955.
Inizia l’attività nei primi Anni 50 con una parte in una rivista delle sorelle Nava, poi in Rai con la serie Poer nano,
infine con Franco Parenti e Giustino Durano nella rivista
Un dito nell’occhio.
Debutta come autore nel 1954 con le commedie Ci ragiono e canto e Gli arcangeli non giocano a flipper. In tutto
scrive 47 commedie, fra cui Chi ruba un piede è fortunato
in amore, Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri.
Morte accidentale di un anarchico (riferita alla morte inspiegata di Giuseppe Pinelli precipitato da una stanza della
questura di Milano nel corso delle indagini sulla bomba di
piazza Fontana del dicembre 1969), Ma scusa non è quello
il padrone?. Il Fanfani rapito. Mistero buffo, Johan Padan e
la scoperta delle Americhe, Non si paga, non si paga. Coppia
aperta. Manuale minimo dell’attore. Ha firmato 80 regie e
composto una sessantina di canzoni.
Lo spettacolo in scena in questi giorni a Milano
Se il diavolo riesce a infiltrarsi
in una città preda della corruzione
La presentazione in anteprima a Messina, lo scorso
agosto, dell’ultimo lavoro di
Dario Fo aveva suscitato un
certo scalpore, essendovi stato ravvisato più di un riferimento alla Milano di «Mani
pulite», con un giudice incorruttibile al di là di tutti i tentativi che richiamava Di Pietro e una città corrotta dove
gli appalti sono truccati a
vantaggio di tutti i potenti,
compresa la Chiesa. Una satira con un Giorgio Albertazzi
interprete maschile ad accrescere la sorpresa, viste le sue
posizioni di destra. La vicenda si svolge in una città italiana alla fine del ’500.1 personaggi principali sono un giudice (Albertazzi), la sua serva
Pizzocca (Franca Rame), un
cardinale, un capitano delle
guardie, diavoli, avvocati,
sbirri, ecc. Qualcuno brucia
una chiesa e al giudice tocca
di trovare il colpevole.
Un’accurata indagine sullo
sterco (metafora della sporcizia morale della città) lasciato dalle bestie da tiro sulla
strada conduce a un ladro,
che ha rubato dalla chiesa
una statua di San Giorgio. Si
avanza l’ipotesi che l’incendio sia stato appiccato per distogliere l’attenzione dal furto ma il giudice ritiene invece
che il furto sia stato commissionato per far cadere i sospetti dell’incendio sul ladro,
mentre l’obiettivo vero era
proprio l’incendio, al fine di
favorire l’attività della potente corporazione dei costruttori sostenuti dalla curia locale. Con qualche pressione
psicologica il giudice induce
il ladrone a confessare che è
stato pagato per il furto da un
misterioso cavaliere, rintracciati, in base alla descrizione,
in casa di un capitano delle
guardie, che si dava per morto nell’incendio in quanto
sorpreso dalle fiamme, mentre in realtà amoreggiava con
la sua bella.
A questo punto si fa avanti
un personaggio graziato dal
duca per avere ammesso le
sue colpe, rendendosi disponibile a denunciare i complici; un moderno pentito che
però in tribunale ritratta tutto perché minacciato, facendo perdere di valore alla sua
deposizione precedente (vedi
diatriba sull’art. 513). Il giudice però ha mosso troppo le
Un momento di «Mistero buffo»
acque e, apparentemente per
errore, durante una manifestazione popolare di operai
tessili guidata da un frate
amico del magistrato, i cannoni gli sparano addosso
senza però colpirlo. Ormai le
acque sono diventate tumultuose e si fa avanti una donna misteriosa per fare importanti comunicazioni al giudice. Si tratta dell’amante del
capitano che però risulta essere stata avvelenata e viene
salvata in extremis da un intervento della Pizzocca, sempre intrigante negli affari del
padrone.
Trova a questo punto pratica attuazione un piano concertato da una congrega di
diavoli, uno dei quali opportunamente ridotto deve entrare nel giudice attraverso il
deretano, per costringerlo ad
abbandonare il suo rigore
morale. Se non che, assente il
padrone, la Pizzocca si corica
a riposare nel suo letto e il
diavolo entra in lei anziché
nel padrone. Sbalordimento
del diavolo, che si trova in un
corpo femminile con tutte le
pulsioni che ne derivano;
sbalordimento della Pizzocca, che si trova a avere un
paio di «zinne» di tutto rispetto e cambiamento del
«piano», nel senso che la corruzione dovrà verificarsi tramite il corpo avvenente della
donna. Intanto il giudice,
ignaro di tutto, procede in
tribunale, esibendo con un
coup de théâtre il capitano redivivo, rintracciato a casa
dell’amante. Con questo testimone il tribunale si avvia a
condannare i maggiorenti
della città ma, approfittando
di un momento di confusione, questi cerca di fuggire e
una guardia lo uccide. Rovesciamento della situazione
con il giudice messo sotto
accusa, intervento del «grande inquisitore» per condannarlo. Interviene però la Pizzocca che dichiara di essere
stata pagata per testimoniare
contro il giudice, assolto ma
con apertura di una nuova
indagine. Il demonio lascia la
Pizzocca e viene accusato di
essere un traditore. Scena finale con il giudice che rema
incatenato su una galera,
mentre su una piccola barca
la Pizzocca lo insegue chiamandolo disperatamente per
nome (si erano innamorati
Luna dell’altro).
Il testo, con i suoi riferimenti storici (è vero che si
incendiavano le chiese per
fabbricare altri edifici) è un
testo colto, che ha forti punti
di contatto con Mistero
buffo, tra cui l’uso di più dialetti italiani, mescolati al volgare del ’500. Gli spunti satirici di eccellente qualità sono
molti e a tratti fa capolino la
fantasiosa genialità dell’autore. Nel suo complesso però
manca la continua, frizzante,
esplosiva comicità di Mistero
buffo e lo spettacolo rallenta
eccessivamente in lunghe
scene troppo statiche. Resta
comunque l’impressione che
il testo abbia in sé delle potenzialità inespresse. Vivacissima ed efficace la recitazione di Franca Rame, pur nella
difficoltà di due ruoli molto
diversi derivati dalla «trasformazione» del personaggio.
Professionalmente ineccepibile l’interpretazione di Albertazzi, che però non pare
adatto a ruoli da comico. Ottime le scene disegnate dallo
stesso Fo. (p.f.)
Ljuoenio stretti
le ntott
Bonhoi
; a biffi
responi
■cerazio'
Un volume in cui vari autorevoli studiosi forniscono contributi interdisciplinari allo studio del problema
«ipporti fra Gesù e il movimento di Qumran nelle ultime indagini sui manoscritti
Et deserto della Giudea
nel 1947, poco prima che
,®se fondato lo Stato di
be, un giovane pastore
e scoprì per caso in una
fnii „ w'^^^^ntica a ovest del
^ alcuni antichi
®®eritti. Da allora, sotto
Pulso iniziale di padre
u de Vaux, 1 manoscritti
e gli oggetti ad
jjOilegati vennero rinve. n undici grotte situate
essi di alcune rovine vi
® di insediamenti uma
.evi.
dalla seconda
W a.C. vissero
. 'luoghi sacerdoti e
-^stretti
1 a vivere nel de
eli;
. . 0nn"*ttnità nel 68 d.C
•Uè
^Purché esiliati dal Teme^salemme; dati ar
'ticn u ® '■acconto dello
®breo Giusenne Fla
au„ Giuseppe FlaL stano la distruzione
della X legione
' romano.
ffeflt’*' Stana ^ ®^"za dubbio la
iL lite., de scoperta archeoF t quanto concerne
gli studi biblici. Le edizioni
Piemme offrono al pubblico
colto italiano un interessante
volume collettaneo* ad opera
di specialisti di fama internazionale che fa il punto della
situazione per i supposti contatti tra Gesù e il suo movimento e la comunità di Qumran. Il curatore del volume è
il professor James H. Charlesworth, docente di Nuovo
Testamento e direttore del
«Dead Sea Scrolls Project»
della Facoltà evangelica di
teologia di Princeton (Usa).
L’opera ha carattere interdisciplinare e ecumeitico; vi
collaborano docenti di antropologia culturale, di lingue
semitiche, storia antica, storia delle religioni, appartenenti a tre differenti confessioni, ebraica, cattolica ed
evangelica.
Quali sono le analogie e le
differenze tra il movimento
di Qumran raccolto intorno a
una figura carismatica denominata «Maestro di Giustizia» e il movimento sorto dalla predicazione di Gesù di
Nazareth? È importante co
glierle per situare il messaggio di Gesù nel suo background ebraico e nella sua
originalità (ebraica) messianica. La comunità di Qumran, gli autori dei manoscritti del Mar Morto, appartenevano a un vasto e influente
gruppo diffuso in tutta la
Giudea al tempo di Gesù. Gli
Esseni (probabilmente dall’
aramaico hasyya, i pii) ammontavano a circa 4.000 persone. i più rigidi, circa 200,
vivevano a Qumran. Gesù nel
suo ministero itinerante può
avere incontrato gli esseni, e
questo spiegherebbe le somiglianze tra i due movimenti.
In comune Gesù e gli esseni
avevano il territorio, si battevano contro gli avversari comuni, in particolare i sadducei e l’aristocrazia sacerdotale di Gerusalemme, erano
animati dalla profonda convinzione che Dio stava per
dare compimento alle proprie promesse profetiche, ed
erano quindi orientati in senso apocalittico ed escatologico. L’uno e gli altri vennero
uccisi dai soldati romani.
Ma le differenze tra i due
movimenti sono altrettanto
evidenti. In primo luogo occorre rilevare il carattere
aperto del gruppo raccolto da
Gesù: il suo messaggio era
pubblico, gli insegnamenti
degli esseni erano segreti. Nel
suo ministero itinerante Gesù
fraternizzava, gli esseni vivevano a Qumran in una comunità chiusa. L’amore per i nemici (Mt. 5, 44), il quotidiano
incontro con emarginati e
malati contraddistingueva
l’opera di Gesù che aveva costituito una comunità aperta,
senza alcuna discriminazione
di tipo rituale. Infatti la differenza principale tra Gesù e gli
esseni era costituita dall’interpretazione della Torah. Alla libera interpretazione di
Gesù, la comunità di Qumran
opponeva le Regole e gli Statuti aggiunti alla Torah. Gesù,
a differenza di Qumran e dei
fondamentalisti contemporanei, non ha mai letto le Scritture in modo letterale. La sua
originale interpretazione del
«vero tempio» lo distinse da
Qumran: «A Gesù non inte
ressavano le misure corrette
dei cortili del Tempio, egli
non si lamentò mai dell’impurità rituale dei sacerdoti,
perché nella prospettiva del
Regno che viene la purità del
cuore era quella (decisiva»
(Otto Bez, «Gesù e il rotolo del
Tempio», pp. 127-128). Gesù
poteva interpretare liberamente le Scritture perché
«Egli sentiva di essere Figlio
di Dio» (Paolo Sacchi, p. 159).
La conclusione non poteva
essere differente: «Il Maestro
di Giustizia lasciò Gerusalemme e il Tempio, ritirandosi nella quiete sicura del deserto. Sulle sponde desertiche del Mar Morto egli si
sentì insignito da Dio del
compito di giardiniere della
piantagione eterna (Ezechiele 19, 10-14). Gesù si recò coraggiosamente nel cuore
dell’opposizione contro di
lui. Fidando di essere Figlio
di Dio, egli orientò il suo
cammino, la sua via, verso
Gerusalemme e il tempio.
Probabilmente fu influenzato
dall’allegoria di Isaia della vigna del Signore (Isaia 5, 1-7)»
(James H. Charlesworth, «Gesù come Figlio e come Maestro di Giustizia», pag. 196).
Sono dunque falliti i tentativi
di riportare in auge la tesi di
Ernest Renan, autore di una
celebre vita di Gesù (1863),
secondo il quale il cristianesimo è un movimento sviluppatosi all’interno delTessenismo e sopravvissuto a esso.
La ricerca dei manoscritti
del Mar Morto dimostra i collegamenti tra i due movimenti, indispensabili per comprendere l’ebreo Gesù nella
sua umanità e nelToriginalità
del messaggio profetico.
(’) James H. Cuari.esworth (a
cura di); Gesù e la comunità di
Qumran. Casale Monferrato,
Piemme, 1997, pp. 382, £ 48.000.
Hai fatto
rabbonamento
 6
6
PAG. 6 RIFORMA
________________________VENERDÌ 24 OTTQRr^:
intenti
Si è tenuto a Napoli il 7 e 8 ottobre un forum internazionale organizzato dalla «Tavola della pace>
Il terzo settore e l'economia popolare nel Nord e nel Sud del moni
Un ricco scambio di informazioni e riflessioni sulle varie forme di autorganizzazione economica, iniziative locali, nuo^j
modi di organizzare la produzione, il consumo, la finanza e contribuire così a costruire un'economia della solidarietà
Mani tese: agire locale in una rete globale
L’intervento di Sabina Siniscalchi ha evidenziato l’importanza del lavoro politico
delle Ong, come movimento
trasversale a tutti i paesi, per
contrastare i devastanti effetti della globalizzazione e contribuire a scongiurare le fosche previsioni di tendenza
come quelle esposte recentemente da Ralf Dahrendorf in
questi termini: «Forse la conseguenza più seria del diffondersi delle convinzioni che
accompagnano i nuovi imperativi della flessibilità, della
competitività e della redditività è la distruzione dei servizi e degli spazi pubblici, senza i quali difficilmente la società civile riuscirà ad organizzarsi. Anche se molte persone soffrono lo stesso destino, non esiste una spiegazione unica e unificante della loro sofferenza e un nemico
comune da combattere. Cosa
ancora più grave, gli esclusi e
quelli che rischiano di cadere
nell’esclusione non rappresentano una nuova forza produttiva utile alla crescita: i
ricchi possono diventare ricchi anche senza di loro, i governi possono essere rieletti
anche senza i loro voti».
Dopo aver messo in evidenza gli sfilacciamenti dei
legami tra il sistema economico e finanziario e quello
politico-sociale, come ha mostrato il caso eclatante della
reazione negativa della borsa
di New York all’annuncio della diminuzione della disoccupazione negli Usa, e dopo
aver commentato alcune impressionanti cifre dell’ineguaglianza (si spendono oggi più
soldi per giocare a golf che
per curare i bambini in stato
di bisogno). Siniscalchi ha
proseguito commentando
una recente indagine condotta in Europa secondo la quale
la gente comune percepisce
l’importanza dell’interdipendenza, vorrebbe più informazioni sulle politiche della cooperazione e un incremento
dell’aiuto economico ai paesi
in via di sviluppo.
Da questo dato positivo
prosegue offrendo la sua lettura degli eventi e la sua proposta: «Le chiavi del cambiamento, i cunei con i quali
possiamo incrinare questo si
...
Sabina Siniscalchi
sterna sono due: l’azione locale e quella globale. Ma attenzione, non ci possiamo
permettere di separarle. Oggi
essere un gruppo di solidarietà che si occupa di un problema preciso nel proprio
territorio, senza avere la coscienza della dimensione globale di quel problema, può
essere perdente. Se mi occupo dei disabili nel mio quartiere dovrò per forza fare i
conti con lo smantellamento
dello stato sociale, imposta
dalla dottrina del liberismo e
della competitività. Se finanzio una piccola azienda di
trasformazione in Brasile, dovrò scontrarmi con le multinazionali dell’agro-industria
che riescono ad invadere il
mercato con il loro prodotto,
magari di qualità inferiore,
ma di prezzo più accessibile.
Sarò in grado di incidere su
problemi globali come la
scelta di molte imprese di
spostare la loro produzione,
alla ricerca di costi più bassi e
maggiori agevolazioni, non
solo se farò pressione sul mio
governo, ma se mi alleerò con
i lavoratori di quei paesi dove
queste imprese operano
spesso in violazione dei diritti
sindacali e della tutela ambientale. (...)
Questo principio è stato
ben compreso dal sindacato
dei tessili americano che assieme a varie Ong e gruppi religiosi ha promosso una campagna contro la catena di abbigliamento «The gap». La catena americana realizzava,
tramite subappalti, la sua produzione nel Salvador, trattando in modo vergognoso le
giovani operaie: meno di 60
cent di dollaro l’ora per un
orario che arrivava a toccare
le 70 ore settimanali. (...) La
minaccia di boicottaggio dei
prodotti, distribuiti sul mercato americano, ha ottenuto
che l’impresa redigesse un codice di condotta per gli appaltatori, permettendo ad osservatori indipendenti di controllarne l’applicazione. Una
campagna che si ispira agli
stessi criteri denominata
«Clean cloth» (panni puliti) è
stata avviata anche in Europa.
«Mani Tese», raccogliendo
la richiesta di alcuni partner
indiani, ha scelto di promuovere una campagna contro il
lavoro minorile sta cercando
l’alleanza dei sindacati e sta
studiando una legge di iniziativa popolare per ottenere
meccanismi di controllo delle
imprese italiane che operano
all’estero. La vicenda della
Con il tìtolo «Il terzo settore e l'economia popolare: le alternative al mercato nel Nord e nel Sud del mondo» si è svolto a Napoli ìl7 e 8 ottobre uno dei Forum internazionali organizzati dalla «Tavola della pace» (un coordinamento da
varie associazioni del settore) quale contesto di riflessione in
vista della marcia Perugia-Assisi che ha avuto luogo il 12 ottobre sul tema generale «Per un’economia di giustìzia». Il seminario, che si è svolto nella sala Maria Cristina del convento di Santa Chiara, con l’apporto di 23 esperti, ricercatori e
operatori sociali, ha offerto un ventaglio di riflessioni e di
esperienze nel campo delle attività non proflt del terzo settore nei paesi del Nord e di economia popolare nel Sud del
mondo. L’obiettivo dichiarato del Forum era favorire lo
scambio fra varie forme di autorganizzazione economica, di
iniziative locali, nuovi modi di organizzare la produzione, il
consumo, la finanza e contribuire così a costruire un’economia della solidarietà sottratta almeno in parte alle logiche
di mercato. Fra i contributi al Forum abbiamo scelto di offrire, quale esempio di lavoro e riflessione di una Organizzazione non governativa (Ong) italiana per la cooperazione
internazionale, una sintesi dell’intervento di Sabina Siniscalchi di «Mani Tese», parlare brevemente del Movimento
brasiliano dei «Senza terra». Abbiamo rivolto poi alcune domande a Guido Celentano, del comitato promotore locale.
Chicco, committente dei giocattoli prodotti dalla fabbrica
thailandese dove un incendio
ha provocato il ferimento e la
morte di decine di giovani
operaie, getta una pesante
ombra anche sulle nostre imprese. Sappiamo che soprattutto le produzioni di giocattoli, tessili, scarpe e abbigliamento sportivo, commissionate a piccole e medie aziende del Sud-Est asiatico o
dell’America Latina, sono fortemente sospette. Bisogna attivare di concerto con Ong e
sindacati del Sud sistemi di
monitoraggio che impongano
il rispetto delle convenzioni
dell’Organizzazione internazionale del lavoro.(...)
Infine possiamo registrare
il successo della campagna
contro le mine: il Parlamento,
in luglio, ha votato a favore
del bando totale e il nostro
governo ha tenuto una posizione coerente alla recente
conferenza di Oslo, la cui dichiarazione finale, passata
purtroppo con il voto contra
rio degli Usa (che si è sommato alla significativa assenza di Russia e Cina), chiede il
bando della produzione, della
vendita e dell’esportazione di
questi micidiali ordigni.
Gli esempi di azioni politiche concrete sono davvero
molti, ma molto ancora resta
da fare: piccole azioni di resistenza portate avanti nei paesi in via di sviluppo da movimenti di base e associazioni
popolari che subiscono in
prima persona la violazione
dei propri diritti possono essere amplificate e avere maggiori speranze di successo se
Ong di altri paesi e reti di Ong
le sostengono. Ritengo che
questo sia uno dei compiti
principali che ci attende nel
prossimo futuro: in un mondo globalizzato dobbiamo
reagire in modo sempre più
globale, solo così potremo
trovare il coraggio di affrontare un fenomeno che, come
dice Darendhorf, «rischia di
erodere la nostra forza e annientare i nostri valori».
Il terzo settore a Napoli può essere un'occasione per creare posti di lavoro
ANNA MAFFEI
Guido Celentano è presidente della cooperativa
«‘O Pappece», che gestisce a
Napoli la bottega per il commercio equo e solidale ed è
stato uno dei promotori del
Forum. Come nasce l’idea di
organizzare il forum a Napoli?
«Abbiamo colto un’opportunità che ci veniva offerta
dalla scelta tematica proposta per la marcia Perugia-Assisi pensando di riproporla
sul circuito cittadino che è
tradizionalmente molto len
to e disattento rispetto a
queste problematiche. Questi temi sono invece cruciali
e attuali e anche legati a
un’esigenza molto napoletana di riuscire a ricollegare le
esperienze terzo-settoriale
anche in un ambito che crei
lavoro. È importante infatti
che il lavoro nel terzo settore
si distacchi da questo fortissimo senso di attesa che il
welfare di stato si dismetta
sempre di più, e sia capace
invece di proporsi sul mercato privato dei servizi culturali, dei servizi alla persona con
un atteggiamento di iniziativa imprenditoriale che possa
essere senza rete. Senza rete
però si vive solo se c’è un circuito, se c’è un raccordo tra
questi gruppi, movimenti,
associazioni. Questo a Napoli è molto difficile. Volevamo
con queste presenze nazionali e internazionali far riflettere su quanto può essere
fatto in questi contesti senza
mendicare dallo stato quello
che lo stato non può più curare in prima persona».
- È questa l’esperienza della
bottega...
Napoli: un momento dei lavori del Forum
«La bottega ha questo tipo
di attenzione in quanto, facendo commercio equo e solidale, si propone di rendere
migliori le opportunità di lavoro per artigiani, contadini e
quanti sono nostri partner
commerciali nei paesi terzomondiali, e al tempo stesso
appoggiare il loro lavoro attraverso persone che anche
qui da noi lavorano. È questo
lo scambio del commercio
equosolidale: non un’ennesima attestazione di solidarietà
lontana ma una compresenza sullo stesso circuito lavorativo delle persone più disagiate e di quelli che tra noi
vogliono su questo tipo di
impegno marcare una presenza continuativa».
- Un bilancio sulla partecipazione?
«Nella prima giornata c’è
stata una presenza di circa
60 persone: molto meglio di
quanto ci si aspettava. Purtroppo mancano gli studenti,
mentre era auspicabile che
l’Istituto universitario orientale e la facoltà di Economia
e commercio, che hanno collaborato all’organizzazione
dell’evento, potessero testimoniare un’attenzione maggiore. Grande interesse invece c’è stato da parte di quanti
operano in questo settore
anche se, a mio giudizio, sono state spesso presenze di
rappresentanza più che di
ascolto...».
- Pacifismo dunque oggi?
«Sicuramente è un pacifismo molto zoppicante, an
che se non parlerei, come
fanno alcuni, di riciclaggio
del pacifismo nella solidarietà. Per me il pacifismo che
affronta oggi le problematiche della giustizia testimonia
di una continuità di impegno. Questo tipo di riflessione tra l’altro accosta in maniera molto opportuna la
motivazione etica che sottende al pacifismo di matrice
cattolica ad un’altra che invece tradisce nell’attenzione
al filone economico e all’impegno sociale una matrice
marxista o comunque dei
partiti della sinistra. Le esperienze che sono testimoniate
in questo forum presentano
elementi di fusione tra queste due matrici e di questo
sono molto contento. Nel lavoro concreto abbiamo ricevuto appoggio e fattivo aiuto
dai francescani, anche se il
grosso è stato fatto da cinque
persone. Fra le istituzioni per
lo più assenti c’è da segnalare l’attenzione della sola Provincia di Napoli che in tempi
abbastanza solleciti ha finanziato una parte dell’organizzazione del forum».
Economia
informale
in Brasile
MARTA D’AURIA
NELL’AMBITO delFo,
internazionale è int»
nuto Luis Antonio Pasq|
in rappresentanza del «li,
mento senza terra» (Mst)¡
la relazione dal titolo
nomia informale e agrior
ra in Brasile». Il Movimi
dei lavoratori rurali senza]
ra nasce alla fine degli
70 dalle lotte per la conqii
della terra che singoli gm
di lavoratori rurali attuati
nella regione meridionale!
Brasile. In dodici anni
stenza, quasi 140.000 fai
glie hanno conquistatola]
ra. Gran parte degli insi
si organizza in cooperatii
produzione, che già coni
55 associati alle centrali li
te alla Confederazione
cooperative di riforma
ria del Brasile (Concrab),
«L’aumento del redJij
delle famiglie insediate-!
detto Pasquetti - è ormai
realtà in molti insediami
soprattutto dove sono
le agro-industrie. Alcuni)
cerche della Eao hanno
provato che, in media, ilii
dito negli insediamenti «ji
vale a 3,7 salari minimim
sili per famiglia. Dove ai
no agro-industrie taleii
sale a 5,6 salari menltf
famiglia. Il settore delicazione è uno dei più;
e va oltre la semplice
rizzazione. In campagiij
40% delle persone è ani
beta e il Mst ha approvato)
programma di educazioi
alfabetizzazione della pi
lezione: più di 38.000 sttil
ti e circa 1.500 insegnatisi mele ì
di Psic
di Sali
10. So
te, in
direttamente coinvolti
questo progetto,
anche dall’Unicef. Le eoo
rative dei senza terra hai
raggiunto delle importi pej,to
conquiste: il 40% della]* ¡^gnd
duzione dei semi di ortagl
Brasile sono prodotti daisi
za terra; la nostra uniti
congelamento del lattep
duce 17.000 litri di laW
giorno commercializzai
mercato; abbiamo vani
sperienze di piccole
dustrie che determiano*
luppo locale, lavoro e sOf
dio. Siamo convinti chel*
nomia popolare, la coop|
zione agricola e l’ain®'
straziane di queste pi'
imprese deve essere so» ma è
controllo dei lavoratori*'
contadini che partecipai'*
fettivamente alla gest^
gli investimenti. (•
mo
bisogno di unire loJ| anche
per opporci a quel mo
organizzativo che g»“
esclusione sociale P®'
struire invece un altro tip
economia: un’econom^
ecUIlUilllct. Ull . '-uà
giustizia basata sul r^sp
dell’essere umano e
mercato e il guadagno’
queste piccole imprc®
fili
razien;
Ferraci
toin q
.■frimai
|3razia
(ria de
«E. Aj
iati p
l’ambi
zazion
fflariat
da qua
sti era
.diatria
della ]
ini;
Il de
con
iuenn;
Vello
fediai
?iend;
ecRegi
I Ahi
no, ol
® lgi(
Sponi
fìià ri
nella
tìinic
diadi
;li nei:
..'nia;
zioni tra il Nord e il Ce:
mondo con l’obiettivo ^^^cerch
Sulle
siamo costruire
struire una società n»*
una società solidale»
Regala
un abbonami
hone
domi
il do
®spo
sister
 7
7
_ji,ione in a.p. 45%
20/B legge 662/96 - Filiale diTorino
tódi mancato recapito si prega restituire
***H»nte presso l’Ufficio PT Torino CMP Nord.
' gl impegna a corrispondere il diritto di resa.
Fondato nel 1848
i» (Mst)
Itolo
e agri«
Movinit
ii senza!
' degli
a conqi
igolignii
li attui
idionale
annidi
0.000 fai
¡statola;
gli tasi
operatit
già coni
entrali il
izione
forma
ncrab),
lei red
sediate
è ormai]
sedia®
: sono*
;. Alcunii
danno
tedia, i
menti Bpl
iinimiii»|
Doveeà
e taleiü
mensits
re delà'
li piurf
plicesi'
ampapii
ne è ani
pprovatoi
lucazioi
della pi
.000 stili
segnati
oinvoltf
appo]
f. Le COI
terra hi
impori
?, della
di ortaf
lotti dai
tra uniti!
el latte
■i di lattt|
nalizzaó
mo varit]
:ole
rmiano
jro e sti!
Iti cheli
la CODI
; l’am®
aste pià
sere so#
oratori*'
rtecipai'®!
gestioijl
nirelef“
uel nto»
che ge”¡
ale
altro tif
conoW*
sul risi
IO e no®,
idagnO'
-n prese
nuove
e il Stj
ettivot“',
ietà n#'
ale»'
biblioteca comunale — In Italia molti giovani
dichiarano di non leggere alcun libro eccetto quelli scolastitanti adulti leggono appena un libro l’anno. Eppure le biMoteche dei nostri Comuni paiono vivere un momento di
Mancio. Negli ultimi anni diversi paesi hanno visto aprire
luna nuova biblioteca, oppure il potenziamento dell’attività.
Sabato scorso è stata inaugurata la nuova biblioteca di Torre
Mlice; i 5.000 volumi in dotazione non saranno più consultali nella piccola sede del municipio ma in quella più spa^osa e luminosa di via D’Azeglio. Con meno di 4.600 abinti; la biblioteca «Carlo Levi» di Torre Pellice ha registra[to nel 1996 più di 4.800 prestiti, con un aumento netto
inell’anno in corso di circa il 40%. I nuovi locali dovrebbero
pare un’ulteriore spinta all’utilizzo da parte degli studenti,
i ora fra i maggiori fruitori della biblioteca.
DE
r
<1
A Lj.
venerdì 24 OTTOBRE 1997
ANNO 133 - N. 40
LIRE 2000
In questo periodo, in forme
diverse (dai tavoli della
Santa Cena coperti di frutti e
fiori in Scozia a lunghi tavoli
stracolmi di frutti colorati sopra e patate di montagna sotto
a San Giovanni) molte chiese
celebrano la festa del raccolto.
Chi lavora nell’organizzazione guarda con una punta di legittima soddisfazione i prodotti esposti, il numero crescente di donatori... e la massa
di acquirenti (non sempre assidui frequentatori di culti).
Vogliamo richiamare alla
nostra memoria un antico testo: «Guardati dunque dal dire
in cuor tuo: la mia forza e la
potenza delle mie mani mi
hanno procurato queste ricchezze» (Deut. 8, 17). Il prodotto della fatica del contadi
OPERE UMANE E OPERA DI DIO
IL RACCOLTO
MARIO F. BERUTTI
no o del coltivatore, pensionato o part time, è una buona
parabola di ciò che questa pagina del Deuteronomio vuole
esprimere. Nulla come il prodotto dei campi è legato da un
lato al sudore della fronte;
nulla è tanto legato a incertezze meteorologiche; la modernità e la legislazione europea
aggiungono poi rigidi vincoli.
Può essere dietro l’angolo
l’orgoglio di pensare che tutto
è prodotto della nostra forza e
della nostra potenza.
Portare una parte del raccolto per sostenere la chiesa
può essere un piccolo segno
di riconoscenza, un modo per
ricordare a tutti noi che il poco, ma oggi dovremmo dire il
tanto rispetto alle altre generazioni 0 ad altre aree geografiche, non sono «solo» il frutto della nostra fatica. Le generazioni che hanno conosciuto
la dura fatica dei campi e del
lavoro del granito di Luserna
ci stanno lasciando; la logica
della forza e della potenza
dell’uomo dominano la scena.
La chiesa è chiamata a dire,
anche solo sommessamente e
senza pretese di essere madre
e maestra, che «se il Signore
non edifica la casa, invano si
affaticano gli edificatori» (Sai.
127, 1). Sorelle e fratelli dobbiamo riscoprire e aprire gli
occhi sulla grandezza dell’opera di Dio dietro le piccole e
le grandi cose della nostra
quotidianità e a lui rendere lode e gesti di ringraziamento.
Ricordiamo che il Signore «ti
dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare, come
fa oggi, il patto che giurò ai
tuoi padri» (Deut. 8, 18).
[Azienda Usi 10
iNominati
|ue nuovi
fiiirnari
/iflirettore generale del¡■lienda Usi 10 di Pinerolo,
Hiruccio Massa, ha nominato in questi giorni due nuovi
iTpimari: il dott. Giuseppe
prazia nel reparto di Pedia^tria del presidio ospedaliero
^<E. Agnelli» e il dott. Ema, mele Fontana nella specialità
di Psichiatria del dipartimento
di Salute mentale dell’Ausi
(10. Sono state così completate, in sei mesi daU’insedialento della nuova direzione
aendale, le nomine di 6 pripari per i posti vacanti nel|l’ambito del piano di organizzazione aziendale. Alcuni pri(fflariati erano infatti vacanti
da quasi due anni: uno di que[Sti era proprio quello di Pepatria, dopo il pensionamento
della prof. Zoratto avvenuto
dl’iniziodel 1966.
Il dottor Grazia, a cui è state conferita la nomina quinquennale di dirigente di II li''ello (ex primario) di PediafWa, è fra i più titolati medici
■tediatri operanti presso l’aienda ospedaliera infantile
Regina Margherita» di Torioltre ad essere specialista
Wehe in oncologia clinica e
te igiene e aiuto primario re^®Ponsabile del servizio di
l«day hospital oncologico»,
teià ricercatore sperimentale
Ideila Clinica pediatrica, focal~zò modalità di intervento in
Pmica genetica e immunoloSiu diventate poi fondamentat ' bella letteratura medica inflazionale; studioso presso
1 Centro nazionale delle ri■ btche, il dott. Grazia opera
, r'e problematiche di nutrii ^ ? .^bterale e parenterale
I j^taiciliare in età pediatrica,
dottor Fontana invece era
^Pensabile dei servizi di as^^tenza sanitaria di base e inSrativa presso l’ex Unità sojj^sanitaria 43 della vai Pel5 ® fino a oggi aiuto corregQ di Psichiatria pres
n dipartimento di Salute
'"ùntale dell’Ausi 10.
Una giornata di studio e di dibattito opportunamente organizzata dalla Comunità montana vai Pellice
Lo Stato sociale si rinnova se riesce a fare promozione
PIERVALDO ROSTAN
Sulle prospettive dello Stato sociale si è andati alla
crisi di governo, su questo argomento si discute in tutto il
paese da mesi e lo si dovrà fare nei prossimi in modo concreto senza sfuggire ad alcuni
nodi centrali. La Comunità
montana vai Pellice ha scelto
questo tema per una giornata
di studio organizzata a Torre
Pellice sabato scorso. E se la
presenza del Presidente della
Repubblica nella vicina Giaveno ha sottratto alla giornata
alcuni esponenti politici, le tematiche proposte alla riflessione non sono state comunque banali. Un’argomento definito «bomba a orologeria»
da Cesare Roccati, de La
Stampa, che presiedeva il dibattito, ma più che di una
bomba si è parlato di come far
sì che le classi più deboli possano contare su un sostegno
di servizi e di risposte ai loro
bisogni che, se non garantito
dallo stato, troverebbe le fasce di popolazione in difficoltà sempre più emarginate.
In realtà, ha ricordato il sindacalista Cisl Nanni Tosco,
L’Italia spende troppo poco per il sostegno alla famiglia
«lo Stato sociale è stato concepito inizialmente dalle forze
conservatrici che di fronte
all’organizzarsi delle classi
operaie per garantirsi qualche forma di tutela (è il caso
ad esempio delle società di
mutuo soccorso) avevano preferito promuovere forme pubbliche di sostegno». Ma oggi
bisogna partire dallo scenario,
dalla situazione di lavoro o
non lavoro dei cittadini. «Lo
Stato sociale - ha continuato
Tosco - è stato concepito in
modo strettamente collegato
al lavoro e si è pensato ad
una crescita regolare dell’occupazione. Sappiamo benissimo che oggi non è così. Da un
lato ormai è chiaro che molti
non faranno per tutta la vita
lo stesso lavoro, ma va tenuto
conto di una ampia fascia di
lavoro che non corrisponde ai
canoni tradizionali del lavoro
dipendente. Se quest’ultimo
resta il principale ( 12,5 milioni su 20 milioni in Italia), ci
sono ormai 5,5 milioni di cittadini impiegati in lavoro autonomo, 2 milioni a part time
e circa 4 milioni di lavoratori
“in nero’’. A questi dati pos
siamo aggiungere che circa
1,6 milioni di persone oggi lavorano in Italia per proprio
conto versando al sistema
previdenziale la sola aliquota,
di recente introduzione, del
10%. Quale copertura pensionistica queste persone potranno avere infuturo?».
La condizione di lavoro
dunque pone sinistre ombre
sulle prospettive, anche perché sempre più la disoccupazione pare «strutturale», cioè
di lunga durata, specialmente
per giovani e donne. Né la
formazione che oggi si ipotizza per il futuro sembra rispondere alle esigenze di superare
la fortissima concorrenza dei
paesi senza o con pochissima
tutela sociale, garantendo capacità di produrre puntando
sulla qualità. Accanto al cam-’
biamento delle opportunità di
lavoro, Tosco ha ricordato anche i mutamenti nella composizione della società, dal progressivo invecchiamento della
popolazione, al cambiamento
nella struttura delle famiglie,
fatte sempre più di single, ma
anche di padri o madri sole
con figli. «Finora si è pensato
allo Stato sociale solamente
J n capitolo doloroso sul quale i
LJ figli della Chiesa non possono
non tornare con animo aperto al pentimento è costituito dall’acquiescenza manifestata a metodi di intolleranza e persino violenza nel servizio della verità... da
parte di tanti suoi figli che hanno deturpato il volto della Chiesa, impedendole
di riflettere pienamente l’immagine del
suo Signore crocefisso». Così il papa
Giovanni Paolo II nella lettera apostolica
«Tertio millennio adveniente». Questo
riconoscimento aperto e coraggioso onora la Chiesa di Roma, ma esso diventa
veramente molto pregnante quando lo
confrontiamo con reali episodi di intolleranza e violenza vissuti per esempio dai
nostri evangelisti nella loro opera di diffusione del Vangelo nel secolo scorso,
nel nostro paese. Cose che oggi apparirebbero incredibili se non fossero documentate da testimonianze dirette.
Rileggendo le memorie delPevangelista colportore Angelo Deodato, rilevia
ILFILO DEI GIORNI
INTOLLERANZA
ALBERTO TACCIA
mo con sgomento alcuni episodi. A Castrogiovanni (Sicilia) si impedì al pastore Stefano Revel di tenere una conferenza in una chiesa sconsacrata già concessa dal sindaco. Il Deodato aprì la sua casa a un folto uditorio, ma nel frattempo
così scrive: «In tutte le chiese della città
il tema delle prediche era uno solo: fuggite il protestantesimo, fuggite il protestante Angelo Deodato, non gli parlate,
pena la scomunica! E vero che la scomunica non aveva più il vigore di un
tempo, ma fecero tutto il possibile per
isolarmi e farmi morire di fame assieme
alla mia famiglia». Il Deodato era calzo
laio e i cittadini erano diffidati dal recarsi alla sua bottega
Ma il fatto più grave viene così descritto: «In sul finire dell’inverno de!
1885 mia moglie fu presa dalle doglie
del parto. Si chiama la levatrice, non si
avverte nessun pericolo, tutto sembrava
riuscire bene, come per i primi sei, invece... si sgravò di una bambina morta!
mentre fino al E ultimo momento si era
avvertito che era viva. Quella fu opera
del diavolo, ovvero di un prete che suggerì alla levatrice di soffocare quella
creatura che stava per venire al mondo
nella famiglia del prote.stante». Il dubbio
fu atroce ma purtroppo la levatrice stessa
confessò la grave colpa in occasione di
un nuovo parto in casa Deodato (l’ottavo!), questa volta con esito felice. I coniugi vollero esporre denuncia, ma pensando alle conseguenze che ne potevano
derivare tacquero, anche perché furono
pregati di tacere, «ma presentarono a
Dio le loro giuste lagnanze!».
in termini di assistenza, di
protezione - ha aggiunto il
rappresentante della Cisl -; è
ora di iniziare a ragionare in
termini di promozione: i livelli di spesa italiani non .sono
molto diversi da quelli di altri
paesi europei, il problema è
che in Italia si tutela pochissimo la famiglia, chi fa i figli, e
si spende molto in pensioni».
lina questione che è stata
ripresa anche da altri interventi, in particolare dall’on.
Morgando: «Serve uno Stato
sociale che sia la base di una
nuova cittadinanza» ha detto
il parlamentare del Ppi. Certo
bisogna poter considerare il
mondo del lavoro e della produzione nella sua complessità: «In Europa lo Stato sociale costa circa il 32% della
ricchezza prodotta - continua
Morgando -, in alcuni paesi
dell’Asia si spende E8 o il
9%; è chiaro che queste cifre
innescano una pericolosa
forbice e il rischio che determinate produzioni si spostino
in zone a scarsa tutela del
cittadino».
Ma dobbiamo accettare
queste considerazioni senza
spirito critico? Se lo sfondo è
questo e se le grandi aziende
sempre più multinazionali
sembrano fare il bello e il cattivo tempo, non c’è la capacità, almeno a livello europeo
dove lo Stato sociale è un patrimonio storico e consolidato, di proporre modelli alternativi? Lo Stato sociale viene
spesso vissuto come un .semplice problema di conti da far
quadrare e su questa base
l’apparente dilemma è fra
quanti lo vorrebbero abolire
lasciando alle compagnie private l’assistenza e quanti lo
difendono; in realtà la questione è più complessa, affonda le sue radici nei bisogni
spesso urgenti di chi deve fare
i conti con un problema specifico, dalla povertà alla persona non autosufficiente in casa.
I servizi possono funzionare
meglio e, forse, anche costare
di meno, ma la questione non
è solo economica.
 8
8
PAG. Il
E Eco Delle "^lli "^.ldesi
VENERDÌ 24 OTTQRrp ,
Cronache
ANGROGNA: LA NUOVA MERIDIANA — Lo scorso fine
settimana Angrogna ha visto le consuete mostre dell’artigianato e dei prodotti agricoli nell’ambito dell’Autunno in
vai d’Angrogna. Sabato è stata anche inaugurata una bella
meridiana, posizionata di fronte alle scuole elementari di
San Lorenzo e realizzata da Gianni Mattana e Guy Rivoir.
«FRATELLO LUPO» — «Se nella pittura non possiamo privarci di un quadro di Raffaello o Tiziano..., se nella musica
non è possibile fare a meno della 9“ sinfonia di Beethoven..., se nella scultura non ci fossero le statue di Michelangelo... altrettanto non possiamo privarci nella natura della
presenza del lupo», eosì recita l’introduzione alla mostra
«Ben tornato... fratello lupo», che sarà inaugurata venerdì
31 ottobre alle 17 a Palazzo Vittone di Pinerolo. Si tratta di
un’esposizione didattica, presentata dal Wwf sezione pinerolese, sulla presenza in Italia e in Piemonte del mammifero
tra i più rari della fauna europea; la mostra resterà aperta fino al 9 novembre dalle 9 alle 19.
TORRE PELLICE CITTA D’ARTE — Si concluderà a Torre Pellice la rassegna voluta dalla Provincia di Torino denominata «Città d’arte a porte aperte» e tesa a evidenziare un
ricco patrimonio di storia, di cultura e di arte, spesso celato
all’interno di città e paesi di periferia. Al termine di un percorso di 21 domeniche e altrettante città, questo turismo di
«scoperta» arriva a Torre Pellice. Domenica 26 ci sarà la
tradizionale castagnata, il gemellaggio con Guillestre sancito da lunga data, il mercatino dei prodotti artigianali e agricoli, visite guidate ai luoghi storici, i menù dei ristoranti a
base di prodotti tipici di stagione.
CONVEGNO SULLA LEGGE GALLI — Il Consorzio
Acea di Pinerolo organizza sabato 25 ottobre alle ore 9,30,
all’Hotel Cavalieri di Pinerolo, un seminario su «Gestione,
tutela e uso delle risorse idriche: legge n. 36 del 5-1-1994;
legge Galli». L’argomento di discussione sarà appunto la
cosiddetta legge Galli che prevede tra l’altro la delimitazione, da parte della Regione, degli «Ambiti territoriali ottimali» per la gestione del servizio idrico, governati da un’«autorità d’ambito» costituita dai rappresentanti dei Comuni e
della Provincia. Quando la legge sarà attuata, scompariranno gli acquedotti a gestione comunale per lasciare spazio a
uno o più gestori che opereranno sull’intero territorio. Il
eonvegno è rivolto in particolare agli amministratori dei
Comuni e delle Comunità montane della provincia di Torino; gli enti interessati sono eirca 120 e comprendono la pianura pinerolese, la vai Pellice, le valli Chisone e Germanasca, l’alta e la bassa vai Sùsa e la vai Sangone.
E APERTO LO SPORTELLO DEL CONSUMATORE —
Dal 6 ottobre, telefonando gratuitamente al numero verde
167-574574, il cittadino-consumatore sarà messo automaticamente in collegamento con lo «sportello del consumatore»
più vicino alla località di chiamata e avrà la possibilità di illustrare il problema che lo assilla, ottenendo consigli, indicazioni operative, assistenza e un eventuale appuntamento
per un colloquio. È un servizio valido su tutto il territorio
piemontese, fornito dalla Regione a tutti i cittadini che possono così segnalare disguidi, lungaggini, e qualsiasi reclamo
legati al consumo di prodotti come alla fruizioni di servizi
pubblici e privati. Lo stanziamento dei fondi per la tutela del
consumatore fatto dalla Regione Piemonte quest’anno è stato di un miliardo e mezzo, rispetto ai 300 milioni del ’95.
AssicruRAziorsii
^BasileseaUiUiîhasÊ
Gruppo di Assicurazioni
la Basilese
Società coiiegata con gruppo
Banca Carige
Agente
Maria Luisa POGGIO GÖNNET
Agenzia generale
via Raviolo, 10/A - Pinerolo
tei. 0121-794596-76464
Incontro a Porosa Argentina
Per i fondi europei
non è tutto facile
LILIANA VIGLIELMO
Fino all’altro ieri dei fondi
europei non si sentiva
quasi parlare: ora improvvisamente le prospettive di accedere a questi finanziamenti
sono entrate nelle conversazioni quotidiane, si presentano progetti, alcuni respinti,
altri approvati.
L’incontro, dal titolo «I
fondi europei e lo sviluppo
del Pinerolese: risultati e prospettive», che ha avuto luogo
a Porosa Argentina il 17 ottobre nella sala della Croce
Verde, si proponeva di dare
delle indicazioni su questo tema che presenta una certa urgenza: infatti sta per terminare il primo decennio di questa
iniziativa, che dovrà essere
riformata a causa del probabile ingresso nell’Unione europea dei paesi dell’Europa
centrorientale, ma ora ci si
rende conto che l’Italia in generale e il Pinerolese in particolare hanno usufruito ben
poco di queste possibilità.
Il consigliere regionale
Marco Bellion e il funzionario della Regione Vito Valsania hanno spiegato i termini
della questione; ad essi si è
aggiunto r europarlamentare
Rinaldo Bontempi che si occupa della riforma futura. I
non addetti ai lavori potevano
capire alcune poche cose: il
Pinerolese, come tutta la provincia di Torino, la valle
Scrivia e il Verbano-CusioOssola, viene considerato una
zona di declino industriale e
come tale destinatario di fondi per la riconversione in altre
attività. Per quanto ci riguarda, a parte le due aree industriali di Pinerolo e Villar Po
rosa, non vi sono altre possibilità di sviluppo se non il turismo ma un progetto turistico, per quanto finanziato, non
produce di per sé un effetto
dirompente se non si sviluppano attività che danno da vivere a chi le pratica. C’è anche da osservare che un finanziamento rivolto agli enti
pubblici non' copre mai la totalità della spesa, per cui si
devono impegnare i fondi
propri non facili da trovare: a
volte i Comuni si trovano in
difficoltà anche solo a sostenere le spese per i progetti.
Le lungaggini burocratiche
fanno il resto e questo produce ritardi nella presentazione
delle domande che poi rischiano di venire scartate.
Per non accentuare troppo i
soli aspetti negativi, alcuni interventi di altri amministratori
locali hanno messo in risalto
la necessità di allargare gli
orizzonti, unendosi per presentare progetti più ampi e
perciò più credibili. In questa
prospettiva si situano i patti
territoriali, nei quali il territorio, viene considerato nei suoi
vari aspetti, sia economici sia
culturali e ambientali, in eollaborazione tra pubblico e privato. Scendendo ancora più
nel concreto, si è riparlato dei
problemi di viabilità ancora in
sospeso, vedi autostrada Torino-Pinerolo e statale 23, che
richiedono una soluzione a
breve termine. In un’area come la nostra, dove si registra
un alto tasso di invecchiamento, cercare qualche possibilità
perché i giovani rimangano e
abbiano un lavoro retribuito è
senza dubbio un obiettivo primario, non soltanto per gli
amministratori.
Controllo sugli impianti termici
La legge non era
procrastìnabìle
In tema di controlli sugli
impianti di riscaldamento, la
presidente della Provineia,
Mercedes Bresso, e l’assessore all’Ambiente, Giuseppe
Gamba, hanno dichiarato di
essere solidali con i cittadini
titolari di impianti (circa
50.000 sui 190.000 della provincia di Torino) che hanno
provveduto a tempo debito
all’obbligo di inviare la dichiarazione facendo autenticare la loro firma e quindi pagando il relativo bollo prima
che intervenisse la possibilità
dell’autocertificazione prevista dalla Bassanini bis, ma
che la cosa più grave sarebbe
stata rimandare l’applicazione della legge.
Lo scopo della legge sul risparmio energetico è infatti
troppo importante per il paese
nel suo complesso e per i bilanci familiari: il controllo
delle caldaie ha permesso di
intervenire in tempo su impianti inefficienti, che fanno
sprecare combustibili e soldi.
L'obbligo di sottoporre periodicamente gli impianti termici a manutenzione ordinaria e
al controllo del rendimento
energetico (il cosiddetto controllo dei fumi), stabilito dal
Dpr 412/93, è scattato nell’autunno del ’94 e ha cadenza biennale per i piccoli impianti familiari e cadenza superiore per gli altri. Gli inter
venti effettuati devono essere
registrati sul libretto di impianto o di centrale.
L’autodichiarazione di avvenuto intervento sostituisce
il successivo controllo fiscale: non c’è multa per chi non
vi provvede; l’intervento d’
ufficio (che è solo un controllo del rendimento energetico
e non una manutenzione) per
gli impianti non dichiarati
sarà di 85.000 lire per le caldaiette familiari e via via crescente per gli impianti più
grandi. Invece le multe scattano, e salate, per chi risulti
non avere fatto nei tempi previsti le manutenzioni e i controlli di legge. Per ora il costo
dell’intervento di manutenzione e controllo dei fumi effettuato dalle imprese specializzate non è un prezzo controllato: la Provincia sta trattando con le associazioni di
categoria, le associazioni dei
consumatori e gli altri soggetti interessati un accordo che
definisca parametri certi e trasparenti di conduzione degli
interventi tecnici.
Le 18.000 lire per le caldaiette e le tariffe maggiori
per gli altri impianti sono i
costi che la Provincia sostiene, non finanziata dallo Stato,
per l’avvio del complesso sistema di verifica, e che per
legge devono essere rimborsati dai titolari degli impianti.
Pinerolo
Il computer
e i libri per
nonvedenti
L’associazione Omero e
l’Unione italiana ciechi sono
stati protagoniste di una importante conquista nella diffusione del libro fra i nonvedenti e del miglioramento
della possibilità di usufruirne
da parte anche di chi non li
può leggere direttamente.
Nelle seorse settimane è stato
siglato un accordo con una
casa editrice di livello nazionale, la Danna, per l’utilizzo
di nuove tecnologie.
«Abbiamo presentato recentemente a Pinerolo l’iniziativa - dice Francesco Fratta, rappresentante delle due
associazioni in città -: si tratta
di un software costruito da
una mia collega di insegnamento al Buniva, la prof. Fossetto e da me, finalizzato alla
lettura di testi. La novità è che
esso rivela tutta la sua efficacia se applicato a libri forniti
direttamente degli editori: con
questo software si può mettere il nonvedente nelle condizioni di fare tutto ciò che normalmente una persona che vede può fare quando si trova
per le mani un testo e cioè
leggere o meno una nota, saltarla, tornare indietro, trovare
un rimando a un’altra pagina
senza per questo perdere il segno del punto dove si era
giunti nella “lettura”. Si tratta
insomma di un modo interattivo di rapportarsi a un testo ed
era una cosa che mancava;
abbiamo lavorato un anno e
l’editore ha molto volentieri
aderito alla nostra proposta; in
questo modo si potrà acquistare un libro e con esso, gratuitamente, avere due dischetti. Il nostro sogno è che anche
altre case editrici aderiscano
al nostro progetto».
Angrogna
L'acqua
ultima risorsi
di montagna
Sono ben quattro le
ste di concessione per
sfruttare l’acqua dell’Anj
gna che risultano depositale j
Provincia. Di un progetto*
particolare, quello della ceì
tralina elettrica della dj?
«Divalsim» di Racconigijl
parlato giovedì 16 ottobre o
la popolazione. È quindi^;
mersa la necessità di un.
me complessivo di ciòc
potrebbe succedere nell)
corso del torrente, in caso!
una 0 più concessioni,
fronte all’esposizione i
chiara della ditta, che ha d
quale sarebbe il suo guada»
e quale rimborso potrebbe^
dare al Comune (20-30 mia
ni annui), sono stati citati «
preoceupazione gli esempi] tiComini
gativi realizzati nella valici iasua ni
Carbonieri e si sono sotto infuturo,
neate tutte le possibili prej al Corniti
cupazioni ambientali. D'alii :Strodesid
parte ci sono gli aspetti eco* /Con il
mici: l’acqua è una dellea| ®eheall
me risorse dei comuni di m ¡pere «c
tagna, occorre assolutama pone,
impedire che ancora una vo ¡alta fen
questa ricchezza vada altroi ¡Abbian
Una centralina elettrica coi lopaes
circa 3 miliardi; la previa langelic
produzione di kilowatt acp itutto il
stata dall’Enel ai prezzi viga ¡elico eh
ti (ma su questo punto ci su Mtinuo
delle incertezze) darebbei achièsc
ritorno economico che, in
15 anni, ripaga i 3 mibari,(
da quel momento in poi
costi se non minimi proci
un reddito di circa mezzoi
bardo annuo. Di fronte a (f
sti conti l’offerta della dii
Comune appare bassa; Ip
sta alternativa sarebbe ài
Comune si associasse if
vati per un controllo dinll'
del territorio e per godeici
maggiori introiti.
(fella wta
Un amico delle
valli valdesi
Il 6 settembre scorso è deceduto a Parigi, all’età di 66
anni, Philippe Rossillon, appassionato di francofonia e di
latinità, convinto della necessità di conservare dignità alle
lingue dell’area latina, ivi
compreso naturalmente il
francese. Ex allievo dell’Ena
(la pre.stigiosa Ecole Nationale ¿’Administration), alto
funzionario del ministero delle Finanze, nel 1966 fu il primo relatore dell’Alto Comitato per la difesa e l’e.spansione
della lingua francese. Da allora, egli tenne contatti e svolse
missioni con il Québec, la
Louisiane, l’Acadie e vari
paesi africani. Fra le molteplici sue attività, Philippe
Rossillon fu sindaco di Beynac et Cézenac, nel Périgord,
per 16 anni. Delle sue pubblicazioni, cito VAlias de la langue française, éd. Bordas,
1995 (vedi Riforma del 2710-1995) in cui, a pag. 65,
troviamo un breve cenno (a
cura di Felix Vigne) «sull’importanza che ha avuto la lingua francese nel Bastion vaudois du Piémont italien».
Rossillon fu fondatore e
presidente di varie associazioni alle quali dedicava personalmente tempo e possibilità
finanziarie: France-Québec,
les Amitiés Acadiennes e altre. D&]\'Union Latine (organizzazione intergovernativa
costituita da stati di matrice
latina) fu segretario generale
dal 1983 al 1997. In quel pe
riodo, il numero degli sM
membri passò da 24 a
invitata da Rossillon a parte
pare al primo Colloquefro4
lier français et italien pom
diffusion mutuelle des la
che si svolse dal 1° al 2
1993 a Nizza, Sophia Antip
lis (vedi Riforma del 30-4-95
Allora, come in altri inco»^
parigini, ebbi modo di
zare la sua personalità di
matore appassionato e disi
ressato della francofonia.
La stampa francese e q®
canadese in particolare
hanno dedicato ampi arri
di stima e di amicizia. PI
pe Rossillon rivestì incan®
ministeriali che lo portar^
a verificare la situazione
l’insegnamento del fiances
della cooperazione frane®
in paesi lontani. Volle"'
visitare il Pinerolese e le
valdesi, tanto più interess
alla nostra regione in qn®
la moglie, Véronique Rn®
lon appartiene alla fa^s
Seydoux-Schlumberger
Hsp (Haute société protf®
te). Egli aveva a cuore di
servare lo studio del finp
nelle Valli come pure di
vare relazioni più agi
frequenti tra Italia e FraH
Aveva promesso di ritor®
ma... Ricordiamolo-^
strenuo difensore della
cofonia, attento al «roy<>l
meni de la civilisation
f/Proprii
Morzan
^lico sic
(»n le ri)
state arri
durante 1
il nostro
ce), KB!
ffljfesé, I
Ihran
Fdeidib
scemo
venute: :
battito è
¡cipanti: '
c:
Jori di
ita polii
Dobbi
il nosi
innaio
lichian
Tvizio
hioni/
(
¡sul front
® sem'
çaise».
Liliana Ribet
-W
SOSALCOLlSm
Poliambulatorio
Villar Penosa: tei. 51045-
 9
9
della Federazione Donne Evangeliche in Italia
Positatei
rogettoj,
della ce, ,
ella dii]
:onigisi
ttobren
quindi,
di une
Fdei: an anno dopo
ísempii
a valle 1
>0 sottol
nili pre
li. D;
etti ecoi
dellei
nidii
dutanw
i una
da altroj
trica co
a previs
v'att ac(|
;zzi viji
ito cisi
arebbe
;he, in
miliaii,!
1 poi SM|
li proal
mezzoái
mteai|ií
:11a dili
;sa; \$
bbe M
sse ai|i
lio dii®
goderei
Fa chi <
artiíí
iegli sil
la
1 a partí
]ue /ro»l
en poiiJ
'es langi
al 2 api
lia Antij
1 30-4-9!
xi incoili
di appi
lità di
) e di!
bnia.
se e qui
colare
'P‘ n.
ria. Pi
ì incanì
porta«
izione
france!
; fraiiei
rolle
e e le
nteresi
in qni
ue Rei
a fami!
;rger <■
protesi
xre di
;1 fratiCj
ire di *
agevol
e Frai*
ritorni
ilo-e?'
iella W
«rayof,
■tionì
„-Toiil
ism
)45-5I^
lamo a un anno dal congresso Fdei che ha deciso la svolta per un più coerente
impegno di tutte le donne evangeliche in Italia. Occorre fare un primo bilancio!
^ La nostra analisi deve toccare i tre fronti dell’iniziativa: quello internazionale,
niello nazionale e il servizio di formazione e informazione delle donne evangeliche.
■Éorninciamo da quest’ultimo: ci sono opinioni ampiamente positive sia sul Notiziario
”i sua nuova «veste» e i suoi contenuti) sia sul materiale di studio. Sarebbe importante,
in futuro, che ciascuna di noi (unione/gruppo femminile o singola) desse un contributo
al Comitato nazionale per scegliere il tema di studio al fine di rispondere meglio al voistro desiderio di approfondire argomenti di fede e di attualità.
Con il Notiziario siamo «visibili» non solo nel nostro «piccolo mondo» evangelico, ma
'sche all’esterno. È il nostro maggior biglietto da visita perché chi non ci conosce possa
are «che cosa» tacciamo e «come» testimoniamo. Ma anche qui occorre tanta collaboàone, perché il foglio diventi davvero «la fotografia» di tutta la varia gamma delle
jltà femminili evangeliche presenti in Italia.
lAbbiamo molto curato la parte internazionale perché, essendo noi minoranza, nel nero paese, non pecchiamo di alcun complesso... appunto, «di minoranza». Noi donne
igelichc in Italia rivendichiamo l’appartenenza a un vasto mondo evangelico diffuso
iiutto il mondo e ricco di valori fondamentali per ogni essere umano. Un mondo evanÉco che fa della propria assidua elaborazione e riflessione biblica, uno strumento di
atinuo rinnovamento per una testimonianza sempre più capace di parlare a chi soffre,
ti è solo, a chi patisce ingiustizie: fondamentalmente a chi cerca la risposta sul senso
ideila vita.
■■^Proprio questa coscienza, di dover tutte essere al servizio delle altre, ci ha indotto a
[i Morzare i nostri legami con il vario associazionismo femminile internazionale sia evan^licosia ecumenico. Abbiamo avuto incontri con le evangeliche dei paesi mediterranei,
con le riformate svizzere, con le sorelle che lavorano nel Diakonisches Werk, ne siamo
state arricchite e abbiamo potuto mettere a punto iniziative comuni, come è avvenuto
(lutante l’Assemblea ecumenica di Graz dove, tra l’altro, eravamo presenti non solo con
il nostro simbolo (le quattro donne che, unite, ricordano il sacrificio di Cristo sulla cro) ce),m^ianche con due «speciali» del Notiziario, uno in lingua francese e 1 altro in lingua
ffljjese,*per facilitare il dialogo fra tutte le credenti.
ttirante la 2- Assemblea ecumenica, il gruppo «donne» della Cepple ha incaricato la
Fdei di tenere un seminario su «Donne credenti e politica». Il seminario ha avuto successo e molte sono state le evangeliche e le cattoliche inter- _________________________—„
venute: francesi, spagnole, portoghesi, svizzere. Dal dibattito è scaturita una riflessione comune a tutte le parteiCipanti: «Se la politica non è vissuta come servizio c se le
' inne credenti non si mantengono fedeli a se stesse e ai
Jori di rispetto della dignità e dei diritti di ciascuno, la
ita politica può avere una potente forza di corruzione».
, Dobbiamo infine riconoscere che ancora insufficiente
à il nostro impegno sul piano della formazione; solo a
' innaio partirà una prima esperienza a Vallecrosia; aulichiamo di poter allargare questo settore di lavoro e di
irvizio della Fdei. C’è già una disponibilità in alcune
^nioni/gruppi femminili pugliesi; potrebbe concretizzarsi
Ìà nel corso del nuovo anno qualche iniziativa specifica;
[sul fronte «esterno» cioè nella società, la Fdei sta trovansempre più ascolto; la nostra cultura, alternativa a
dominante, ci rende interlocutrici importanti, in
questo periodo di ricerca di valori fondamentali, anche per il nostro vivere civile. Un segno di questa rinnovata attenzione, è stato il convegno su «L’altro femminisnno» tenutosi
in giugno a Roma presso la Camera dei deputati, È stato un confronto tra più voci all interno del mondo delle religioni monoteiste; erano presenti il rabbino Elio Toaff, 1 imam
Hammad She Weita del Centro islamico culturale d’Italia, monsignor Vanzan dell Università Gregoriana di Roma, e la professoressa Cettina Militello dell Università Maria
num di Roma. È stato facile comprendersi con la teologa cattolica Militello; più difficile
spiegare agli altri, agli uomini, che esaltavano la nostra funzione «procrcatrice», che se
Dio voleva solo assegnarci quel compito non doveva dotarci di cervello! Il rabbino, ricollegandosi all’Antico Testamento, ci ha invece ricordato le numerose figure femminili che
sono «a tutto tondo» essere umani, rispettati e valorizzati. E, giustamente, ha concluso:
«...però le donne devono imporsi».
Se questo è il quadro di questo primo anno, dobbiamo ricordare a noi stesse che ci attende un periodo ancora più intenso: da un lato viene a cadere la fine del «decennio» e
la Feci ha già organizzato a Roma un importantissimo appuntamento per il 28-29 marzo 1998, per la cui preparazione anche la Fdei è impegnata; dall’altro scade anche il
periodo «straordinario» della Fdei che tra il 30 ottobre e il 1- novembre 1998 terrà il
proprio congresso per darsi il definitivo assetto e scegliere i percorsi di lavoro per gli anni a venire. Per far ciò occorre organizzare, tra l’autunno e la primavera ’98, i convegni
regionali. Già se ne sono svolti tre, uno in Sicilia, uno a Torino (interregionale Piemonte, Val d’Aosta, Liguria) e uno a Roma (interregionale Lazio, Abruzzo e Umbria) che
cercano di dotarsi di nuove strutture di lavoro: è infatti importante che già in sede locale
cominci a vivere la nuova Fdei, cioè diventi davvero 1 espressione di tutte le realtà. Molto
intensi sono i rapporti sia con le luterane sia con le awentiste e l’Esercito della Salvezza.
Forte è la partecipazione ai lavori della Fdei del «gruppo ecumenico delle donne straniere», ma tante altre sono le sorelle che possono aiutarci nella nostra testimonianza... e
abbiamo bisogno di tutte loro!
C’è infine un ultimo adempimento, formale ma di grande significato, che dobbiamo,
in base ai deliberati dell’ultimo congresso: compiere la riforma dello Statuto. Un gruppo
di lavoro ristretto si è già incontrato il 10 ottobre.
Questo è il nostro piano di lavoro, se avremo I aiuto ed il consenso di ciascuna di voi
e, soprattutto... «se a Dio piace»
Dorìana Giudici
0)
Oì
E
o
0
1
in
O
(D
E
'im
IH
Ido 1
feuella
-Il
WE®#
«
M
Lasciarsi affarrare, senza rimpianti
entre camminavano, un tale disse a Gesù: “Io verrò con te, dovunque tu andrai . Ma Gesù gli rispose: Le volpi hanno
unri Ena-e# uceètìt:^ ma il Figlia déiruomo non: ha un posto dove po^r riposare Poidissa a un altro-,
- » “Vieni con mel”. Ma quello rispose: “Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre . Gesù gli rispose:
/“Lasciatile i mé0i s0p0eUisédtmMorpmorM^. fu invecem’, ad dmpnzi^e d _ worvico “rhi
Uri altro: Éisse-àè&esM^^ìghòrfydò:^^ prirné:terò: Jd^ldtip: dh ■ Gesù gli rispose. Chi si
rneaealFaratrò:apomvòl&inéietra, nonepdqttoperiLre^ . _ . , , _ ,
Gesù secondo quanto ci dice l’Evangelo di Luca, ha ormai preso la decisione di mettersi in viaggio per Gerusalemme. Egli e fermamente
deciso à portare anche là, in Gerusalemme, nella città santa, nel cuore delFebraìsmo il suo messaggio del regno di Dio che viene e certamente =sà,ijtìltto;béftÌjÌÌà=ciieitÌbofripQrteràUriò , .. j
Còsi mentre Gesù e i suoi discepoli sono in cammino, un tale che, apparteneva a quella folla che gli stava sempre intorno ovunque andava ali k avvicina. Costui, definito dail’evangelistà Mattèo «rnaestro della tegge>i; .e a quel gjruppo della dingenza relipo
sa’<5tilela=Ìésù,"àffaariÌ& dall’insegnamento di Gesù,,si dÌchiara ,pronto a seguirlo ovunque. E Gesù, con un detto popolare
che sottolinea ritisicurézza della vita umana, gii fa presente (ù. SS),quanto precaria e insicura sia la sua stessa vita.
" Gesù riélla sùà iniàsione; itinerante, aveva molti amici (e iAferigèli ce rie danno testitrionianz^ ed erano amia che lo a^o^v^o a c^a
loro mèglio che potevano, facendo il possibile per non fargli mancare Mila, Esprimendo quindi la precarietà della sua vita, Gesù wole far
capire che non basta ùh grimo entusiasmo, seguirlo è una cosa seria, vuol dire avere un esistenza precartaqoiu ancora di quella delle bestie
selvatiche II discepolo, ihfatti, sarà sempre straniero e non avrà mai la tranquillità di un posto sicuro, poiché le cose di questo mondo non
hanno una forza tale da trattenerlo, sarà sempre in viaggio cioè sempre disponibile ovunque è per chiunque, sara nel bisogno e potrebbe
anche non avére, il minimo necessario alla dignità della vita. Il discepolo che vorrà scegte^^ di stare al seguito di Gesù dovrà fare come Gesù stesso, affidasi ùnicamente alla Provvidènza divina e solo cosi potrà avere ricovero, riposo e_il nece^ano per vivere. ^ HaU’ar,Per seguire Gesù, àllora,; bisogna saper abbandonare ogni nostra sicurezza: la sicurezza che viene daUa nostra condizione sociale, dall ap
partenenza a una Chièsa, à uri partito,... le sicurezze che vengono dalla propria famiglia, le sicurezze de! proprio patrimonio, dalla propna
qualifica professionale, dàlie proprie conoscenze culturali. Tutto questo è come un bagaglio inutile, ma non nei senso che non s^e piu a
nulla, che sia tutta roba da buttare vìa, ma nel senso che tu che ce l’hai non sei più irnportante di uno che non ce 1 ha, perche a Gesù non
interéssa aumentare il numero dèi proseliti, interessa invece il dono che ognuno fa della propna persona, il dono di se che fa colui che ha
capito che in Gesù il Regno di Dio è giunto fino a noi. ■ c
Continuando a ritleltefe sul brano di Luca, notiamo che Gesù, ad un certo punto (w. 59 e 60), usa il termine «morte» in senso figurato
rivolgendosi a coloro la cui vita non è stata rinnovata dalla fede in lui che chiama, essi sono dei morti, non sono dei vivenh. Sentire il dovere di anniinziare l’Evangelo deve avere priorità su tutto, nella mente e nel cuore del discepolo; ci sarà anche tempo dopo di assolvere al dovere della pietà verso i morti, ma è il «si» schietto c sincero che Gesù vorrebbe c che invece non viene. ^ • t n i- - c
Insomma 11 comandamento della legge, poiché di questo qui si tratta, non può avere pnonta sul! appello di Gesù a seguirlo. Egli c il Signore e poiché è il Cristo, solo lui può parlare con tono di autorità, un tono che rivela a noi le nostre contraddizioni, la nostra pochezza la
Lstra miseria. Per chi vuole essere discepolo seguire Gesù deve essere una necessità vitale perché, come dice Pietro in un altro passo del
Vangelo, «a dii andremo noi, o Signore, se tu solo hai parole di vita eterna?» (Giovanni 6, 68).
Il discepolo del passo biblico pone addirittura delle condizioni: «"lo ti seguirò (...) ma.... » (w. 61 e 62). Questo discepolo '^ole seg
Gesù ma con riserva. Gesù però, non vuole dire che non bisogna più guardare in taccia i propri parenti, ma che bisogna tagliar Mto con
loro bui i parenti stanno a significare tutta la propria affettività, tutto il proprio vissuto, tutto il proprio passato che non può tratteriere il
discepolo perché non può essere il nostro passato che ci impone la regola e il modo di seguire Gesù, semmai è Gesù che spingendoci a
guardare in avanti, al futuro di Dio, proprio in quest’ottica ci permette il recupero di tutto il nostro passato, con la mente libera e il cuore
Leno Così come il lavoratore nel campo deve sempre guardare avanti a sé perché se si volta indietro il solco non sarà dintto non sara
nrofondo ma tortuoso e superficiale. Così chi segue Gesù deve guardare davanti a sé, a colui che lo prende al suo maestro il Cristo, bolo cosi il passato può avere un senso, solo se tutto il nostro bagaglio, tutta la nostra vita con ciò che di meglio contiene sarà messa al ser
Sollln^qtStó prospettiva potremo vivere, lavorare, amare, con responsabilità, con coraggio, con gioia e perché no, anche con allegria.
Gesù non ci chiama certo a seguire pratiche religiose, ma ci chiama alla vita, ci chiama ad andare dietro di lui, subito, nel mondo, a lavorare con lui nel mondo e per il mondo, non da soli, ma «in Cristo», uniti a lui, tutti insieme, uomini e donne, nella comunità che è illuminata
^^Se non è°quiste^R*ottica entro la quale noi mettiamo la nostra vita, rischiamo veramente di diventare dei «morti capaci solo di seppellire
inostri morti». SUvana De Costcr
 10
10
PfIG. Il
#• ■
Il
Donne evangeliche e statuto
Come molte di voi ricorderanno, l’ultimo Congresso Fdei ’96, a Ecumene, aveva dato mandato al Comitato nazionale di prendere contatti con le varie realtà femminili protestanti presenti sul territorio nazionale per dar vita a una nuova Fdei che dovrebbe raccogliere tutte le
donne evzingeliche in un’unica federazione, pur lasciando a ogni denominazione la più ampia
libertà nella propria specificità, nei regolamenti interni e cosi via.
Nel febbraio di quest’anno c’è stato un primo incontro a Roma con le sorelle in rappresentanza delle donne avvertiste, delle luterane, dell’Eserdto della Salvezza, della Chiesa evangelica intemazionale e dell’Associazione Cassiopea e tutte si sono dichiarate disponibili all’idea di
un’unica Federazione che le riunisca e le rappresenti.
In seguito a ciò il Comitato nazionale ha provveduto a nominare una Commissione che si è
incontrata in questo mese di ottobre per la revisione dell’attuale statuto della Fdei, per dare
concretezza alle proposte scaturite e che potranno ancora emergere.
Il Congresso straordinario del 1998 potrebbe, cosi, vedere la nascita di una federazione di
donne evangeliche in Italia ancor più ampia di quella già esistente sul piano delle chiese (l’attuale Fcei).
E un progetto ambizioso, non privo di difficoltà, specie sul piano amministrativo, ma che,
con l’aiuto di Dio, potrà essere attuato rivelando ancora una volta la tenacia delle donne, laddove soffia lo Spirito.
Emera Napoletano
CIn comitato nazionale per la Gmp
Come tutte saprete all’ultimo congresso della nostra Federazione (Fdei) abbiamo deciso di i
nizzare un comitato per la Giornata mondiale di preghiera in modo da poter anche noi far i
dell’organizzazione a livello mondiale. Come vi ricordate, questo comitato doveva essere un (
nismo che rappresentasse il più possibile le realtà evangeliche, cattoliche e ortodosse.
In questi anni il Consiglio ha lavorato in questo senso cercando contatti che fossero rappreso,. |
fativi, a livello nazionale, dei vari organismi. Non è stato un lavoro molto semplice anche pe^l
molte chiese evangeliche non hanno gruppi femminili a livello nazionale mentre altre realtà son I
decisamente contrarie a qualunque attività femminile. ''1
Oggi posso dire che, oltre alle sorelle rappresentate dalla Fdei, erano presenti alla riunione eh L
si è tenuta a Roma il 6 ottobre anche rappresentanti delle chiese cattolica, anglicana e luteran,
nonché di Cassiopea. Altre chiese o organismi che sono stati convocati non hanno ancora ristv *
sto ma conto sulla loro risposta. cap*'’® ®
Per poter capire meglio come organizzare il futuro comitato abbiamo rafforzato contatti siaa|. ***^^^2
vello europeo che a livello mondiale. Alla fine di agosto Daniela Platone ed io abbiamo partecipa. oni
to a un convegno europeo della Gmp che si è tenuto in Svizzera, vicino a Lucerna, in un paesino ^**di ui
di collina molto pittoresco per la sua simmetria e l’ordine. L’unico punto negativo erano le rnur. t? i» A- a
'0K ^
che che di notte continuavano a pascolare nei campi suonando i loro campanacci. Eravamo alW
giate in un Centro gestito dal movimento delle donne cattoliche svizzere, nato come Centro di ac.
coglienza per donne con problemi; oggi, per potersi autofinanziare, serve anche come Centro pg
conferenze. '
dmnesty International
desig
lenti
dodici
à agli ii
The
siimonp
L’Unione europea ha designato l’anno 1997 come Anno europeo contro il razzismo, il Consiglio ecumenico delle chiese ha
dedicato l’anno 1997 alla solidarietà delle chiese con gli sradicati. Così per Amnesty International l’anno 1997 è l’anno in difesa dei rifugiati.
Quindici milioni di rifugiati, venti milioni di sfollati. Un’accusa
enorme per il mondo intero. La stragrande maggioranza dei rifugiati si trova nei paesi più poveri, mentre meno uno su dieci
raggiunge uno stato industrializzato.
Con la crisi del sistema intemazionale per la protezione dei rifugiati il problema si aggrava soltanto. Gli stati fanno di tutto
per respingere i richiedenti asilo (Guardie di confine, ufficiali
ostili, ecc.). Quindi la campagna in risposta alla crisi mondiale
dei rifugiati mira a:
- prevenire le violazioni dei diritti umani, così che la gente
non debba lasciare la propria casa in cerca di sicurezza;
- assicurare a coloro che fuggono dalle violazioni dei diritti
umani la possibilità di raggiungere un luogo sicuro, di ricevere
effettiva protezione contro il ritorno forzato e la garanzia di ottenere uno standard minimo di trattamento umano mentre sono
profughi;
- rendere i diritti umani una priorità nelle tematiche inerenti i
rifugiati, quali programmi per il loro rimpatrio, gli sviluppi nelle legislazioni intemazionali e
nella sua attuazione, e la protezione richiesta dagli sfollati all’interno dei loro stessi paesi.
Sono molte le persone che ogni giorno prendono la decisione di lasciare la propria casa perché temono per la loro vita, molti di loro non hanno attraversato una frontiera, sono gli sfollati, profughi all’interno dei loro stessi paesi. Soffrono spesso ulteriori abusi, vivendo nel paese
che non ha potuto dare protezione nel luogo originario....
La maggior parte dei rifugiati a livello mondiale sono donne e bambini che debbono affrontare il doppio delle difficoltà degli uomini durante la fuga, nei campi, ma anche quando cercano asilo nei paesi «più industrializzati».
In questo quadro c’è stata un’azione speciale riguardo alle donne in Afghanistan, a cui la
Fdei ha dato pieno appoggio. Nelle zone controllate dai Talibani, le donne sono ridotte a prigioniere nelle loro stesse case, possono uscire soltanto accompagnate da un parente di sesso
maschile. E dove la donna è l’unica responsabile del sostentamento familiare, la situazione è
tragica. Nella sola città di Kabul sono oltre 30.000 le vedove, molte delle quali non hanno un
parente di sesso maschile che possa accompagnarle in pubblico.
Motivata la scelta del titolo di questa campagna di A.I.;«Donne in Afghanistan; una catastrofe dei diritti umani».
Il ciclo di abusi impuniti scoraggia ogni speranza per una situazione in cui i diritti umani possono essere vissuti.
E con forza che affermiamo ciò che sta scritto nell’articolo 14 della Dichiarazione universale
delle Nazioni Unite, cioè il diritto di ognuno di chiedere e beneficiare, in altri paesi, dell’asilo
contro le persecuzioni, a meno che non si sia ricercato per reati non politici o per azioni contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Tema della conferenza; Donne in Europa, Lavorare per la pace. Sottotitolo; Dio ci ha creati diversi
come vivere insieme in Europa. Non si è parlato solo della Gmp, ma le conferenze avevano come tema il nostro essere donn^
in una Europa che cambia, le nostre speranze e le nostre responsabilità.
Durante i lavori di gruppo, negli incontri interpersonali, abbiamo imparato molto sull’importanza che questa giornata ha in^Udavar
Europa; molto impegno è speso per la sua organizzazione, molte sono le comunità che si ritrovano per pregare insieme. Non ¡¿iment
esistono problemi «ecumenici», il rispetto reciproco è punto fondamentale della vita di fede per chi partecipa alla Gmp. ft u Jd Ci
fronte alle esperienze delle nostre sorelle europee abbiamo trovato difficile spiegare la nostra situazione di chiese di minoranza me corp'
in un paese a preponderante maggioranza cattolica. jerificio
Per capire meglio come organizzare il nostro «novello comitato» ci siamo incontrate, una sera dopo la conclusione dei lavori, lacorru
con le responsabili del comitato europeo, con la rappresentante del Comitato mondiale per l’Europa e con un membro del Co ità a cat
mitato mondiale alle quali abbiamo esposto le nostre perplessità e le nostre difficoltà. Ci hanno dato suggerimenti legati alialo- Jamo, la
ro esperienza, ci hanno consigliato una struttura leggera, libera di agire senza troppi vincoli istituzionali che opera nel rispetto Inente de
delle diverse identità. Abbiamo ascoltato le esperienze delle sorelle dell’Est europeo che solo ora incomincia ad affacciarsi al ¡verbale
mondo della Gmp. jittura.
Per noi il convegno si è concluso il venerdì pomeriggio con una gita sul lago in battello, il treno per il ritorno ci aspettava,
avevamo dovuto partire in anticipo per essere presenti all’apertura del Sinodo. La nostra fretta è stata punita quando sul Got-'
tardo sei vagoni dietro di noi si sono staccati dal resto del treno. La paura è stata molta, per fortuna però nessuno sì è fatto dèi *
male; siamo però ritornate con molto materiale che potrà aiutarmi per un prossimo incontro; certo i problemi da risolvere so-* 1 fpndan
no molti, vorrei condividerne alcuni con voi nella speranza che abbiate voglia di aiutarmi con alcuni suggerimenti. Chi do;
nominare le componenti del comitato? Siamo abituate che i nostri comitati o Consigli devono rispondere del loro operato
una assemblea, da chi sarà composta questa assemblea? Molte di noi dovranno imparare a confrontarsi con un nuovo tipo
organizzazione anche a livello locale. Sono sicura che tutte insieme lavoreremo perché la Gmp non si impoverisca ma diva
sempre più un momento di aggregazione, di arricchimento, «un movimento che riunisce donne di popoli, culture e tradizioni^
diverse in profonda comunione, reciproca comprensione e solidarietà concreta».
Lidia Ribet
Greetje van der Veer
Un versetto biblico per ii congresso
Il prossimo anno dovrebbe vedere il compimento del mandato che il VI Congresso
dato al Cn-Fdei e cioè l’awalersi di quel progetto di revisione della sua struttura bmv intesi),
coinvolgere, in un lavoro unitario, altre realtà evangeliche femminili presenti nel nostro pa4
Il lavoro del Cn, a un anno circa dal prossimo congresso straordinario è stato assai intei» j
e non è certamente finito. A tal proposito, da tempo è stato richiesto alle sorelle delle unioi|
e dei gruppi di indicare, motivandolo, un versetto biblico che rappresenti le finalità e i conti
nuti guida del prossimo nostro Congresso nazionale. Finora sono pervenute solo due propf
ste, e invece è importante lasciarsi coinvolgere e far sentire il proprio pensiero.
Pensate anche insieme a un versetto biblico che faccia da «filo conduttore» al congresso
straordinario, motivate brevemente la scelta e inviate il tutto entro marzo al neo-gruppo di
dazione a Torino. In questo modo permetterete alla Commissione di pastore preposta, di
minarle e sceglierle con attenzione.
Saranno pubblicate, sul Notiziario, quelle proposte che sapranno esprimere attraverso
parole della Bibbia, la fedeltà e la testimonianza che sono la guida del nostro lavoro.
Tea Tonarclli
jfiUsa, i
íinizi di
ice rea
loteo
i diques
10 infedi
ico, e co
me della
per 1
lent
Ki, 11 fono
findiesse
raáone all
Oltre alia
ca, che res
leste come
rare affa I
morale eti
l’omosessu;
¡nati
i fondar
pure un
è stai
i, una
Indice del nostro interesse
Arrivano gii
stadi Fdei
Molte volte il problema delle finanze viene sottovalutato oppure
poco considerato quando si parla della nostra vita di fede. Eppure,
anche nella Bibbia, troviamo molti passi che ci fanno capire come
l’offerta del denaro è una risposta gioiosa della fede, è una espressione di condivisione e di solidarietà. È con questi pensieri che desidero esporre la situazione finanziaria attuale della Fdei.
Il Comitato Fdei può contare su mezzi finanziari esigui che possono a volte limitarne l’attività. Sono le quote delle Federazioni denominazionali, quella battista e quella valdese-metodista, e le offerte di
singole sorelle che permettono al Comitato Fdei di svolgere il compito affidatogli.
Compito che prevede; la pubblicazione di quattro numeri del Notiziario all’anno, della pubblicazione del materiale di studio, gli incontri del Comitato per la programmazione dei lavori, il costo dei
viaggi per le attività di collegamento e di rappresentanza, spese di
segreteria, poste, telefono,...
L'avvio del tesseramento, nato per permettere anche alle donne
evangeliche non appartenenti a unioni o gruppi femminili di entrare a far parte della Federazione, si è fermato a trenta tesserate. Accanto al proprio bilancio di gestione, il Comitato nazionale Fdei ha il compito di gestire la colletta della Giornata mondiale di preghiera fino a
quando non si costituirà ufficialmente un Comitato nazionale della Gmp, che, in questo periodo, sta già prendendo fisionomia.
E allora mi sembra doveroso informarvi che, nel ’96 la colletta ha permesso di inviare a
Haiti la somma di 10.800.000 lire per il progetto dei ragazzi «Restaveks». La somma è stata
inviata tramite la Federazione internazionale «Terre des Hommes», che ha sede a Ginevra, e
una loro funzionarla ha recapitato la somma direttamente ai Focolai «Maurice Sixto» di Haiti.
Invece, la colletta della Giornata mondiale di preghiera del ’97 ha finora raggiunto la somma
di 9.068.000 lire. Tale somma, tolte le spese, verrà devoluta, come annunciato a suo tempo,
in parte al progetto rivolto a donne invalide della Corea del Sud e in parte suddivisa a tre opere sociali delle chiese battista, metodista e valdese (vedi Notiziario n. 2 del febbraio ’97).
Per concludere vorrei ribadire che le possibilità di aiutare concretamente il lavoro del Comitato Fdei sono tante e ci auguriamo di ricevere presto dei «segni» di incoraggiamento che ci
permettano di proseguire l’impegno affidatoci con serenità.
«Eco-femminismo» è il tema di studio che la Fdei (insieme con i comitati denominazionali battista, valdesemetodista) propone alle donne evangeliche per questo nuovo anno ecclesiastico.
Il Cn-Fdei, attento ai temi ecologici, dopo aver sonstenuto la raccolta delle firme per la petizione sul clima (promossa dalla Fcei), insiste nel voler sensibilizzare le donne intorno alle problematiche che riguardano
l’habitat e il rapporto con esso, l’importanza del rapporto con le risorse naturali del pianeta, essenziali alla
sopravvivenza.
Il continuare a vivere in un ambiente inospitale crea
inevitabilmente disagio psichico e malessere fisico. E
allora noi donne, come portatrici di vita umana, siamo
chiamate ad avere un ruolo determinante nel la riappropriazione del nostro ambiente.
Elena Chines
Marina Bertin
Fcei a Fdei
Mentre esce questo nostro Notiziario si aprono i lavo!
a Torre Pellice, dell'XI Assemblea della Federazione dell*
Chiese evangeliche in Italia. Il cammino della Fcei, in
sti suoi trent'anni di vita, si è fortemente consolidato ed
auguriamo che l'importante incontro imprima ulterior
slancio ai servizi che la Fcei esprime: dalla radio televis|! ^at
ne al lavoro tra i migranti sino all'impegno pedagogi® i, luter;
per le scuole domenicali. La Federazione delle don« ^o«dc
evangeliche in Italia (Fdei) lo scorso anno ha compW ^
vent'anni. La Fdei non è la Fce «in rosa». Si tratta di dd
organismi paralleli e autonomi. La strada federativa cof |
risponde evidentemente alla sensibilità di uomini e don feto int
ne protestanti che credono nella valorizzazione delle di^^Ha
ferenze. Si può essere cristianamente diversi, ma proW
demente insieme per un comune progetto di testW neiggij.
nianza e presenza In questo paese dove la voce del p#
lo evangelico deve farsi maggiormente sentire, (di) sentat
iblee
Miniredazione per ii Notiziario
ci V
Il gruppo di lavoro per la pubblicazione del Notiziario Fdei aumenta. Infatti, a Torino,
costituita in questi giorni una «mini-redazione» che cercherà di sollecitare maggiormént®,^
mondo femminile a scrivere perché queste pagine diventino sempre più uno strumento di d^
logo e informazione. Essa collaborerà inoltre per tutti gli aspetti tecnici relativi alla pubblicaZ'^
ne e alla spedizione. _
A Maria Grazia Arena, a Grazia Martini, a Laura Gelso e a Edina Prochet, che hanno accfl
tato di condividere questo compito redazionale (e che hanno già collaborato alla realizzaz>®"|
dei numeri precedenti) va il nostro grazie per l’impegno assunto.
Infine desideriamo esprimere la nostra riconoscenza alla redazione di Riforma che si ^ ^
pre dimostrata concretamente disponibile a risolvere ogni problema mettendo a disposi^®^
persone e mezzi per l’elaborazione grafica, impaginazione, stampa, spedizione e quanta®!
necessita alla realizzazione del Notiziario.
Daniela Ferrar«
 11
11
Kl®1TQ2Q(35iQ®
P6Q. Ill
Una riflessione approfondita sui fattori di connivenza e quelli di resistenza
eologia protestante e fondamentalismo
1 protestantesimo, come
jutte le altre confessioni
^tiane e la maggior pardelie religioni, sviluppa certe
radicali di intolleranza
rana j^yte H solo modo possibile
^ ^ire e di praticare la reliin questione.
sia a li- radicalismi protestan'decipa. ^ono il più delle volte la
paesino ¡0 di una ridefinizione dot
pneche
lutei
le I
muc-1^ di alcuni punti della fei^siderati non negoziabili;
'■odiac-designati con il termine
Palgainentalismo, in riferimenB^odici pìccoli trattati ap' 'diversi, agli inizi del secolo, intie donne ^ The Fundamentais: a
fftinìony to thè Truth, che
inciavano i seguenti punti
pe- Non jlamentali: la nascita vergijrnp. Di |g del Cristo, la sua resurrenoranaa me corporea, la sua divinità
acrificio espiatorio della eroai lavori, la corruzione di tutta l’uma'delcò ita a causa del peccato di
ti alla lo- ^0, la seconda venuta imrispetto inente del Cristo, l’ispirazioxiarsial ¡verbale e l’inerranza della
iittura.
sui Gol Una reazione teologica,
fatto culturale, politica
Ivere sohi do\
perato aj
0 tipo 4i
a divenSt
radizioti
Ribet
SO
0
' intesoj
•o paal
li inteiu'
Ile unid
; i conte
e prop»
ongresso
ipo di re.
a, di
averso %
1 fondamentalismo proviene
li Usa, in cui si è sviluppato
Inizi del secolo come una
ice reazione: contro il libe10 teologico che i sostenii di questa corrente giudicamo infedele al messaggio bib, e contro la secolarizzarne della società americana
^ (he, per loro, minacciava le
Édamenta stesse delFAmerik 11 fondamentalismo può
(|Édi essere inteso come una
reazione alla paura.
Oltre afla dimensione teologica, àe resta centrale, si manilesta come una reazione moraalla depravazione
è necessario ritornare alla Bibbia, fondamento
eterno dell’America;
l’offiwssualità e l’aborto sono
ondannati con virulenza.
1 fondamentalismo comporre una dimensione cultuè stato, per lo meno agli
d, una protesta culturale
contro la modernità; si è fatto
notare in maniera particolare e è ancora il caso di oggi - per
una virulenta opposizione alle
teorie evoluzioniste, incompatibili con la lettera del messaggio biblico. In certi periodi ha
infine assunto una dimensione
politica, fra l’altro attraverso il
movimento della «Moral Majority» che si è fortemente impegnato per sostenére la candidatura di Reagan.
In Francia il fondamentalismo ha avuto un incremento
nel corso degli Anni 70, mentre si profilava la crisi economica e le ideologie del progresso erano meno dinamiche.
Esso appare come una reazione contro le «teorie del mondo», molto presenti nel protestantesimo ciel dopoguerra, in
cui è possibile ravvisare una rilettura teologica del profondo
cambiamento sociale che la
Francia ha conosciuto durante
le «trente glorieuses».
Ortodossia dottrinale
e esperienza religiosa
Teologicamente il fondamentalismo è innanzitutto una
ortodossia dottrinale che rifiuta
qualsiasi accomodamento nel
messaggio religioso con la cultura moderna. Ma insiste anche sull’esperienza religiosa
personale: un «vero» cristiano
deve essere passato attraverso
la conversione e «aver accettato il Signore nella sua vita».
Il fondamentalismo mantiene, di conseguenza, una relazione complessa, fatta di prossimità e di rifiuto, con i movimenti neopentecostali che attribuiscono un posto centrale
all’esperienza religiosa, quella
del parlare in lingue o dei doni
di guarigione in particolare.
Ciò che queste due aree
hanno in comune è una certa
difficoltà nel considerare la dimensione storica di qualsiasi
processo di fede e la convinzione che Dio sia a noi accessibile direttamente. Preconizzare una lettura letterale dei
testi biblici significa dimentica
narelii
Convegno Fdei interregionale
Italia centrala
3 i lava
jne dalli
i, in
dato e Í
ulterio
televisiS
dagogic
e doni*
:omplu
ta di db
itiva I
li e doli
delle dii
j profoi
testini
lei pop
±Ì)
)
fino, s'J
menta
lo
jblicazi^
i è tenuto a Roma il 28
settembre, presso la
chiesa luterana di via
*aana, il convegno interre®ale della Fdei dell’Italia
Mrale; erano presenti le
^presentanti delle varie
battiste, metodiste, valI luterane, anglicane e del
migranti» di La|Abruzzo e Umbria. Dopo il
Fa, tenuto in lingua tedesca
¿lingua italiana, presso la
™tà luterana, il convegno
"io introdotto dalla relaziouella segretaria uscente
ita Van der Veer che
bato il lavoro fatto dalla
"agli impegni futuri.
fOpo il pranzo sono stati
ùntati i risultati della 2tnt di Graz dalla presi‘^^i, Doriana Giudici; le
Idedi Vaccaro e Maria
iJ^ii hanno esposto l’una
lupetti di preghiera e liturgi
re la loro iscrizione in una cultura e in un’epoca precise e
pretendere che, nella lettura,
si possano mettere da parte i
secoli che ci separano da essi.
Parimenti, nell’esperienza spirituale, il credente pretende di
inserirsi in un rapporto diretto
con Dio.
Principio protestante
e sostanza cattolica
Nelle posizioni fondamentaliste si riconoscono certamente
alcune affermazioni teologiche
tradizionali del protestantesimo. 11 sociologo J.-P. Willaime
si spinge fino ad affermare:
«Se il fondamentalismo rappresenta una sensibilità particolare nel protestantesimo, si può
anche dire, attribuendo al termine “fondamentalismo” una
accezione più vasta e non storica, che il protestantesimo,
con la sua affermazione della
Sola Scriptura è un fondamentalismo, nel senso che vuole
affermare il fondamento scritturale della fede cristiana e attenersi a questo fondamento
contro qualsiasi affermazione
che appaia divergente». E prosegue subito: «Ma bisogna allora aggiungere, nello stesso ordine di idee, che il protestantesimo è comunque un liberismo
(libero esame e relativizzazione
dei magisteri ecclesiastici, teologici e morali). Quindi è la
tensione fra un certo “fondamentalismo” e un liberismo
che è costitutiva del protestantesimo». Sarà sicuramente necessario esaminare alcune delle grandi affermazioni della
Riforma per tentare di comprendere in che cosa possano
favorire il fondamentalismo e
in che cosa, al contrario, vi
oppongano resistenza.
Ma stando a Tillich, il protestantesimo non è caratterizzato in primo luogo da un corpo
dottrinario; è piuttosto un processo, un «principio» che Tillich definisce opponendolo alla
«sostanza cattolica». Se il cattolicesimo ha la tendenza a localizzare la presenza di Dio, a
materializzarla in «luoghi» sacri
(il pane dell’eucarestia, la presenza del sacerdote o del papa, l’istituzione ecclesiale), il
protestantesimo, al contrario,
tende a desacralizzare qualunque cosa, per meglio sottolineare la trascendenza di Dio e
ricordare che egli non è legato
neanche a ciò attraverso cui
vuole manifestare la sua presenza. In tale prospettiva ci si
può chiedere se il fondamentalismo, che fa della lettera della
Bibbia la Parola stessa di Dio,
non costituisca una certa «materializzazione» di Dio che lo
avvicinerebbe al cattolicesimo.
Ma bisogna anche interrogarsi: questo protestantesimo
in cui l’uomo non ha mai alcun
dominio su Dio, nessuna garanzia di poter entrare in rapporto con lui, non è troppo
difficile da vivere? D’altronde
Tillich pensava che in ogni religione fosse necessario un
equilibrio tra sostanza e principio. Il modo di procedere fondamentalista che consente
all’uomo una via d’accesso a
Dio sempre disponibile appare
più rassicurante!
Sola scriptura
Per i riformatori affermare la
Sola Scriptura era affermare la
priorità accordata ai testi biblici su qualsiasi altra autorità,
particolarmente su quella del
magistero che pretendeva di
controllare la lettura e l’interpretazione della Bibbia. Significava anche porre la Bibbia «in
posizione di origine e di referenza fondatrice», che sola
permette di accedere alla Parola di Dio. È possibile per
questo identificarla pienamente con la Parola di Dio?
I riformatori, ognuno a proprio modo, hanno preso le distanze da una simile concezione: la verità alla quale questi
testi rendono omaggio non è
comprensibile per l’intelligenza
umana. Per Lutero, la Scrittura diventa parola di Dio solo
quando, per opera dello Spirito, conduce a Gesù Cristo. Lui
ne è al centro, e ne resta la
chiave e il giudice. In un dibattito sulla giustificazione mediante la fede, Lutero si è spinto fino a sostenere: «Il Cristo è
il Signore della Scrittura e dì
tutte le opere (...). Tu fai forza
sullo schiavo, cioè sulla Scrittura. Quello sciavo io te lo cedo.
Io scelgo il Signore che è re».
Eppure è nella Scrittura che si
può cogliere la testimonianza
pura e originale dell’Evangelo,
è per suo tramite che possiamo scoprire Gesù Cristo come
una realtà salvifica che ci giustifica mediante la fede.
Quanto a Calvino, egli insiste sul ruolo dello Spirito che
solo può trasformare la Scrittura in Parola di Dio. Non può
esserci Parola di Dio senza il
supporto della Bibbia, ma neppure senza lo Spirito che fa
parlare la Scrittura per noi.
D’altronde Calvino come Lutero sono coscienti che i testi biblici, segnati storicamente,
possono essere compresi solo
attraverso un lavoro di interpretazione rigoroso. Per questo lavoro hanno utilizzato tutti
i metodi che la scienza
dell’epoca metteva loro a disposizione, precorrendo l’esegesi moderna. Pare quindi difficile avvalersi della loro autorità per esaltare una lettura letterale dei testi biblici.
La chiesa
Stabilendo una distinzione
fra l’istituzione ecclesiale, chiesa visibile e la chiesa invisibile,
corpo del Cristo, la Riforma
ha comportato una desacralizzazione e una relativizzazione
dell’istituto ecclesiale. Per la
teologia protestante è il rapporto del credente con la parola di Dio che determina il
suo rapporto con la chiesa, e
non il contrario.
Una tale concezione della
chiesa evita le derivate integraliste che può conoscere il cattolicesimo, come pure il dominio di una minoranza sull’interpretazione dei testi biblici. Può
tuttavia presentare due rischi:
Una lettera aperta alle unioni e gruppi femminili
Via ai convegni ragionaii
ci e l’altra il «duro» lavoro dei
delegati all’Assemblea. È risultato dal quadro fatto dalle tre
relatrici che anche se alla fine
l’Assemblea ha stilato un documento in cui «le chiese riconoscono di aver peccato contro
le donne», la strada che ci attende è ancora molto lunga e
difficile, ma, come tanti sassolini formano una valanga, così
con la perseveranza e, «sempre e solo» con l’aiuto del Signore, le credenti saranno capaci di superare ogni ostacolo.
È stata eletta all’unanimità la
sorella Claudia Claudi (già impegnata nel lavoro della Fdei e
della chiesa di Forano) segretaria regionale: sarà coadiuvata
dalle sorelle di Roma Margherita Battaglia, della Chiesa luterana, Gloria Preite, battista della Chiesa della Garbatella, Piera Troja della Chiesa valdese di
piazza Cavour c dalla sorella
Elsa Antonelli, metodista di Villa San Sebastiano oltre che da
Vololona Andriamitandrina del
gruppo donne migranti.
Prima della chiusura la presidente Fdei ha esortato le presenti a studiare i documenti di
Graz e a far partecipare a questi studi le comunità a cui apparteniamo. Momenti di comunione spirituale e di preghiera sono stati dedicati alle
genti delle regioni colpite dal
recente terremoto.
Giuliana Giammetti
Lettera aperta alle sorelle
della Fdei, in particolare, rivolta alle segretarie
regionali. Care sorelle, vorrei
qui ricordarvi i due articoli del
«Regolamento relativo agli organismi territoriali della Fdei».
Art.l - «Al fine del miglior
collegamento tra gruppi federati e per la trattazione di questioni di comune interesse,
viene convocato annualmente
(...) un Convegno dei gruppi e
delle unioni femminili aderenti
alla Fdei nell’ambito di una o
più regioni. Nel corso del
Convegno viene eletta una Segretaria regionale...».
Art. 2 - «La Segretaria Regionale ha il compito di raccordare l’attività dei singoli
gruppi o unioni (...) organizzando ogni anno un Convegno regionale...».
I convegni che si sono tenuti nei vent’anni di vita della
Fdei sono stati occasione di riflessione sugli studi proposti,
gli argomenti hanno riguardato i problemi della famiglia e
l’uso che abbiamo fatto della
natura che Dio ci ha affidato,
le tematiche relative a una ricerca della voce delle donne
nella Bibbia e quelle relative
alla pace e aH’ecumenismo.
Questi temi coinvolgono ancora tutte noi, dal Nord al Sud,
come abbiamo letto nelle relazioni dei convegni svoltisi in
Sicilia e nel Piemonte/Lom
bardia (v. Notiziario Fdei n. 4).
Il Comitato Fdei si augura
che questi convegni continuino a coinvolgere sempre più
sorelle. Proprio per una migliore conoscenza e per una
testimonianza comune del
maggior numero di sorelle del
mondo evangelico il Congresso del 1996 ha dato mandato
al nuovo Comitato di studiare
in quale modo ristrutturare la
Fdei affinché diventi un collegamento organico delle varie
realtà femminili evangeliche
presenti in Italia. Vorremmo
che la Fdei diventasse un luogo di incontro non solo di movimenti femminili organizzati,
ma anche di singole sorelle
che vogliono lavorare e riflettere insieme perché si sentono
unite da una stessa fede.
A livello nazionale il Comitato della Fdei ha già iniziato
questi contatti, ma desideriamo che sia anche la base a
sentire propria questa esigenza. Per questo motivo sarebbe
bene che fossero organizzati
convegni regionali ai quali invitare le realtà evangeliche locali esistenti sul territorio.
Qgnuna delle responsabili regionali è invitata ad indire questi convegni. Le componenti
del Comitato nazionale sono
disponibili a partecipare a questi incontri e a illustrare il nostro progetto, che non è quello di dare vita a una struttura
di «élite», ma è quello di creare
una rete di contatti e di scambi
tra donne evangeliche per un
cammino di comune testimonianza dell’Evangelo nella società di oggi.
Manca poco più di un anno
al Congresso straordinario (autunno 1998) e quindi è auspicabile che questi incontri si
tengano entro la prossima primavera. Il Comitato nazionale
vorrebbe avere un quadro preciso delle persone a cui fare riferimento, anche perché alcune responsabili potrebbero essere cambiate, e invita le unioni e i gruppi a comunicare il
nome della responsabile attuale e le iniziative prese.
Quello che ci sta davanti è
un anno di intenso lavoro, con
l’aiuto del Signore e la collaborazione di tutte voi ci auguriamo di poter organizzare un
congresso a cui partecipino
sorelle consapevoli e convinte
della nuova realtà che ci vogliamo dare come donne
evangeliche che testimoniano
in Italia.
A nome del Comitato Fdei,
buon lavoro a tutte.
Maria Grazia Sbaffi
quello di lasciare il credente solitario di fronte al testo, senza
una debita sollecitazione che
gli impedisca di assolutizzare la
sua lettura; quello di favorire le
scissioni che evitano di vivere il
difficile ma necessario apprendistato della differenza: perché
se la chiesa non è sacra, è
sempre possibile fondarne una
nuova con un gruppo di simili,
quando si è in disaccordo con
l’interpretazione dominante.
Mentre l’esperienza della differenza vissuta nel rispetto è così
preziosa per volgere uno
sguardo nuovo su Dio...
«Sola Grafia, sola fide»
Nel cuore della Riforma c’è
l’affermazione della giustificazione per grazia, che è stata
così liberatrice per Lutero: la
salvezza non dipende da ciò
che facciamo, è dono gratuito
di Dio che, in Gesù Cristo, ci
assicura del suo amore, ci riveste della sua giustizia e ci fa vivere. Nella fede, l’uomo può
rispondere all’appello di Dio e
lasciarsi trascinare verso una
nuova vita. A Dio spetta l’iniziativa di questo incontro, è
Dio che ama per primo; la
Grazia è sempre preminente,
la fede dell’uomo non è che
una risposta alla fede del Cristo. L’attribuire alla fede la
priorità, come fa in genere il
fondamentalismo, modifica in
profondità l’affermazione dei
riformatori: questo conduce a
valorizzare la rottura fra cristiani e non cristiani, e quindi a
una visione manichea del
mondo in cui il «non convertito» si trova necessariamente in
errore; conduce soprattutto a
sottolineare l’azione dell’uomo
con il rischio di determinare un
nuovo legalismo.
L’inquietudine che, da una
parte, è all’origine dei fondamentalismi, trova certo là più
una fonte di alimentazione,
che non di rassicurazione. Mi
sembra che soltanto l’affermazione molto forte della Sola
Gratta possa liberare l’essere
umano da questa inquietudine.
Sostenendo che siamo costruiti da Dio, ci esime dall’obbligo
di costruirci da soli. Proclamando «un Dio che ci è favorevole», ci invita a trovare la
nostra sicurezza nell’abbandonarci nelle mani di Dio, piuttosto che nel cercare di racchiuderla nella Bibbia per acquisire
un dominio su di lui.
In ogni radicalismo religioso
c’è un bisogno di assoluto, il
bisogno che sia disponibile
qualcuno o qualcosa che ci faccia uscire dalla relatività che
caratterizza tutta la vita umana, specialmente in un mondo
cosi precario come il nostro.
Può darsi che la conversione
che ci è richiesta nel processo
di fede sia proprio quella di
staccarci dall’idea che potremmo avere un accesso immediato a questo assoluto, di rinunciare a qualsiasi dominio su
Dio per lasciarci incontrare da
lui quando meno ce lo aspettiamo...
L’affermazione della grazia
preminente, più forte delle nostre manchevolezze morali,
dottrinali o spirituali, potrebbe
costituire questo punto fermo
che ci consentirebbe di uscire
dalla paura e di accettare le incertezze del nostro tempo e
delle nostre vite.
Isabelle Grellier
(Faculté de Théologie
Protestante de L’Université
des Sciences Humaines
de Strasbourg)
traduzione dal francese di
M. G. Arena
Collaborate!
in forme diverse, come più vi piace, alla realizzazione dì una
mostra sulla violenza contro le donne, inviando il materiale
entro la metà di gennaio '98 alla Rei, Gruppo di lavoro per
il decennio, vìa Firenze 38, 00184 Roma
 12
12
PUG. IV
Kl©ira2[i(a^a^
Un mosaico multicolore, antico come il mondo, sempre in formazione
La spiritaalità dì noi donne
componenti
Comitato
nazionale
Non amo parlare delle
donne come se esistesse un universale
femminile che ci accomuna
tutte. Noi donne ci siamo accorte sperimentandolo sulla
nostra pelle in modi diversi,
che gli universali cancellano le
differenze, omogeneizzano e
trivializzano le identità e soprattutto, sono solo delle visioni di parte e parziali che qualcuno spaccia o ci impone come realtà oggettive. Non posso parlare di donne e spiritualità senza prima riconoscere
l’impossibilità e il rifiuto di offrire un quadro generale di facile appropriazione.
La spiritualità delle donne è
un mosaico multicolore, antico
come il mondo ma sempre in
formazione, composto da pezzi di forme ^ materiali e misure
differenti. E inutile cercare di
studiarlo allontanandosi e cercando di cogliere un’impressione generale, un colore o un
disegno dominante. La sua
bellezza e la sua natura stessa
stanno in questa irrididucible
molteplicità. Non fidatevi di
chi vi offre una facile chiave di
lettura: non potrà essere che
una visione parziale e di parte.
Però potete avvicinarvi soffermarvi su un’immagine in particolare, e studiarne i tasselli più
da vicino.
Se ci avviciniamo alla sezione che è stata ed è prodotta
dalle donne cristiane possiamo
già perderci in una moltitudine
di immagini e colori: dalle donne della chiesa antica, alle mistiche medievali, alle donne
delle comunità di base in Ame
rica Latina. La diversità di queste sorelle di fede non consiste
solo nella scelta di espressioni
di fede differenti, ma anche
nell’adesione e nella produzione di teologie differenti.
L’immagine del mosaico si
concretizza ai miei occhi ogni
volta che incontro altre sorelle
di fede di contesti differenti
negli incontri ecumenici, nelle
università teologiche, nelle
chiacchierate occasionali alla
fermata dell’autobus. Mi basterebbe uscire sul pianerottolo e
chiamare le mie vicine di casa
a raccolta: cattoliche, protestanti, ortodosse, e «in ricerca». Studiamo teologia nella
stessa Facoltà, siamo amiche,
condividiamo la passione per
la lotta contro la violenza e la
discriminazione nei confronti
delle donne, a volte condividiamo momenti di culto, ma
ognuna di noi si riconosce in
una particolare tradizione e vive la propria spiritualità in
modo diverso.
Ho avuto un’esperienza analoga partecipando a un progetto della Società europea delle
donne teologhe (Eswtr). A
quindici donne europee è stato
chiesto di scrivere un articolo
sulla propria spiritualità; i Vciri
articoli sono ora stati pubblicati in un libro, un piccolo tassello per il nostro famoso mosaico (Re-Visioning Our Sources Women’s Spiritualities in European Perspectives). E anche in
questo caso, ci siamo ritrovate
con quindici storie, quindici
modi diversi di vivere la propria fede: di incarnarla in culture, tradizioni, situazioni so
cio-politiche diverse. Dopo
questa mia apologia delle differenze, mi è ancora possibile
parlare di una spiritualità delle
donne? Nonostante tutto, io
credo di sì. Anzi, credo che solo quando siamo consapevoli
delle nostre differenze, possiamo parlare delle cose che ci
accomunano. Quindi vi offro
alcune osservazioni e spunti di
riflessione, ricavate dalla mia
particolare esperienza di italiana trapiantata a New York, di
pastora valdese a continuo
contatto con donne di culture
e tradizioni di fede differenti.
Mi viene in mente una frase
della sorella africana Marianna
Ba: «Si odono grida dappertutto; ovunque, nel mondo, si
odono grida di donna. Le grida
sono molto diverse, ma c’è ancora una certa unità». Per prima cosa mi sembra che ovunque le donne stiano acquistando maggior visibilità. Le donne
si stanno facendo sentire, usano quella voce che è stata per
tempo zittita o relegata a particolari contesti. E quello che mi
pare di sentire da un numero
sempre crescente di donne, in
ogni angolo della terra, è una
sorta di «basta!» universale gridato a piena voce o timidamente sussurrato.
A che cosa stanno dicendo
basta queste donne? Certamente ad ogni tipo di violenza
contro le donne. Ma anche ad
avere gli uomini come intermediari tra se stesse e la fede
la teologia, la spiritualità. Basta anche alla propria complicità e passività, die per troppo tempo ha lasciato che la
Graz; in caleidoscopio le esperienze delle donne
Briciole di lavoro di grappo
Durante la 2- Assemblea ecumenica europea di Graz ho partecipato a uno dei lavori di
gruppo, come delegata metodista, sul documento base.
Complessivamente ho condiviso una esperienza «forte» che,
partendo dal momento iniziale
della preghiera, del canto e
della riflessione sulla Parola, è
stata scandita durante la giornata nel dialogo e nella ricerca
comune.
Non sempre il dialogo è stato agevole: su punti scottanti,
come a esempio il ruolo della
donna nella società e nella
chiesa oppure l'evangelizzazione aH'interno di paesi già di
tradizione cristiana, si sono
manifestate diversità rilevanti.
Entravano in gioco modi di
sentire e di vivere la propria
esperienza di fede legati strettamente al contesto storico,
culturale e politico nel quale si
vive. Le diversità le ho avvertite come un unico con le tante
storie dei partecipanti e, come
in un caleidoscopio, rivelatrici
di un mondo variegato ed unificato. nello stesso tempo, nella
convergenza verso il Padre.
Scorrendo le mie note prese
in quei giorni, la mia attenzione si ferma su alcune problematiche. La «querelle» sul proselitismo nell'Europa orientale
è stata ripresa con fermezza da
parte ortodossa a dimostrazione che il problema non è risolto nelle relazioni ecumeniche.
Ho colto una semplificazione
di esso quando non si approfondiva la distinzione tra
proselitismo che cerca di conquistare con
mezzi finanmmMt ■ zi a ri o pro
■ M pagandisti
ci membri
— di un’altra
confessione
e evangelizzazione. Rimane da
chiarire la relazione esistente
fra il concetto ecclesiale di territorio canonico (specifico delle
chiese ortodosse e di quelle romano-cattoliche) e il diritto alla
libertà religiosa.
In questo contesto manca a
tutt'oggi una convergenza ecumenica sul mandato missionario nelle chiese all’interno di
paesi aventi già una «tradizione» cristiana. Più volte ho
ascoltato testimonianze sulla
spiritualità cristiana. Da parte
ortodossa, insieme al riferimento alla preghiera e alla
meditazione, si è insistito
sull’importanza di utilizzare,
come luogo privilegiato ecumenico, il monastero. 11 monastero consentendo di trovarsi
insieme, separati e liberati in
un certo senso dalle «vanità
del mondo», coinvolge i credenti in un rapporto più intenso e pregnante con Dio mediante il silenzio, la riflessione
biblica e la preghiera.
Soprattutto nella riflessione
biblica si allargano gli orizzonti
della nostra comprensione da
un lato dell’amore di Dio e
dall'altro delle sue ricchezze
che si esprimono nella diversità dei doni elargiti e delle testimonianze sollecitate in noi.
La necessità di riflettere insieme sulla Parola è emersa
nell’esame di altri punti del documento base. È stata ricorrente la convinzione che la diversità nell'interpretare la Parola ci arricchisce e si spinge,
mediante l'assistenza dello
Spirito, ad attualizzarla nei nostri «contesti vitali».
«Confessiamo davanti a Dio
che esiste ancora nelle nostre
chiese e nelle nostre società un
atteggiamento indegno nei
confronti delle donne» (dal Documento finale A16). L’affermazione è chiara e prima che
spiritualità delle donne fosse
definita dall’autorità di un Dio
patriarcale «gestito» da élite
ecclesiastiche maschili fondate
su scritture, teologie e tradizioni scritte, tradotte e interpretate da uomini. Basta anche a
un linguaggio liturgico e teologico che sminuisce le donne,
che le relega a ruoli stereotipi,
che nega che il femminile sia
parte della realtà di Dio, e che
le donne siano create a immagine e somiglianza di Dio.
Spesso ho sentito dire che
questo tipo di discorso e proprio solo di gruppi di donne
intellettuali e benestanti, che
non hanno nessun altra preoccupazione nella vita. Non c’è
qualcosa di più falso. Certo
non tutte le donne pubblicano
libri sull’argomento. Ma ho ricevuto innumerevoli testimonianze del fatto che le donne
che si raccolgono per gli studi
biblici nei paesini rurali più isolati dell’Asia, dell’Africa e
deH’America Latina e parlano
proprio di tutto questo, certo
con linguaggi differenti. Perché la fede è un aspetto fondamentale della loro vita, spesso
della loro sopravvivenza, della
loro lotta per affermare la propria dignità e i propri diritti.
Come potrebbero lasciare che
gli uomini continuino ad usare
Dio, Gesù Cristo, la Bibbia e
le chiese come strumenti di
potere contro se stesse e le
proprie figlie?
Le donne rivendicano un
rapporto diretto con Dio riscoprendo e creando nuove immagini per parlare di Dio e
nuove liturgie, che incorpori
no le proprie esperienze di vita e di fede, le proprie lotte, la
propria fisicità. Celebrare Dio
con la totalità del proprio corpo, e non solo a parole, sta diventando un’esigenza per molte donne cristiane, che trovano tragicamente ironico che
una fede che ha al suo centro
l’incarnazione abbia tradizionalmente avuto un certo orrore per il corpo, soprattutto
quello femminile...
Certo i percorsi della spiritualità femminile sono diversi.
Alcune di noi non hanno più
nessuna intenzione di mettere
piede sulle strade spianate da
secoli di tradizione patriarcale,
e si avviano per nuovi sentieri.
Altre cercano di percorrere le
vecchie strade con uno spirito
nuovo, abbattendo ostacoli,
portando alla luce vecchie
trappole, componendo nuove
canzoni per la via, a volte scoprendo nuovi passaggi. Alcune
si aggirano un po’ confuse.
Molte di noi fanno un po’ tutte
e tre le cose. Alcune vogliono
viaggiare solo con altre donne,
altre pensano che i viaggi debbano essere compiuti in comunità di donne e uomini. Ma se
tutte camminiamo nel nome di
quel Dio che è amore, giustizia
e liberazione per tutte e tutti,
sono sicura che Dio sia con
tutte noi. Certo sarebbe bello
scambiarci i nostri giornali di
viaggio, le nostre esperienze e
le nostre canzoni un po’ più
spesso. Forse poi ci rimetteremmo in cammino con più
energia e più speranza.
Dorìana Giudici
presidente
via del Casaletto 385
00151 Roma
Emera Napoletano
vicepresidente
via Croce Rossa 34
90144 Palermo
Maria Grazia Sbaffi
segretaria
via Racagni 24
43100 Parma
Marina Bertin
tesoriera
via Olivet 12
10062 Luserna S.Giovanni
Tea Tonarelli
via Pomposa 19
44100 Ferrara
Elena Chines
via Casalaina 32
95126 Catania
Margherita Greetje
Van Der Veer,
rapporti con
Amnesti/ International
località Toppito
67060 'Villa San Sebastiano
(L’Aquila)
Lidia Ribet
responsabile per la GMP
via Assietta 4
10069 Villar Perosa (Torini
Daniela Ferraro
responsabile per la stami
via S. Pio V 15
10125 Torino
f a iiiont
|;loogo f
ile più di'
0va itoti
ijglla sto)
^aeper 1
cessione
IMale
ica
allearti
I dunque
libile £
di un
le Pian
\rmanc
iiale qua
Ita», teni
Le
jizzate p<
li
dabi
Mo:
inde fiu:
¡piedi, s
jblico p
Irte modi
pea Filipp
Wlice.
OD si pu
il sobri!
d’ai
Gabriella Lettini
Le lotte delle donne all'Assemblea ecumenica
fosse sancita nel documento,
l’ho colta nella discussione del
gruppo: la diversità circa il modo di rapportarsi alle donne,
anche a livello ecclesiale, era
ben presente in alcune testimonianze. Ho notato negli interventi riguardanti questa situazione, sensibilità assai contrastanti radicate nelle proprie
esperienze. Si conviene nel riconoscere che ogni atto di violenza contro le donne deve essere visto come una ferita al
corpo di Cristo. Non si riesce
però a determinare maggiormente uno spazio adeguato
per le donne aH’interno delle
comunità cristiane. La limitata
disponibilità degli uomini a
mettere in discussione seriamente i comportamenti legati
ai propri ruoli consolidati può
spingere le donne a ritenere di
dover vivere in una non riconciliazione.
Sono rimasta colpita dalla testimonianza di una sorella ortodossa che si sentiva pienamente realizzata nella situazione
esistente nella sua chiesa e tale
da escludere responsabilità di
tipo ministeriale. Ciò mi ha fatto riflettere che non solo gli
uomini hanno bisogno di
«muoversi» ma anche le donne.
Per esse la riconciliazione significa anche esprimersi in forma di contestazione per ricordarsi di non dimenticare le violenze subite o quelle in atto.
Come ultima impressione
posso dire che l’essere stata
inserita in un gruppo di lavoro, se mi ha portato a avere
una panoramica più ampia
sulla formulazione finale del
documento-base, mi ha anche
impedita, in parte, di fare
esperienze alternative che ritenevo importanti per me, come la frequenza al «atelier» e
«carrefour» proposti dal Centro delle donne.
Oltre ogni barriera
«Q
liiiàerà s
Pellicevco
McCbiiville
iicomamui
Anita Braschi
uesta assemblea ha
funzionato a vari livelli e ha posto
questioni importanti: chi è la
chiesa? La gerarchia? 1 delegati? O la maggioranza che ha
partecipato agli incontri informali e alle tavole rotonde?
Nei molti incontri e discussioni le donne hanno parlato dal
cuore delle loro esperienze nella società e nella chiesa. L’atmosfera amichevole del Centro
donne ha permesso alle donne
di parlare liberamente dei propri interessi, al centro dei quali
c’era violenza e esclusione contro le donne in tutti i paesi, tutte le classi e in quasi tutte le circostanze.
È stato messo in luce il fatto
che le donne che parlano della
loro esperienza hanno una più
ampia visione di una nuova società e di una nuova forma di
ecumenismo. Noi siamo qui in
questa dimostrazione fuori della
sala per le plenarie per rendere
visibile quello che è rimasto a
lungo invisibile. Le voci delle
donne hanno articolato i molti
desideri dello Spirito Santo alla
fine del XX secolo. Le chiese
ignorano queste voci a proprio
rischio e pericolo.
E divenuto molto chiaro nelle
nostre discussioni e durante i
vari incontri che non ci potrà
essere riconciliazione senza giustizia nelle molte aree in cui le
donne sono marginalizzate sia
nella chiesa che nello stato.
Finché le donne non sono libere nessun uomo lo sarà mai.
Date alle donne piena eguaglianza in tutte le chiese o la
credibilità di essere chiesa di
Dio è perduta.
• Le donne non vogliono essere messe da parte!
• Giustizia prima della riconciliazione!
• Ecumenismo? Chiedete alle
donne!»
Con la lettura di questa dichiarazione dal titolo: «Nessuna
riconciliazione senza giustizia!»
letta da Angelica Fromm con
un megafono da un palco improvvisato proprio davanti alla
sala delle plenarie dell'Assemblea è culminata la manifestazione delle donne del 27 giugno a Graz. Angelica Fromm è
la coordinatrice in Germania
del movimento denominato
«Stola viola» che da anni si batte per l’ordinazione delle donne al sacerdozio, ma con lei
c’erano molte altre donne, in
maggioranza cattoliche ma anche protestanti, decise ad
esprimere alle delegazioni ufficiali il proprio disagio, la propria vibrata protesta contro
quelle chiese che delle donne
fanno volentieri a meno, ovviamente quando si tratta di sedi
decisionali. E in effetti all’assemblea, mentre la presenza di
donne protestanti era ben visibile, qualificata e numerosa (e
negli interventi in plenaria questo si è ben notato) non si poteva dire la stessa cosa delle
delegazioni cattoliche e ortodosse, anzi. Cosi le donne hanno scelto l’arma della manifestazione pubblica per parlare
alle chiese e alla gente di tutta
Europa attraverso stampa e te
iacont]
F in vai ]
tgiunt
alla
i mo
iSOc:
intar
B£
ini:
.. L
Issate.
'Tacabai
litinerai
Bica pof
«Canti
tiativa
^ellice,
, di I
levisione. Oltre Angelica^ le, nell’
anche Elfriede Harth cooro jto gQjj,
trice del movimento “Nob ali. Fra j
mo chiesa» che in tutto il® Cca l’ei
do ha raccolto le firme in " n» dalla
re di una reale democra® g^n Gi(
zione della Chiesa cattoP otto :
Dorothea Nassabi, anch* lanouni
tedesca che attualmente^ Bicope
dina la rete europea delle imgotj
nizzazioni che in Europa s' la tecni
tono per la riforma della ¡^preved
sa cattolica. Dorothea Na^ Boding
stata la più fotogr®_| Ostile
e siala la piu - «me
dell'Assemblea, credo, J^inelj
violi iioosil > IL/lt C* ^ Vii V.’ HVi<X J
durante la manifestazione Soixii^e
va vestita da vescovo (o Pigligf
naie, non so) con una 9 WO lìrg
pancia (finta) e a chiunP pne ggj.
friva provocatoriamente^, Lusgj.^
mano da baciare. E
mano ua uaciaie. ^ r ««-“«O tl
vamo anche noi, le donn jl
testanti italiane,
non, divertite ma se®® ,
.solidali, perché le lo
donne devono aocorn , ®d6iM||
tutte ecumenicarnebi «inio,
ogni barriera confession
Fascicolo interno a WF®
40 del 24 ottobre
Pinerolo n. 'l’i'6/1991. f; " jj.
bile ai sensi di legge: ri
Edizioni Protestanti sr, .
Pio V n. 15 bis,
Stampa: Tipolitografie
riana - Mondovi.
 13
13
ì 24 OTTOBRE 1997
ilÄI
;tra conclusiva a Torre Pellice
ilonvìso re di pietra
E Eco Delle ^lli ^ldesi
Il patuà a Radio Beckwith evangelica
Moun pai, ma lèngo
PAG. Ili
MtRCO BESSON
, a montagna, da sempre
/luogo pieno di fascino e
[listerò, spesso mitizzata
upiù diverse culture, non
Iva non diventare nel corolla storia fonte di ispira
Ine per
iasione artistica dell’uo¿alla letteratura alla muJalle arti figurative.
È dunque pienamente comLsibile e condivisibile la
di una cornice naturale
le pian del Re per una
mance artistica multiple quale «Monviso re di
¡10», tenutasi lo scorso 13
jlio. Le foto delle opere
Rizzate per l’occasione, acjmagnate dai relativi proiti e da brani letterari dediti al Monviso o al Po, il
inde fiume che nasce ai
oi piedi, sono ora esposte al
Y , Jblico presso la Galleria
irte moderna e contempoica Filippo Scroppo di Tor^Pellice.
lon si può certo pretendere
r ■ iBeü sobrio ambiente di una
°™®leria d’arte abbia lo stesso
tal
stampjJ
®&*//
'■3
irre Pellice
via
cabanda
milnero sette
lÉierà sabato 25 ottobre
tei tempio valdese di Torre
Pellice,’TOn un concerto di
inglese del duo
violinista Tom
WcCojville e dalla suonatrice
Ji cornamusa Pauline Cato, la
iseitìiua edizione di «Tacaban',Ì8contri di musica popoin vai Pellice, organizzaiuntamente dall’assesalla Cultura della Comontana vai Pellice,
sociazione culturale
tarana» di Pinerolo,
[io Beckwith e dalle alinistrazioni comunali
ro Loco delle località
sate.
«Tacabanda» è una rasselitinerante di spettacoli di
®ca popolare sul modello
[«Cantavalli», l’analoga
dativa primaverile della
'Fallice, con proposte quadi respiro internazionelTottica di un con, dp con altre tradizioni muto «Noi ali, Fra ; musicisti stranieri
ud° E l’ensemble «EgschiMongolia (Luserf®'' Giovanni, 1° novem“E ’ Otto musicisti che pre’ .0 ttno spettacolo davve
^ j" i! m ^ l’originalità degli
0 ¡1 ®®uti e la particolarità
il ,J.*®onica vocale khomji,
! ’^oyode l’uso contempo
^ di registri acuti e bassi,
"°n conosce
“d°' ^ nel panorama della mutazione »occidentale
J IJgl'etto d’ingresso costa
■^Ulire ed - -----
igelica c;
una !
zhiunqc«
'delegò*
seria>"f
fine
e integrato in
.1. (Bobbio Pelli
E poic'|^Ìo7^ Lusernetta) da
No.
tt-adizionaie dopo il
’ \ Valdesi
corni"’*'®'-'
nenie
ssiona'®’
è
.^tci
'I Mille, 1 - 10064 Pinerolo
■d12l-323422;fax 323831
'^dazione Torre Pellice
'•0121-933290; fax 932409
Sped.
io abb. post./SO
I. con Riforma
Sf Rflft venduto separatamente
!5 J li legge Piera Egidi
^ Ghisieriana Mondovì
lina copia L,
. 2.000
Ila La
Sferspa
fascino del suo suggestivo
pianoro ai piedi del Monviso,
ma il materiale esposto riesce
comunque a rendere conto
delle linee guida dell’iniziativa. I progetti testimoniano una
ricerca, talvolta sofferta, della
giusta armonizzazione tra il
manufatto umano e la sua cornice naturale, tra gli spregiudicati stili dell’arte contemporanea e i millenari silenzi dei
prati e delle rocce. Risultato
ottenuto ora in modo sfumato,
con un accorto uso di quanto
offerto dall’ambiente, ora con
un effetto di maggiore rottura
(con il ricorso, ad esempio,
all’acciaio come materiale)
ma sempre rispettoso delle linee del paesaggio.
I racconti affascinano anche
per la loro varietà: vanno dal
commovente ricordo personale alla divertente notizia giornalistica inventata. Le poesie,
fra cui alcune in occitano, manifestano la forte presenza
della figura del Monviso
nell’immaginario degli abitanti delle valli da esso dominate. Il messaggio complessivo che sembra trasparire è
una nuova attenzione per una
funzione da sempre svolta
dalla montagna: essere punto
di incontro e non di divisione
fra genti diverse. Una montagna che assurge a ruolo di
veicolo di cultura, mediando
tra la semplice conservazione
statica dell’ambiente e la sua
riduzione a bene di consumo
turistico. La mostra sarà aperta fino al 26 ottobre.
JEAN-LOUIS SAPPE
Da alcuni giorni sono iniziate su Radio Beckwith
evangelica trasmissione in patuà. E un’iniziativa del Centro
culturale valdese finanziata
dalla Comunità europea sulla
base di un progetto denominato «Moun pai, ma lèngo». Un
gruppo di studiosi e ricercatori
delle valli Pellice, Chisone e
Germanasca ha infatti messo a
punto una serie di 23 interventi della durata di mezz’ora
l’uno che comprendono interviste su testimonianze di vita
(il lavoro, l’emigrazione, le attività ecclesiastiche), racconti
e leggende. In coda alla trasmissione, di volta in volta,
una breve rubrica musicale o
di cucina tradizionale, proverbi e modi di dire.
«Moun pai, ma lèngo» va in
onda il lunedì alle ore 9 e il
venerdì alle ore 17,30, con repliche rispettivamente al mercoledì alle ore 17,30 e al sabato alle ore 9, ed è rivolta in
particolare a «sensibilizzare le
giovani generazioni alla parlata del patuà», come dice il pastore Giorgio Tourn, responsabile del progetto. «Per svariate ragioni (avvento della televisione, modernizzazione
della vita, decremento demografico, urbanizzazione verso
il fondovalle e soprattutto
molto diffusa nelle famiglie
valdesi che la lingua “bassa”
penalizzi i suoi parlanti) la comunicazione in patuà ha subito una flessione importante.
specie negli ultimi anni, per
cui sono pochi i nuclei che
praticano ancora il dialetto»,
prosegue Tourn.
Il progetto prevede anche
interventi formativi nelle
scuole delle valli Chisone e
Germanasca, portati avanti da
«Conteurs», a loro volta formati in anni recenti con due
corsi di aggiornamento promossi dal Centro culturale,
che hanno coinvolto 4 giovani
disponibili all’iniziativa. Questo secondo ramo del progetto
«Moun pai, ma lèngo» si concretizzerà con la realizzazione
di un video dal titolo «E mi
countiou, mi countiou» (e io
racconto, racconto) che visualizzerà un racconto scelto tra
quelli maggiormente graditi
dagli alunni.
Un’iniziativa dunque lodevole quella del Centro culturale, anche se dall’esito incerto.
Le statistiche dicono che
quando una lingua non viene
più parlata che da un ristretto
numero di persone è destinata
inevitabilmente a scomparire.
Occorrerebbe un’inversione di
tendenza, difficilmente ipotizzabile in un momento in cui la
cultura dominante è quella che
passa attraverso i media, che
massificano e omogeneizzano
tutto. Se non altro l’abbondante materiale raccolto (oltre 20
ore di registrazione) resterà a
testimonianza di una lingua e
una cultura che hanno formato
decine di generazioni, ma che
oggi, anche per colpa nostra, è
perlopiù svilita e sottostimata.
VOLLEY: SETTIMANA
POSITIVA PER IL 3S
Settimana positiva per le
formazioni del 3S impegnate
nei vari campionati giovanili
di pallavolo: tutte le squadre
hanno infatti vinto le rispettive partite. Nel campionato ragazze successo contro il Cavour per 3-0; fra le juniores
successo a Rivalla per 3-2 al
tie break. Vittoria anche per i
ragazzi ( 3-1 sul Valli di Lanzo) e per gli juniores (3-0 sul
Caluso).
TENNIS TAVOLO: PRIMA
BATTUTA D'ARRESTO
Prima battuta d’arresto per
la Valpellice in C2; priva di
Malano la squadra ha così
perso Timbattibilità. Non sono
bastati i 2 punti di Sergio Chiri e uno ciascuno di Migliore e
Piras per battere il Rivoli che
si è imposto per 5-4. Importante affermazione invece per
la squadra di DI che ha giocato la prima partita di campionato a Torino contro il Cus; il
successo, per 5-4 è arrivato
grazie ai 3 punti di Giuliano
Ghiri e a quelli di Alberto Picchi e del nuovo acquisto Fabrizio Agaliate, l’anno scorso
in forza al Fiat Torino. Venerdì 24 inizia anche il campionato di D2 (la Valpellice di
Peracchione, Girardon e Mazzaglia nutre ambizioni di promozione) con una trasferta a
Moncalieri. Sabato 25 a Torre
Pellice la C2 affronterà l’iveco e la DI l’Arca Enel.
PINEROLO
venerdì 24 ottobre
All'auditorium comunale,
alle 21, «Italiani e protestantesimo: un incontro
impossibile» (Claudiana,
1997), presentazione del
libro di Giorgio Tourn,
con la partecipazione
dell'autore, di Gianni Vattimo e Vittorio Morero.
TRIATHLON DELLA
VAL D'ANGROGNA
Bella giornata autunnale per
la 16® edizione del «Triathlon
della vai d’Angrogna» disputatosi domenica 19 sul tradizionale percorso in tre frazioni: skiroll, bicicletta e corsa a
piedi. Il successo è andato a
Mauro Bonnet, Willi Bonato
e Massimo Garnier davanti a
Andrea Bertin, Christian Zancanaro e Davide Bonansea.
Nella prova femminile il successo è andato a Antonella
Chiavia, Germana Rosani e
Federica Bertin davanti a Katia Di Buono, Daniela Bonnet
e Èva Depetris. Fra quanti si
sono cimentati nella prova individuale nelle tre specialità,
il successo è andato a Remo
Garino davanti a Fabrizio Malan e Marco Grassi.
CORSA SU STRADA
Molti atleti del Gs Pomaretto, nella corsa su strada di San
Francesco Al Campo di domenica 19, hanno ottenuto un
piazzamento da podio o addirittura la vittoria; Monica
Ghigo è giunta 1® nella sua
categoria risultando così campionessa provinciale Uisp e 5®
assoluta, Valentina Richard
(Cadette) è giunta prima sia
nella classifica assoluta che
fra le Uisp e ancora, prima
Uisp e assoluta, Ivana Roberto fra le Allieve. Fra i Cadetti
Andrea Barrai è giunto 2° nel
campionato Uisp e Ezio Sola
è stato primo nel campionato
Uisp e 2° assoluto; 4° in questa gara Cristiano Micol.
CALCIO: PERDE IL LUSERNA
È andata male invece al Luserna che il prima categoria è
stato battuto in casa dell’Olmo per 2-0, al Barge, sconfitto in casa per 2-0 dalla Doglianese e al San Secondo battuto in casa per 2-1 dal Cornegliano. Nel torneo Aics, il
Collegio valdese ottiene la seconda vittoria grazie a due reti
ciascuno di Benech e Bellion.
HOCKEY GHIACCIO:
PER LA VALPE
ESORDIO VINCENTE
Esordio vincente per THockey Club Valpellice nel campionato di serie B di hockey
su ghiaccio. Opposti in trasferta sul campo di Zanica alle Civette Milano, i valligiani
hanno sempre avuto in pugno
rincontro, anche se la prima
rete è giunta solo dopo un
quarto d’ora ad opera del torinese Andrea Doglio. La Valpe gioca bene in attacco, giostrando a tre linee, ma deve
comunque ringraziare il portiere Tovo che para tutto. Nella seconda frazione raddoppia il neoacquisto valdostano Hermes Sbicego e al 35’
Claudio Marchetti porta le reti
dei biancorossi a tre. La partita si fa un po’ nervosa nel terzo tempo, con i padroni di casa che capiscono di rischiare
molto; così, subito dopo il 4-0
ad opera del terzino Bassoli,
un battibecco fa stare la Valpe
in 3 contro 4. I lombardi realizzano con Fantin, ma è
l’unico cedimento della difesa. Negli ultimi minuti spazi
di gloria per Doglio (seconda
rete) e Filippo Barrato che
chiudono il risultato sul 6-1.
Sabato 25, ore 20,30, a Torre
arriverà il Chiavenna uscito
battuto dal campo di Como al
primo turno; si annuncia il
gran pienone di pubblico.
PRIVATO acquista mobili vecchi-antichi e oggetti
vari: tei 0121-40181.
ACQUISTEREI XX volume «Oeuvres complètes», di
Victor Hugo, Paris. Telef.
Merlo 0121-91638.
AFFITTASI Torre Pellice,
zona ospedale, minialloggio
arredato (cucina, camera, bagno). Per informazioni telefonare al 0121-954478.
23 ottobre, giovedì — ANGROGNA: Alle 21, alla biblioteca comunale, incontro dibattito
sul tema «Un progetto per la costruzione di asili in Palestina», a
cura dell’Associazione pace Val
Pellice.
23 ottobre, giovedì — PINEROLO: All’ osservatorio astronomico «Luigi Vignolo», via S.
Antonio 3, alle 20,30 serata osservativa organizzata dal Circolo
pinerolese asuofili Polaris.
24 ottobre, venerdì — PINEROLO: Al Teatro-incontro
alle 21 «La “Giovane montagna”
di Pinerolo», cori e proiezioni di
montagna nel 70° anniversario di
fondazione con la partecipazione
della Badia corale vai Chisone.
24 ottobre, venerdì — TORRE PELLICE: Alle 20,45 nella
sala della Comunità montana vai
Pellice il gruppo studio Val Lucerna presenta la conferenza di
Umberto Levra «Il Risorgimento
e i suoi miti».
24 ottobre, venerdì — TORRE PELLICE: Alle 21 al cinema Trento la compagnia «Arteviva teatro» presenta «Il berretto
a sonagli».
24 ottobre, venerdì — VIETAR PEROSA: Presso la scuola professionale Agnelli per il
corso di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado di
scuola dalle 14,30 alle 17,30 visita guidata al complesso del
Forte di Fenestrelle.
24- 25 ottobre — TORRE
PELLICE: Alla «Bottega del
possibile» incontro seminario
sul tema «Il consorzio di Comuni e la Comunità montana per fare insieme una politica di domiciliarità».
25 ottobre, sabato — PINEROLO: Alle 9,30 all’Hotel Cavalieri si svolge un seminario organizzato dal consorzio Acca sul
tema «Gestione, tutela e uso delle risorse idriche, legge n.36 del
5/1/94 e legge Galli».
25 ottobre, sabato — BOBBIO PELLICE: Nel tempio valdese, alle 21, serata di canti popolari organizzata dal coro Valpellice con la partecipazione del
coro Capo Mele di Laigueglia.
25 ottobre, sabato — ANGROGNA: Alle 21, nella chiesa
di San Lorenzo concerto del coro
La draia e del Coro Rocciavrè di
Bruino; nell’intervallo presentazione delle nuove pubblicazioni
del Centro di documentazione.
25 ottobre, sabato — PINEROLO: Al Teatro-incontro alle
20,45 per la XII rassegna di teatro dialettale «’1 sindich éd Vaisomara» commedia brillante in
tre atti di Tancredi e Milone, con
la compagnia «Ij Camola» di
Giaveno. Ingresso lire 13.000.
25- 26 ottobre — PRAROSTINO: Il Moto Club Gentlemen’s Pinerolo organizza il XIV
Trial motociclistico dei pionieri
con moto d’epoca.
26 ottobre, domenica — ANGROGNA: Festa di Pradeltorno: alle 12,30 pranzo a base di
ricette tradizionali della vai
d’Angrogna (prenotazioni entro
il 24 al 944101); alle 15 balli occitani.
26 ottobre, domenica —
TORRE PELLICE: Alle 12,30
tradizionale pranzo presso la
Foresteria valdese per ex allievi
del Collegio valdese e rispettive
famiglie; sarà festeggiata la IV
ginnasio 1946-47. Alle 14 assemblea dei soci. Prenotarsi
presso il Collegio tei. 91260;
costo previsto lire 25.000.
27 ottobre, lunedì — PINEROLO: Alla scuola elementare
Parri, via Rocchietta, si svolgerà
alle 17 il primo incontro del corso di aggiornamento Lend per
insegnanti elementari sul tema
«Basi teoriche», con Maria Colombo.
28 ottobre, martedì — ANGROGNA: Alle 21 a San Lorenzo. nella Sala unionista, incontro con Carlo Vicentini,
scrittore, testimone della guerra
di Russia.
30 ottobre, giovedì — ANGROGNA: Alle 21 a San Lorenzo, alla biblioteca comunale,
dibattito sul tema «Quale futuro
per i piccoli Comuni?».
AGAPE — Assemblea degli
amici e delle amiche di Agape
dal 31 ottobre al 2 novembre.
I CIRCUITO — Cercasi televisore a colori per attività giovanili nel 1° circuito.
Ili CIRCUITO — Venerdì 24
ottobre alle 20,30 a Frali assemblea di circuito sul tema
«Prospettive per il lavoro giovanile nel 3° circuito».
MUSEI E LUOGHI STORICI
— Si svolgerà a Pinerolo martedì 28 ottobre alle 15 presso
la sala delle attività della chiesa valdese in via dei Mille l'assemblea del Coordinamento
musei e luoghi storici valdesi.
ANGROGNA — Domenica
26 ottobre, nella sala, assemblea di chiesa con all'odg i lavori sinodali, limitatamente ai
temi della cultura e del centocinquantenario dell'emancipazione valdese; gli altri temi
saranno trattati dal pastore
nel corso delle riunioni quartierali. Martedì 28 ottobre alle
20,30 riunione quartierale a
Buonanotte.
LUSERNA SAN GIOVANNI
— Riunioni quartierali: lunedì
27 ottobre a Bricherasio, martedì 28 alle vigne, giovedì 30
a Fondo San Giovanni. Il primo ciclo di studio biblico inizia mercoledì 29 ottobre a cura del pastore Berutti sui libri
dei 12 profeti.
PERRERO-MANIGLIA —
Domenica 26 ottobre culto
unico a Maniglia alle 10 con
assemblea di chiesa di inizio
attività.
POMARETTO — L'Unione
femminile si incontra venerdì
24 ottobre alle 14,30 all'Inverso. Culto al Centro anziani venerdì 24 ottobre. Domenica
26 ottobre alle 10 assemblea
di chiesa per esprimersi sul secondo settennio del pastore
Sergio Ribet. 11 gruppo visitatori si incontra mercoledì 29
all'Eicolo grande alle 15.
PRALI — Domenica 26 ottobre alle 10 al tempio assemblea di chiesa con all'odg le
relazioni su Sinodo e Conferenza distrettuale, elezione di
nuovi anziani per Ghigo e per
Pomieri-Giordano.
PRAMOLLO — Martedì 28
ottobre alle 20 riunione quartierale per le borgate Ruata e
Bosi, mercoledì 29 alle 19,30
riunione quartierale per le
borgate Bocciardi e Sappiatti,
giovedì 30 ottobre alle 20,30
riunione quartierale alla borgata Pellenchi.
PRAROSTINO — Domenica
26 alle 9 culto al Roc, alle ore
10,30 culto a Roccapiatta. Lunedì 27 ottobre alle 20 al presbiterio inizio degli studi biblici: la prima serie di quattro incontri sarà dedicata al libro
del Deuteronomio.
RORÀ — Si cercano fotografie del 21 luglio scorso,
giornata dedicata al festeggiamento dei 150 anni del tempio, per metterle a disposizione del Concistoro e quindi
dell'archivio.
SAN GERMANO — Martedì 28 alle 20,30 studio biblico sul libro del Deuteronomio.
TORRE PELLICE — Riunioni
quartierali; martedì 28 ottobre
all'Inverso, venerdì 31 ottobre
agli Appiotti.
VILLAR PELLICE — Domenica 26, alle 10 culto con assemblea di chiesa sui lavori sinodali e sulle prospettive di
avere una sala nuova o la ristrutturazione dello stabile di
piazza Jervis. Alle 14,30, nel
prato del presbiterio, castagnata e giochi per bambini.
Riunione quartierale venerdì
31 ottobre alle 20,30 al Serre.
VILLAR PEROSA — Domenica 26 ottobre alle 14,30 incontro dell'Unione femminile
a Chianaviere.
VILLASECCA — Assemblea
di chiesa di inizio attività domenica 26 ottobre alle 10.
Riunioni quartierali: venerdì
24 ottobre alle 14,30 ai Trossieri, alle 20 a Serre Marco,
martedì 28 a Villasecca alle
20, mercoledì 29 alla 20 alla
Roccia.
 14
14
PAG. I V
La Qualità
diventa Rispamio!
DAVeNBIDl24
ESABA1025
parlare
tjylornoi
Jescriver'
¿Itivi e
^lor:
sud di Re
(i#ceUe
(0t8da5
¿ihala
&nou
‘iCe
¡isti
lateiapP'
ine sono
ilel’istitut
■'rii
i I
jitti ante
ospita la (
azze
p.0iltin
stiutturat
coUabora:
iioltie un
i|iiiȓ in n
fasore
unto ha fi
ill’inte
stdge ui
persone a
serfcità r
che ci ve
Ittaalf
dai salvia
l'elemen
l'istìtuto 1
 15
15
lì 24 OTTOBRE 1997
------------— Vita Delle Chiese ì
primi risultati della ristrutturazione dell'istituto G. B. Taylor di Roma
Anziani e giovani insieme
¡ff)ìgHoramenti apportati alla ricettività consentiranno di estendere il servizio di
assistenza a bambini e anziani e porteranno risultati di gestione più equilibrati
PAG. 7 RIFORMA
paäarß
dell’istituto G. B.
«lornon è un’impresa facilUché esso ha una storia
ii’nl74 anni; possiamo però
Vivere quali sono i suoi
Svi e come è strutturato.
Slor si trova nella parte
«dalRon^a- nel quartiere
- il complesso è for
rio da 5 edifici, ognuno dei
Si ha la sua storia. Due edi£no utilizzati dalla comuni Gentocelle che con il
Itro istituto ha un particolaieiapporto di amore; altri
juelono adibiti alle attività
i]ell’|tituto: il primo ospita la
Casa m riposo in cui sono alleati i nostri anziani, quasi
^i^utosufficienti; l’altro
ospita la Comunità educativa
jowlivono i nostri ragazzi e
lo^zze con i loro educato¡Tultimo dovrà essere rifturato nell’ambito della
^orazione bmv. Vi sono
ifte un campo da pallone,
jjUjnpo bocce e un parco in
tii^ostri anziani passeggiaèrendono il sole, deno«giardino di Edna HalÌin memoria di una noamericana che
Btoìia fatto per il Taylor.
All’Interno dell’istituto si
svolge un’attività operosa
do di dare assistenza a
anziane e di portare
ità nella vita di giovani
die ci vengono affidati dal
TritìÉiale per i minorenni e
daif^zi sociali. Sì, perché
felemento che differenzia
Fistituto Taylor da altre struttur^|iili è proprio il fatto
chej^anto a persone che
L’istituto Tayior a Roma
sono giunte ormai all’autunno della loro esistenza, noi
ospitiamo anche bambini e
bambine, che il magistrato,
in collaborazione con Tassistente sociale ci indirizza
perché siano sorretti e guidati in un passaggio così delicato della loro vita.
Tale peculiarità conferisce
un aspetto particolare alla
nostra esperienza perché la
convivenza in uno stesso ambito di due attività apparentemente così diverse ha conseguenze estremamente positive per le due categorie di
ospiti, e soprattutto per gli
anziani, tanto che anche il
nuovo progetto, che contempla il potenziamento della
struttura e il suo rilancio in
chiave di collaborazione fra
le chiese battiste, metodiste e
valdesi di Roma, prevede di
mantenere la fruttuosa com
presenza di giovani e anziani.
All’interno della struttura
sono stati ospitati nel 1996
ventotto anziani e ragazzi.
Attualmente i ragazzi sono
nove mentre la capienza della Casa famiglia è di 12 unità:
appena l’iter burocratico lo
permetterà accoglieremo altri bambini. Il numero degli
anziani assistiti, dai primi di
ottobre, in seguito a una serie
di nuovi ingressi, salirà a 38.
Ciò è stato reso possibile grazie ai miglioramenti effettuati
in ordine alla ricettività del
complesso e consentirà, con
un minimo aumento dei costi, anche un miglior risultato
di gestione.
L’istituto ha infatti avuto
negli ultimi anni momenti di
crisi sia economica che di gestione, che aveva sollevato
anche diverse critiche nell’ambiente evangelico (vedi
lettera a Riforma del 18 ottobre 1996). L’ultimo bilancio
era stato chiuso al 31 dicembre 1996 con una perdita di £
234 milioni. Oggi la perdita
sul conto economico al 31 dicembre 1997 è ridotta a meno di 60 milioni, e ci sono
fondate speranze (grazie
all’aumento del numero degli
assistiti) di portare a pareggio
il bilancio di fine anno. Naturalmente la preoccupazione
non è stata soltanto diretta a
sanare il bilancio, ma si è cercato soprattutto di rispettare
lo standard di vita esistente,
puntando piuttosto a migliorarlo e cercando di non turbare la vita degli ospiti.
In particolare, il piano seminterrato della Casa di riposo è stato completamente ristrutturato, creando un nuovo refettorio luminoso con
uscita di sicurezza, nuovi bagni per anziani e personale,
un bagno per disabili, una
nuova cucina e locali per lavastoviglie e altre modifiche
tecniche previste dalle leggi
vigenti di cui eravamo sprovvisti; il tutto naturalmente è
in linea con il nuovo progetto
bmv di ristrutturazione del
complesso. Siamo molto
contenti di dare ai lettori del
nostro giornale queste notizie, poiché il rilancio della
struttura ha riportato serenità e maggiori motivazioni
tra gli operatori dell’Istituto,
dando loro più gratificazione
e creando nuove aspettative.
(Gina Perres, Rosa Manfredi,
Assunta Cretarola, Adele Cristillo)
■Intervista a Paulo Pereira, calciatore che milita nelle file del Genoa
Un atleta che vuole vivere nelle vie del Signore
ERMimO PODESTÀ
scorso quasi un anno
da quando Pereira, atleta
Ito, dalla squadra porse del Benfica era stato
teduto al Genoa. Dopo un
0 contatto avuto un an
1 ora ci siamo conosciuti
e abbiamo fatto una
nuova chiacchierata.
Quando e perché ti sei
weriito?
*!o provengo da una famiiafevangelica e sono stato
dai miei genitori sexuado i principi cristiani.
a 15 anni mi ero allontanuioilalla chiesa, perché es*®do già diventato calciato’®P|sfessionista, avevo lanuto il Brasile e trovandomi
guida spirituale ero diindifferente alle cose
l'^gnore. Ma mio fratello
uus, anch’egli giocatore e
"uta di Cristo [che giocò anAiella Sampdoria e fu in?Ptato per La luce, ndr] mi
'U che al di sopra del deja successo e della gloniivl ^ e che solo lui
'[iflarci una gioia e una setali che non possiamo
da nessun’altra parq. I °.dato retta a lui e da
giorno il Signore è dilato la cosa più importanPUda mia vita, e spesso mi
Ssl ^ ^tii con le parole del
Uiitaf Signore, fam
™>^re nelle tue vie">>.
^^Ùafore di salto triplo
kì/g detto che non vopirci^'^^Stare di domenica,
tn*.^ ^ domenica è giorno
Wrato al Signore. Che co^Pensi?
dlé .*'.®°no d’accordo, perportiamo sempre il
iiichp^ nael nostro corpo. E
quando giochiamo la
libica, possiamo render. a, sentendolo vicino a
posso mi reco al culto insieme a sorelle e fratelli».
- Quali sono state le esperienze che in questo anno di
permanenza a Genova hai
vissuto come più significative
in campo spirituale?
«Tutti i momenti che ho
potuto trascorrere insieme
con altri credenti. Ma in modo particolare tengo a due ricordi. Il primo quando ho dato la mia testimonianza, dopo aver pregato e cantato,
nella chiesa evangelica di via
Digione, alla presenza di tanti giovani e adulti: in quel
momento mi sono sentito veramente uno strumento nelle
mani del Signore. 11 secondo,
quando un gruppo di evangelici è venuto a casa nostra e
tutti insieme abbiamo lodato
il Signore: ci siamo sentiti
uniti secondo la sua volontà».
- Quando segni un gol, come è successo contro la Lucchese, e il pubblico ti acclama, che cosa pensi?
«Ringrazio il Signore perché mi dà la forza di riuscire a compiere quelle imprese.
Io non mi esalto mai, tutto
è merito suo. Poi però anch’
io faccio festa con i tifosi,
perché so che quello che faccio io li rende felici, e allora è
giusto che partecipi con loro
di quella gioia».
- Che cosa vorresti fare
quando concluderai la carriera di calciatore?
«Se dovessi ritornare in
Brasile, vorrei dedicarmi a as
sistere i 300 bambini abbandonati, ospiti di una casa costruita e finanziata dalla mia
famiglia. Se invece dovessi rimanere a Genova vorrei dedicarmi all’evangelizzazione, e
seguire maggiormente le attività della chiesa, cosa che in
questo periodo non posso fare compiutamente. Vorrei
che si realizzasse quello che
dice Paolo (Filippesi3,13-14):
“Eratelli, io non reputo d’avere ancora ottenuto il premio;
ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso
quelle che stanno davanti,
proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della
celeste vocazione di Dio in
Cristo Gesù”».
•Nati
Uralmente quando
Incontro di evangelici fiorentini a Villa Aurora
A confronto sul rapporto con il cattolicesimo
PETER CIAVARELLA
IL pomeriggio del 5 ottobre
si è svolto a Firenze a Villa
Aurora un incontro fra gli
evangelici fiorentini. Lo scopo dell’incontro era quello di
confrontarsi sulla questione
dei rapporti con il cattolicesimo. Circa 45 persone hanno ascoltato gli interventi di
Rolando Rizzo, Mario Affuso,
Giuseppe Colbertaldo, Gino
Conte e Piero Bensi dopo
una breve premessa di Raffaele Volpe, coordinatore
dell’incontro che ha goduto
della simpatica moderatura
del past. Piero Bensi.
Dopo le relazioni i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esprimersi nel contesto di tre piccoli gruppi:
quello sul no, quello degli in
decisi, e quello sul sì, dopodiché i rappresentanti di ciascun gruppo (Roberto Pecchioli. Volpe, e Bensi) hanno
presentato all’assemblea una
sintesi della discussione
svolta nel proprio gruppo.
Nulla di nuovo è emerso
durante l’incontro e quasi
tutti erano d’accordo che nei
rapporti con i cattolici bisogna distinguere fra i rapporti
con i singoli cattolici e quelli
con la Chiesa romana come
istituzione. Certo c’erano
quelli appassionatamente a
favore dei rapporti con i cattolici a tutti i livelli e quelli
altrettanto appassionati contro i rapporti con la Chiesa
cattolica come istituzione.
Tuttavia si può dire che tutti
i presenti erano d’accordo
che qualsiasi dialogo auten
Monteruscello-Pozzuoli
Riconciliazione
fra le due chiese battiste
GABRIELA LIO
..~C eco quant’è buono e
\\ Pi quant’è piacevole che i
fratelli (e le sorelle) vivano insieme!». Bellissime le parole
del salmo 133, un poema breve eppure denso di significato letto e cantato tante volte
ma forse poco sentito nel vivere comunitario. La realtà
descritta dal salmista non
sembra molto frequente, e
quando c’è a volte si interrompe, forse per questo
quando la si ritrova è sentita
come una benedizione da celebrare con gratitudine. Domenica 14 settembre le comunità battiste di Pozzuoli e
di Monteruscello hanno
esperimentato questa gioia,
la bellezza dell’essere insieme, chiamati da Dio alla riconciliazione, dopo un lungo
periodo di separazione e di
rottura.
Nei locali della chiesa di
Pozzuoli-Monteruscello hanno celebrato il loro rincontrarsi, il loro ristabilire rapporti con un culto pieno di
significato attraverso testimonianze, canti, preghiere,
condividendo comuni ricordi del passato, commentando fotografie e anche un vi
deo sulla situazione di grave
disagio vissuta dai componenti le due comunità, un’
unica chiesa fino a pochi anni fa, in conseguenza del bradisismo che ha colpito Pozzuoli nel 1984.
Un’agape fraterna condivisa ha offerto l’occasione non
solo di ricordare il passato
ma anche di comprendere
l’attuale impegnativo compito di testimonianza comune
in aree distinte ma contigue
del territorio. Tanti progetti
ci attendono. Lavorare insieme con solidarietà reciproca,
«come nei campi delle famiglie seminomadi dell’Antico
Oriente», come è stato ricordato nella predicazione, affinché la benedizione di Dio
scenda su di noi per la vita
delle comunità e la vita di coloro che ci incontreranno.
La riconciliazione tra le
due comunità è diventata
concreta e visibile con la celebrazione della cena del Signore, a fine culto: è lì che la
nostra comunione con Gesù
è diventata anche la nostra
comunione. Subito dopo il
culto e l’agape di riconciliazione le due comunità hanno
iniziato un lavoro di evangelizzazione nell’area flegrea.
i membri delle due chiese battiste di Pozzuoli
tico con i cattolici deve potersi svolgere senza equivoci
sulla identità di ambedue i
partner.
L’incontro non si era prefissato di stendere un documento o di arrivare a una
presa di posizione dei protestanti fiorentini. Piuttosto
voleva essere uno spazio di
dialogo (magari primo di
una serie) per i protestanti di
tutte le chiese evangeliche
fiorentine. Alla fine della serata il coordinatore Volpe
non ha nascosto il suo disappunto sul fatto che così poche persone (e poche chiese)
avessero partecipato all’incontro e ha suggerito come
primo compito la riflessione
su quali possano essere i
motivi di questa scarsa partecipazione.
Chiesa evangelica valdese
(Unione delle chiese valdesi e metodiste)
Commissione di studio
per la diaconia
CORSO PER OPERATORI NEI SERVIZI E NELLA DIACONIA
Casa Cares, dal 24 al 29 ottobre 1997
Il corso di aggiornamento propone alcuni argomenti di particolare attualità sia nell'ambito della chiesa sia nell'ambito delle
relazioni con la società civile in un contesto di trasformazione e
di crescita del tessuto organizzativo e di tutela sociale.
L'identità del diacono e della diacona è un argomento ricorrente nelle nostre conversazioni e spesso anche nelle nostre assemblee. Non sembra sia emersa, fino a questo momento, una risposta completa e soddisfaciente, e forse è giusto così, ma ritornare a riflettere su questo tema partendo da una base teologica
può essere utile per aggiornare la ricerca. A questo tema si aggiunge uno studio sul principio dell'ubbidienza secondo la Bibbia
per dare concreti contenuti alla riflessione sull'identità e il ruolo.
Quale è il rapporto fra l'ordinamento valdese e l'ordinamento
statale? Il proposito è quello di metterne in evidenza gli aspetti
quotidiani dove le grandi battaglie ideali e di principio a tutela
della nostra libertà e autonomia devono confrontarsi con interlocutori spesso impreparati. In particolare la diaconia, ponendosi
in dialogo con le istituzioni, ha la possibilità di vivere in prima
persona questa esperienza dalla quale possono scaturire utili indicazioni per proseguire un dialogo coerente e costruttivo.
Il corso si rivolge, in modo particolare, ai membri dei Comitati e
al personale delle opere diaconali ma è anche aperto a tutti coloro che hanno interesse ad approfondire le tematiche proposte.
Programma
arrivo per cena e sistemazione
Luciano Giuliani: «La tutela delle persone»,
introduzione alla legge 675;
Adriano Longo: «La sicurezza e la salute dei
lavoratori», approfondimento di alcune caratteristiche della legge 626;
Giornata di apertura dell'anno di studio al
Cfd a Firenze;
culto presso la chiesa metodista, agape presso il Gouid;
prolusione di Ulrich Beyer: «Chiesa e diaconia nel 2000»;
riunione Commissione Diakonia;
Paolo Ricca: «La figura della diacona e del
diacono», dibattito/confronto su come è vista nel NT e nella tradizione;
mar. 28 ore 9 e 15: Daniele Garrone: «L'ubbidienza nella Bibbia»;
Franca Coisson: «Rapporti fra ordinamento
valdese e ordinamento statale: quando ubbidire, quando resistere»;
mer. 29 (matt.): continua Franca Coìsson;
ore 12,30: pranzo e partenza.
Per le iscrizioni rivolgersi a Casa Cares: tei e fax 055-8652001
ven. 24
sab. 25
ore 9:
ore 15:
dom. 26
lun. 27
ore 11:
ore 15:
(matt.)
ore 15:
ore 17:
 16
16
PAG. 8 RIFORMA
Vita Delle Chiese
VENERDÌ 24 QTTOBRf
Avanzata dalla Commissione spiritualità e liturgia della Federazione delle chiese evangeliche in Italia
Proposta per un nuovo innario-libro di preghiera
A quasi trent'anni dalla revisione dell'Innario cristiano, si fa sempre più urgente la produzione di un nuovo innario
E se questo contenesse anche una scelta di testi per il culto e la spiritualità? Sarebbe il primo «Prayer Book» italiano
Da più parti si sente l’esigenza di una revisione delrinnario cristiano pubblicato
dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei)
quasi trent’anni or sono (nel
1969) e, fra l’altro, quasi esaurito. Nei mesi scorsi il
Consiglio della Fcei ha discusso il problema dell’innologia evangelica, dando in
primo luogo mandato al
Gruppo per la musica evangelica (Grume) nominato
dalla Fcei stessa, di promuovere un convegno sull’innologia (che si svolgerà a Ecumene dal 25 al 27 aprile); in
secondo luogo è emersa l’esigenza di avviare la «produzione futura di un nuovo innario che contenga altresì
una opportuna scelta di testi
per il culto e la spiritualità
(Prayer Book)>> (delibera 125
del Consiglio Fcei), con la richiesta alla Commissione
spiritualità e liturgia della
Fcei di elaborare uno schema
di tale «innario-libro di preghiera». La Commissione ha
quindi elaborato un primo
abbozzo di indice dell’opera,
che è stato approvato nelle linee generali dal Consiglio,
con l’invito a diffondérlo ampiamente e a raccogliere osservazioni e suggerimenti. Lo
proponiamo qui di seguito;
insieme ad alcune schede su
pubblicazioni analoghe pubblicate dalle chiese evangeliche in altri paesi e attendia
mo i vostri contributi in merito al progetto.
Cantare, pregare
confessare la fede
Si propone che il nuovo Innario cristiano non sia una
semplice raccolta di inni ma,
sull’esempio di molti innari
stranieri (in particolare le
edizioni più recenti degli innari evangelici di area tedesca), contenga anche preghiere per varie occasioni e
confessioni di fede; un innario insomma che sia al tempo
stesso «un libro di preghiera»
(Prayer Book), un «libro della
fede» 0, se si preferisce, che
esprima la fede cantata, la fede pregata, la fede confessata.
La fede cantata
Non è competenza della
Commissione spiritualità e
liturgia esprimersi sulla parte
musicale; ci limitiamo quindi
ad alcune osservazioni generali:
- tutte le generazioni di
credenti devono essere rappresentate nel nuovo innario
(certo, non con tutto il repertorio); un innario cristiano è
una raccolta di testimonianze di «fede cantata» attraverso i secoli. Più che di eliminare, ci si deve preoccupare di
aggiungere, visto che rispetto
ad altri innari il nostro è di
dimensioni piuttosto ridotte
(303 inni contro i 669 della
La corale a San Germano Chisone
Chiesa luterana bavarese, i
512 della Chiesa riformata
ungherese, gli oltre 700 della
Chiesa luterana danese, ecc.);
- in linea di massima, si deve evitare di manipolare
troppo gli inni, soprattutto
dal punto di vista musicale;
può essere eventualmente
necessario un ritocco dei testi, soprattutto laddove essi
risultino scadenti sul piano
poetico o incomprensihili
per le nuove generazioni;
- desideriamo infine segnalare la versione italiana del
Salterio ugonotto realizzata da
Emanuele Fiume. È la prima
volta che vengono proposti in
italiano i 150 salmi in musica:
ci auguriamo che quest’opera, dopo essere stata esamina
ta e se necessario rivista da
persone competenti, venga al
più presto pubblicata.
La fede pregata
Il nuovo Innario cristiano
dovrebbe poi contenere una
raccolta di preghiere per varie occasioni, adatte all’uso
comunitario e personale. In
particolare pensiamo a; uno
schema di preghiera per la
mattina e per la sera, ed
eventualmente altri schemi
per brevi culti e per piccoli
gruppi, tenendo conto del
fatto che molti evangelici in
Italia vivono in situazione di
diaspora; un’edizione del
salterio «corale», cioè adatta
alla lettura unitaria alternata;
preghiere per i vari momenti
del culto: adorazione, confessione di peccato, ascolto
della preghiera, intercessione, battesimo. Santa Cena;
preghiere adatte ai tempi
dell’anno liturgico: Avvento,
tempo di Passione e tempo
pasquale, Pentecoste; preghiere di ringraziamento prima dei pasti; preghiere per
accompagnare i vari momenti della vita: nascita, gioventù, vita di coppia, scuola,
lavoro, malattia, morte.
La fede confessata
La terza parte del nuovo
Innario cristiano potrebbe
contenere una serie di confessioni e testimonianze della
fede, scelte non tanto su base
denominazionale, quanto
per il loro carattere di testi
ormai «classici» o per il loro
orizzonte ecumenico. La raccolta potrebbe essere divisa
in tre parti:
a) confessioni di fede della
chiesa antica: Simbolo apostolico: Simbolo niceno-costantinopolitano (nella traduzione dall’originale greco,
dunque alla prima persona
plurale e senza «fllioque»].
b) confessioni di fede e catechismi della Riforma: Confessione Augustana; Confessione Helvetica posteriore;
Piccolo catechismo di Lutero;
Catechismo di Heidelberg.
c) testimonianze di fede
contemporanee: Confessione di Barmen; Concordia di
Leuenberg; la «base» teolooi
ca del Consiglio ecumeni^
delle chiese; alcune «
«Voci
profetiche» del nostro temi
(a esempio le affermazioni
fede di Dag HammarskjoeS
e di Martin Luther King); ji '
cune confessioni di fedepn '
venienti dalle «giovani chL
se» del Terzo Mondo; tesa
monianze di giovani e
donne.
lina/i
0Ìtar
Un invito alla
collaborazione
Un innario è l’espressioi
di una fede vissuta dalla n
munità cristiana. Ritenii
quindi indispensabile il coi
volgimento delle chiese nd|
l’elaborazione del progetto,!
chiediamo la collaborazioi
fattiva degli esecutivi
chiese federate. Invitiamo ai|
che tutti i lettori a inviarci
loro osservazioni elelot;
proposte. In particolare voij
remmo avere reazioni: sull
impianto generale proposti
per l’opera; eventuali inte[
zioni o modifiche dello sci
ma, altri temi; proposte di
sti da inserire nello schema.
Vi preghiamo di indirizzi
le vostre reazioni a; Commi
sione spiritualità e litur)
Fcei, via Firenze 38, OOltj
Roma.
¡fronte
ìllam
, cl
isiasi i
jjconsi
efrattisti
jtivent
ire per
iersarit
jto, han
ìrimpres
me di e
jporta:
10 giunti
ite, Casi
Milan
.use circ
jielle, fi
Ite del
Pattina
ipo il ca
are Pao!
Jreve m
¡ve, inte:
ire e car
ala la teli
(a cura della Commism
spiritualità e liturgia
Federazione delle chi
evangeliche in II
íre del 1
lebattis
pittoliE
iiunelpi
ito, chi
_ li fra 1(
frStati'
le düese
imo agli
lia una p
le donn
toa la
jiioime cor
:iitaravali
L'uso delle risorse e il rapporto con gli enti pubblici in un progetto ideato nel settore dell'intervento sociale
Se lo Stato sociale langue la diaconia fiorentina rilancia
MAJA KÖNIG
GABRIELE DE CECCO
DRACCORDO... un titolo
un po’ presuntuoso,
ma dobbiamo forse languire
anche noi? Troviamo nel nostro lavoro di tutti i giorni segni chiari dell’attuale crisi
che, oltre e forse più che economica, è di progettualità e
di serietà politica in chi dovrebbe sentire la responsabilità per il presente e per il futuro. Ne abbiamo la precisa
sensazione nelle attese telefoniche in compagnia della
musica del centralino dei Comuni, Usi, ecc. Lo leggiamo
in faccia ai funzionari (disinteressati o impotenti), agli
«esperti» dell’oggettività di
bilancio che incontriamo in
luogo di chi è stato eletto per
operare scelte politiche. Speriamo con tutto il cuore di
sbagliarci, ma abbiamo l’impressione che, per un po’ di
tempo, se aspettiamo loro...
Cerchiamo al Gignoro, come immaginiamo faranno
anche le altre opere, di parlare di corretto uso delle risorse, di collaborazione con gli
enti pubblici nella ricerca delle reali situazioni di spreco, di
riqualificazione e differenziazione dei servizi... Ci viene ri
sposto con il linguaggio dei
tagli, sempre in emergenza,
spesso in allegra improvvisazione, non poche volte con
l’incompetenza di chi accumula così peggiori sprechi futuri, oltre a produrre guasti su
reti di servizi costruiti pazientemente negli anni.
Dice che è per entrare in
Europa; ma non si diceva una
volta che in Europa stanno
quasi tutti meglio degli italiani?... ma com’è che per stare
insieme ci tocca di peggiorare
ancora i nostri servizi? com’è
che intorno a noi girano automobili sempre più belle e
fiammanti mentre si stringe
sull’assistenza alla povera
gente? o siamo noi che non
capiamo di alta finanza? È
chiaro che non saremo certo
noi evangelici a rifiutarci di
allargare la nostra visuale per
confrontarci con una dimensione europea anche perché
questa dimensione, di per sé,
risponderebbe pienamente
alla nostra storia e alla nostra
mentalità. Ma com’è che troviamo sempre burocrati che
strumentalizzano anche questa svolta europeista, la sommergono di menzogne ai fini
interni, la interpretano funzionalmente alle necessità
dell’economia del profitto, la
Kifoema
ABBONAMENTI 1998
ITALIA
ESTERO
• ordinario £ 105.000 ■ ordinario £ 160.000
- ridotto £ 85.000 - via aerea £ 195.000
- sostenitore £ 200.000 - sostenitore £ 250.000
- semestrale £ 55.000 - semestrale £ 80.000
■ cumulativo Riforma + Confronti £ 145.000 (solo Italia)
Per abbonarsi: versare l’importo sul ccp n. 14548101
intestato a Edizioni Protestanti s.r.l., via S. Pio V 15 bis, 10125 Torino.
snaturano e la svuotano della
partecipazione dei popoli e
della loro reale rappresentanza. O siamo noi che non capiamo di alta politica?
Comunque sia, noi qualche
domanda sentiamo ormai di
dovercela porre: siamo sempre e comunque disposti (o
legati?) alle attuali forme di
collaborazione (a volte di
sudditanza?) con chiunque
guidi la politica sociale e
ovunque intenda guidarla?
Che sarebbe allora della diaconia come segno profetico?
L’Evangelo ci parla di un patto con Dio che si rinnova e
cambia, delTirmzione di un
Regno nella storia, di un’attesa escatologica che dà senso
al presente, del nostro prossimo come soggetto con noi di
nuove possibili relazioni. Siamo chiamati a vegliare e a
scegliere a chi e a cosa vogliamo essere fedeli e chi vogliamo servire. O siamo noi
che non capiamo di alta teologia? Eppure la diaconia
evangelica ha seguito in Italia
un percorso che ha cambiato
traiettoria nel corso della storia (basti pensare al passaggio dalla surroga dell’iniziativa pubblica a quello della
cooperazione con essa), che
ha dato origine a dibattiti in
tensamente legati al vissuto
di tanti di noi (per tutti quello su diaconia e impegno politico), che ha prodotto nascite, riconversioni e chiusura di esperienze. Non poche
volte inoltre siamo riusciti a
non essere troppo d’ostacolo
alla vocazione profetica che
ci è rivolta. Noi, le nostre
chiese, le nostre opere, abbiamo ancora fiato, coraggio,
spinta vocazionale, capacità
di analisi... per ricercare con
fatica e rischio, ma caparbiamente, ogni possibile fedeltà
all’Evangelo?
Il Gignoro ha l’enorme fortuna di aver sempre mantenuto ottimi rapporti con le
chiese locali che lo hanno
fatto nascere e cambiare nel
tempo. Ma ci sono momenti
in cui è ancora più importante che il rapporto si faccia
esplicito, serrato, fattivo. Per
questo abbiamo deciso di
tornare, anche in modo molto formale, per prima cosa alle chiese rappresentate nel
nostro Comitato, per ripensare insieme il senso della
nostra diaconia, perché sono
le chiese che hanno dato vita
alle opere e è giusto che le
possano cambiare, allargare,
restringere.
Non vogliamo fare chiac
Tavola valdese
Torre Pellice
L’Archivio della Tavola valdese comunica il nuovo
orario di apertura al pubblico, modificato a causa dei
lavori di inventariazione in vista del suo trasferimento. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1997
martedì e giovedì 9-12,30 e 14,30-17 su appuntamento (tei. 0121-91296).
L’archivista si scusa con gli studiosi per i disagi e il
rallentamento delle ricerche che potranno avvenire in
questo periodo.
Ghiere e ci presenteremo da
subito con un esperimento,
rischiando in proprio, cercando di lanciarci in avanti
senza la rete protettiva dei
contributi comunali, cercando di fare quel che sentiamo
(prima di quel che ci si vorrebbe far fare): un progetto
comunque da dosare e strutturare insieme. Proponiamo
un piccolo e modesto progetto di assistenza domiciliare agli anziani (approvato
dal nostro coraggioso Comitato), cercando volontari,
formandoli e organizzandoli.
Possiamo farlo? come e fino
a che punto? quante risorse
sappiamo mettere in campo? Non vogliamo questa
volta determinarlo sulle videate dei nostri computer
zeppi di numeri, ma guardandoci in faccia e interrogandoci insieme sulle nostre
vocazioni. Noi come Gignoro possiamo essere un utile
strumento? possiamo ricercare un passaggio diretto di
attese e vocazioni con i
membri delle nostre chiese?
possiamo ricreare un luogo,
in qualche modo intermedio
tra opera e chiese, nel quale
si operi e si discuta circa il
senso del nostro servizio verso il prossimo?
Non ne siamo certi, ma
pensiamo sia il caso di provare, senza eccedere in precoci
entusiasmi, senza avere fretta, senza disperarci se poi
non tutto il sogno diventerà
realtà. Intanto noi stiamo lavorando agli aspetti burocratici, fiscali, assicurativi e
quant’altro. Ipotizziamo una
collaborazione, oltre che con
la nostra Associazione amici
del Gignoro - Diaconia evangelica fiorentina, anche con
l’Associazione evangelica di
volontariato... vedremo. E
c’è di più, o meglio potrebbe
esserci, se troveremo ascolto
nei «palazzi» di questa città. È
infatti in piedi un importante
SER(
progetto in comune
istituti Ferretti, Gignoro^
Gould, che fonderebbe suit
unico territorio la volontà
servire e le vocazioni espri
se dalle nostre tre operi
dalle chiese, creando unì
sorta di «Centro famiglie:
Anche qui per gradi e
tendo in campo quello cl
saremo in grado di affiori
re, nell’intento di fornire
luogo nel quartiere di Co’
ciano, nel quale le femigli^yg j'jj
possono trovare ascolto e® ¡{j^
sposte ad alcuni problemi^ uropai
comunque essere informât
e messe in contatto con al®
realtà della rete di sertozis
tratterebbe di fornire l’esp*
rienza maturata nei tre isti® ¡gjg
ti, dare occasioni concrete! ^
volontariato, promuovei mggjjg.
l’aiuto reciproco. Esperieji^ijjjgjjQ
A diaci
rita in
ito, tr.
ihe peí
tete in 1
'azion:
della
sé la c
lona u
mire t
irame:
10 essen
del genere esistono m
città e l’indirizzo che semi®
.Certo 1
iciuto.
trasparire dalle nuove ,
mative va in questa direz®
ne. Anche in questo casoc
un gruppo, espressione na®
raímente della nostra «tnP
ce», che sta lavorando ai
aspetti della faccenda.
Per quest’ultimo
dipendiamo però, purtropi
dai tempi della burocraz
Intanto non vogliamo st|
fermi a aspettare, pereto
Gignoro, d’accordo eou^'
tri due istituti fratelli, alz
per primo le vele e tent
l’avventura del mare ape'
Non lo facciamo con la
rezza e le risorse che si P ,
vano avere alcuni anni fa.
cui ci permettiamo
mente di invitare chi è '
cessato a contattarci
po di aiuto e di dispon'
quali
co. qua
wii e si
.enfasi
toare la
Ogn
ato pn
‘ton in
cere
Ila in i
tali d;
sem
laiiopi
‘epersi
fi «lo
‘e scop
'Prio (
«mpi
Ogn'Ì befare c
ci sarà utile, a iniziare
da“"
rale iicüg
se
semplice appoggio tntr
dal consiglio alla critica a
preghiera, fino airoffo|'|^||(,
risorse umane e non. L| j,
tiamo nell’impresa con jfi
stra poca fede e con oO“ .p i^
tezza: così partimmo t Ir ev
tanti anni fa!
Ter
que
’ia
Sonai
i} 'leve
iver
Und
 17
17
,ì 9A ottobre 1997
Vita Delle Chiese
PAG. 9 RIFORMA
A Milano, per il 50° anniversario del Movimento femminile battista
In prima fila per pace e giustizia
Una lunga storia: dalle origini fra le sorelle degli Stati Uniti alle rivendicazioni
gitane dei primi anni in Italia e all'impegno di testimonianza dei nostri giorni
inienio,
le «vojj
0 teni|
iZioili,
rskjoji
edepi
mi chii
o; tesi
mi e
tMWA MASINO
ressioiK
1 aliaci
tenia:
! il coi
ese
3getto,i
)razioi_
ivi deli
amoail
marci
! le loti
lare voti
mi: s
•roposli
inte[
Ilo se
stedi
:hemi
liturgi)
missM
[fronte al pericolo di un
filamento di impegno
lori, che si può trovare
;iasi istituzione, dopo
„^consueto lavoro le so"lattiste della Lombarjnvenute a Milano il 4
)ie per celebrare il 50“
iersario del loro moviJo, hanno ricevuto più
[pressione la constaiione di essere di fronte a
portantissima svolta:
10 giunte dalle unioni di
ite;Casorate Primo, Lu1, Milano via Pinamonte
'¡se circa una settantina
■Ile, fra cui la rapprese della Fdei Lombar^itina Briante.
^ il caloroso saluto del
nre Paolo Spanu e dopo
breve messaggio di chi
re, intervallato da prete e cantici, ha preso la
jlala relatrice Piena Giroli,lorella che ha visto il
>re del Movimento femlehattista in Italia, come
lottolineato Christine
lu nel presentarla. Il Molto, che ha avuto le sue
li fra le sorelle battiste
,..'Stati Uniti, si diffuse
lechiese battiste italiane
imo agli Anni 30 e inconEdaunaparte l’entusiasmo
idledonne più aperte e
itra la critica di uomini
Imie convinti che l’unica
Bltmavalida fosse quella
Elena Girolami ha ripercorso le tappe della storia del Movimento
femminile battista
maschilista. Elena Girolami
ha scrostato tutto ciò che poteva essere idealizzato e diventare mito, costruendo invece il racconto sulle varie
«pietre miliari» che non sono
stele ad perpetuam rei memoriam, ma diventano fari
indicativi per il presente e fari irradianti per il futuro. Dalla chiara e trascinante esposizione nasceva allora in ciascuna di noi la convinzione
che il Movimento femminile
dovrà orientarsi verso svolte
di lavoro e di impegno sempre più incisive.
Se all’inizio il Movimento
diede alle donne, per esempio, la forza di qualificarsi
nelle chiese non come elementi di seconda o terza fila,
ora l’essere in prima fila
comporta la svolta del co
struire la pace, di lavorare
per la giustizia a tutti i livelli,
di salvaguardare il creato. Se
all’inizio le sorelle hanno
messo l’accento sulla decima
al Signore, vuol dire che ora
dobbiamo lottare contro il
consumismo e l’edonismo
che invade anche le nostre
famiglie, riconoscendo che
siamo non possessori di beni
ma amministratori.
La discrepanza fra i progetti da realizzare e gli strumenti
(noi donne con tutti i nostri
limiti e inadeguatezze) era
enorme allora, come lo è tuttora. Ma le sorelle attuano qui
una svolta fondata sul valore
della preghiera (ricordiamo
l’intervento della sorella Marisa Inguanti nel presentare i
volumetti di sua madre «La
preghiera nella Bibbia», «Le
donne nel Nuovo Testamento») e sul valore di una preparazione e formazione biblicoteologica e spirituale quale ci
viene offerta dai vari seminari
del centro di Rocca di Papa,
gestito dal Movimento.
L’elenco delle svolte potrebbe continuare e ciascuna
di noi le ha fatte sue; dobbiamo ringraziare Elena Girolami per aver tratto dalla storia
una serie di figure di sorelle,
quasi presenti, a sussurrare,
nel ricordo, la loro profonda
convinzione di fede, ciò che
ha dato alle sorelle riunite a
Milano la possibilità di vivere
le ore di incontro con grande
gioia e con il desiderio (come
abbiamo sentito dal messaggio nel culto) di «saper dire
grazie vivendo ogni giorno
rincontro con l’amore di Dio
in Gesù Cristo».
Graditissimo è stato il saluto inviato dalla presidente
del Movimento, past. Adriana
Gavina, attualmente negli
Usa. Le sorelle di Milano
hanno offerto a tutte le intervenute un bellissimo rinfresco: dalla torta del 50“ ai vari
dolcetti, il tutto improntato
alla gioia, riconoscendo di
aver ricevuto stimoli nuovi
per proseguire il cammino e
per rispondere degnamente
alla vocazione che il Signore
ha affidato a ciascuna. Ringraziamo quindi le sorelle di
via Pinamonte per la loro generosità e ospitalità.
Prosegue la riflessione sul tema chiesa e diaconia
Evangelicità non «confessionale» e professionalità
re
ignoro!,
rfcsu
•olontà
li espi
: opere
ndo ni!
SERGIO ROSTAGNO
La diaconia è prassi insetita in un annuncio: e
ito, tra l’altro, chiarisce
ihe per sempre che non
.Stein faccia al soggetto
• i-o caritativa un og
!c ' mfii ® diaconia. Di fron
® ? aséla chiesa ha sempre la
^ Affliti umana, chiamata a
enire autonomamente e
a™rnva ^™®iate cosciente del
f isii t creatura. Questo
- n Pti l’infinito rispetto per
'ni miI costituire la
® 'i Mropartita della motivadti evangelica del creden
^•i\ \ "'’Itainbi si ritrovano in
Slodo rinviati reciproca.^1 nie l’uno all’altro nel loro
tre istw yg Un
rncretei
^Salicamente, ogni esselu IPiano e non, come vuole
° linguaggio pietista,
lese® gnfratello, membroricoi, Siuto, certificato e con
* come tale. Basta leg
^ ‘l'ielsiasi brano evange
Ini ilualsiasi incontro di
"il e si vedrà subito quando a enfasi viene messa nel
i^' la libertà dell’incon
essere umano è
urtropP ato proprio in quanto tacncri lon in quanto faccia parte
imo s 'a cerchia dei discepoli o
pef jj. ¡^a in se medesimo quacoci g tali da farlo distinguere,
lii’ ®-I ?’ sembra che gli Evangeli
c proprio a cercare tut
ic fi'-w LP®rsone simbolicamenn . „nti „ “lontane» e «esterne»,
L^cpo di mostrare che
ic' ®sse costituiscono
,p ®Pllflcazione di quel
Pi ® quando si ha a
¡piere con l’amore di Dio.
‘Liiii |{ u questo, sostanzialmen«fiilt' sirK “'Peonia evangelica è
p# Stsn^ sempre servizio alla
Tp j^^Piiaana in quanto taialar® quindi guardarsi
«confessionaon „Jk. P discorso analogo ab
hi è
1. Ogn>
poni
1 una
cef
lO
Enti* nltre volte per le
* S .^''angeliche. Nessuna
•One» sulle persone at
traverso la diaconia: ci mancherebbe altro. Ma anche
nessuna indifferenza verso
gli elementi spirituali che
fanno parte pure essi (anzi
essi in primo luogo) dei «diritti» deUa persona umana. È
forse il tatto quello che deve
suggerire la giusta misura di
sollecitudine e di ritegno, qui
come ovunque.
La persona di fede diversa
o dichiaratamente laica va
trattata come un partner autonomo e consapevole; del
resto, come abbiamo già visto, non esiste in fondo altro
modo di trattare con le persone; chi non condivide la
nostra fede potrà sempre
comprendere le nostre motivazioni. In ogni caso è proprio una delle caratteristiche
della diaconia quella di dimostrare la fede con gli atti e
quindi assai discretamente,
ma efficacemente. La fede
resta invisibile, gli atti invece
sono evidenti e questo interessa. L’assistenza, che per il
cristiano trova la sua ragione
nell’agape di Cristo, resta per
il non credente semplice rinvio alla dimensione sconosciuta e sempre nuova dell’amore da sperimentare e
scoprire. Ma anche il cristiano non può che «scoprire»
tale dimensione; lui per primo sa che tale dimensione
resta legata all’annuncio e
non può diventare una sua
qualità evidente. Non si può
partire metodologicamente
da una qualità e caratteristica «cristiana» che sarebbe
come il nostro marchio di
fabbrica. Il punto di partenza
resta l’Evangelo nella sua dinamica, che costituisce proprio per il cristiano una dimensione sempre nuova e
fuori della sua portata.
La diaconia non può pensare di creare strutture «migliori» di quelle pubbliche.
Anzi essa pretenderà il massimo possibile da se stessa e
quindi anche dalle strutture
pubbliche. Analogamente, in
presenza di realizzazioni scadenti, non deve difendere se
stessa con la scusa che quello che conta sono le intenzioni. Quel che conta è piuttosto la realtà. Il dovere, per
tutti, consiste appunto nel
creare opere «fisicamente»
adatte alle persone che devono usarle.
A livello individuale, ogni
cristiano cerca di dimostrare
con i fatti (anzi soltanto con
essi) la propria fede. Eppure
ogni volta che dovesse definire meglio quali scopi si
prefigge concretamente il suo
agire, dovrebbe riconoscere
che tali scopi possono essere
enumerati soltanto in termini di una morale laica assai
comune.
Se vi sono necessità riconosciute come tali, allora esse delineano un tema di libero dibattito, una questione
che si è richiesti di affrontare
sul piano pratico e pragmatico. Se qualche cosa occorre
fare, allora questo diventa
una questione riguardante
tutti, e come tale va dibattuta. Non è più la questione
della mia fede, della mia coerenza nella sua teoreticità e
astrattezza, ma la questione
del mio prossimo, nella concretezza delle cose.
Per le stesse ragioni, la motivazione evangelica non sostituisce la preparazione tecnica. Se ne va dell’amore del
prossimo, e occorrerà una
grande professionalità nel
proprio campo. Uno dei problemi oggi è appunto l’ineludibile esigenza di essere la
persona specificamente preparata per un compito, non
un factotum eternamente disponibile, ma in realtà pasticcione. Per questo non
credo che la diaconia debba
essere identificata con particolari persone che avrebbero
(titolo» di diacono. La diaconia è affidata a tutta la
chiesa; la diaconia è nel lavo
il
ro stesso e nel saperlo fare.
Se si dimentica questo fatto,
si esce dal campo riformato.
Quello di «diaconia» è un
concetto che si applica a
ogni lavoro. È poi un altra
questione se la chiesa intende affidare particolari compiti a persone a pieno tempo.
Questo avviene proprio perché vi sono ambiti della diaconia che diventano professioni ed esigono professionalità. Le motivazioni religiose
non possono sostituirla oppure coprire l’inefficienza.
Quando si sentono fare distinzioni tra «diaconi» e non
diaconi rispetto al tempo che
si dedica al lavoro oppure in
base allo stipendio che si
prende, bisogna tagliare corto. Questa è una strada impraticabile, perché è quella
delle distinzioni non reali;
quella, cioè, delle distinzioni
che portano fuori strada e
complicano i problemi all’infinito. Lasciamo queste distinzioni a chi si diletta in esse e a chi è in grado di automisurare il proprio cristianesimo. Dopo queste distinzioni ci sono sempre problemi
insolubili e cattiva coscienza.
Diaconia dunque evangelica, perché nel quadro
dell’Evangelo, che non è accaparrato da nessuno, ma è
per tutti. Diaconia come servizio, perché è la dimostrazione del lato pratico dell’Evangelo e questo lato pratico coincide sempre con
una persona specifica, che
sta nel bisogno. Nessuna etica specificamente laica riconosce questo come fondamento. La diaconia evangelica vede l’essere umano così
come l’Evangelo lo vede,
senza farne un «bisognoso»,
ma sapendo bene che il bisogno c’è. Diaconia, infine,
non basata su un idea di perfezione evangelica che non
esiste, ma sull’efficienza, che
fa parte della responsabilità.
2-fine
Agenda
NAPOLI — Biblia (Associazione laica di cultura biblica) organizza un convegno internazionale sul tema «Corano e Bibbia» presso il
Teatro di corte e la Biblioteca nazionale, Palazzo reale. Il convegno inizia alle ore 9 di venerdì e termina nella mattinata di domenica;
interventi di Igor Man, Maurice Borrmans, Sergio Noja,
Claudio Lo Jacono, Bartolomeo Pirone, Alberto Ventura,
Bruno Forte, Mahmoud Ayoub, Abdulaziz Abdulhussein
Sachedina, Pieo Stefani, Angelo Scarabei, Roberto Tottoli,
Giuseppe Laras, Ary Roest Crollius e Aref Ali Nayed. Per ulteriori informazioni telefonare allo 055-8825055.
SONDRIO — «La Chiesa ortodossa. Fede e
ecumenismo oggi» è il titolo della conferenza
che padre Traian Valdman, archimandrita
della Chiesa ortodossa romena di Milano,
terrà alle ore 18,30 presso il Centro evangelico di cultura in via Malta 16.
BARI — Alle ore 17, nei locali della chiesa
valdese (corso Vittorio Emanuele 138), il pastore Lorenzo Scornaienchi tiene una conversazione sul tema: «Filippo Melantone,
collaboratore di Martin Lutero».
AOSTA — Alle ore 20,45 nel Salone ducale
del municipio, il pastore Giorgio Tourn terrà una conferenza sul tema «Italiani e protestantesimo».
TORINO — Nell’ambito della serie «Musica
e preghiera», alle ore 17, nel tempio valdese
di corso Vittorio Emanuele 23, l’organista
Chiara Cassin esegue musiche di Krebs,
Sweelinck, Bruhns, Walther. Per ulteriori informazioni tei. 011-6692838.
TRIESTE — Alle ore 18,30, in via Tigor 24, il
Gruppo ecumenico (gruppo interconfessionale per l’unità dei cristiani e il dialogo fra le
religioni) organizza una conferenza del prof.
Rinaldo Fabris sul tema: «Lo Spirito Santo
nel N uovo T estamento».
CIVITA’VECCHIA — Alle ore 18, nella nuova
aula consigliare, il prof. Daniele Garrone tiene una conferenza dal titolo: «La Bibbia: parola di Dio o parola di uomini?», con introduzione del past. Sommani e intervento della
corale battista. Dal 28 ottobre al 2 novembre
nell’aula è aperta la mostra della Bibbia. Orario: da martedì
a sabato 10-12 e 15,30-19,30; domenica solo pomeriggio.
GENOVA — Alle ore 17,30, presso il palazzo ducale Ala Est,
(piano ammezzato, ascensore 2“ piano), per il ciclo di studi
del Sae su Abramo, il rabbino Giuseppe Momigliano parla
sul tema: «L’alleanza». Per informazioni tei. 010-8391402.
SAN DONATO MILANESE — Al Forte Crest
Hotel si tiene il XV Congresso cristiano di
«Uomini nuovi» sul tema: «Quando viene lo
Spirito» con gli oratori Colin Urquhart, Rauna L. May, Claude Ruffo, Giuseppe E. Laiso.
Per informazioni tei. 02-76002654.
PORDENONE — «La Bibbia nelle mani del
popolo, conseguenze nella chiesa e nella società» è il titolo della conferenza, proposta
dalle chiese evangeliche di Pordenone, che il
pastore Martin Ibarra terrà alle ore 20 in viale
Grigoletti 5 per i 480 anni della Riforma.
GROSSETO — «La Riforma protestante del XVI secolo nella
formazione dello stato moderno» è il tema della conferenza che il pastore Claudio lafrate terrà alle ore 18 nella chiesa battista di via Piave 19.
BERGAMO — Per il ciclo di tre conferenze su
«Luteranesimo e cultura tedesca», organizzato dal Centro culturale protestante con il patrocinio della facoltà di Lingue e Letterature
straniere dell’Università di Bergamo, alle ore
17,30 nella sala conferenze del Centro in via
Tasso 55 il prof. Emilio Bonfatti dell’Università di Padova
parlerà su «I discorsi a tavola di Lutero: genesi, divulgazione e riflessi nella cultura tedesca». Tel. 035-238410.
TORINO — Il Centro evangelico di cultura «Arturo Pascal»,
con le comunità cristiane di base, il corso per animatori biblici, la Federazione donne evangeliche in Italia, il Gruppo
donne credenti, la redazione de «Il Foglio», il Sae, «Tempi di
fraternità» e l’Ywca, propone alle ore 20,30 nel salone valdese di corso Vittorio Emanuele II23 un dibattito su «Il problema dell’Opus Dei». Intervengono padre Eugenio Costa, direttore del Centro teologico di Torino, Manuel Kromer, curatore del libro «I segreti dell’Opus Dei» (ed. Claudiana) e il
giornalista Luigi Sandri. Sarà presentato il volume di Peter
Hertel, «I segreti dell’Opus Dei. Documenti e retroscena»,
Torino, Claudiana, 1997. Per informazioni tei. 011-6692838.
TRIESTE — Per il ciclo di incontri organizzati dal Gruppo interconfessionale per l’unità
dei cristiani e il dialogo tra le religioni, alle
ore 18,30 presso la sede di via Tigor 24 padre
Atenagora Fasiolo parlerà sul tema «Le chiese ortodosse in Italia». Tel. 040-303715.
CULTO EVANGELICO: ogni domenica mattina alle 7,27 sul primo programma radiofonico della Rai, predicazione e notizie dal mondo evangelico italiano ed estero, appuntamenti e commenti di attualità.
PROTESTANTESIMO: rubrica televisiva di
Raidue a cura della Federazione delle chiese
evangeliche in Italia, trasmessa a domeniche
alterne alle 23,40 circa e, in replica, il lunedì
della settimana seguente alle ore 9,30 circa.
Domenica 2 novembre andrà in onda: «Assemblea Fcei: l’impegno degli evangelici nella società;
l’Impegno dei metodisti in Sud Africa; Incontri: rubrica biblica». La replica sarà trasmessa lunedì 10 novembre.
Le segnalazioni devono giungere con 15 giorni di anticipo.
 18
18
PAG.
10
RIFORMA
venerdì 24
OHOBREj
La scuola si muove
Prisca Giaiero*
Ore otto: una nuova giornata è alle porte, vediamo cosa
ci potrebbe riservare, diamo una rapida occhiata all’orario: prima ora filosofia, seconda storia (che noia, sempre
la stessa faccia!, va beh che oggi non interroga, però...),
la terza c’è ginnastica almeno ci si rilassa un po’, e la
quarta?, inglese, oggi si va in laboratorio, poi c’è scienze e
poi religione, dai che esco un’ora prima!
Così cominciano la maggior parte delle giornate scolastiche per chi sulla carta d’identità ha scritto, accanto a
professione, studentessa o studente. Ci sono poi giornate
un po’ più speciali, in cui non ti propinano le solite spiegazioni interminabili né ti affidano qualche compito da
risolvere in classe, con valutazione, decidono persino di
non interrogare!, finalmente ti fanno parlare. E una novità, a scuola quasi nessuno ti chiede cosa pensi, quali
siano le tue opinioni personali né riguardo agli argomenti affrontati in classe, né tantomeno circa i fatti di attualità; in questo modo risulta una spaccatura netta tra
quanto avviene nel mondo e ciò che accade a scuola, si
presenta una divisione incolmabile tra il presente, vivo e
inquietante, e U passato.
Tuttavia giornate di questo tipo sono molto rare, allora
per farsi sentire bisogna scendere in strada a manifestare, e qualsiasi pretesto riguardante fi pianeta scuola appare utile per far sentire la propria voce al mondo; ed è
così che ogni autunno diventa caldo, scoppiettante di
obiezioni e di controproposte riguardo alle decisioni di
mutamenti all’interno del settore istruzione. Anche quest’anno la nostra protesta si fa sentire, i ministri cambiano ma la politica scolastica continua a prefiggersi gli
stessi obbiettivi: tagli economici a danno della scuola
pubblica in favore della scuola privata, riforme degli elementi collaterali del sistema educativo (alias corsi di recupero in sostituzione degli esami di riparazione e nuovo
progetto esame di maturità), mentre una revisione degli
elementi centrali stenta a decollare.
Mi sto riferendo all’organizzazione stessa del sistema,
che parte dalla formazione del personale docente e giunge sino alla definizione dei programmi ministeriali, passando attraverso la determinazione del ruolo del/della
dirigente scolastico (preside), senza perdere mai di vista i
fruitori di tale sistema. Innanzitutto è indispensabile restituire alla scuola il suo ruolo pedagogico-formativo, attualmente sostituito da una funzione puramente informativa di tipo accademico e nozionistico, ma per attuare
ciò si presenta necessaria una formazione didattica per
le/gli insegnanti, mi pare infatti ormai anacronistica la
didattica attualmente utilizzata che risale al periodo
umanistico-rinascimentale (si tratta di 500-400 anni fa) e
che fu istituzionalizzata dall’ordine dei Gesuiti nel sedicesimo secolo.
Circa i programmi ministeriali, immutati (se si escludono le sperimentazioni affidate al buon senso di ogni singolo istituto) dai tempi della riforma Gentile degli Anni
20, la scuola ha da confrontarsi col mondo che cambia in
modo disuguale e ingiusto (si pensi al divario tra paesi del
Nord e del Sud), essa deve aprirsi all’immigrazione, alla
coscienza ecologica, alla cultura delle differenze e non
all’indifferenza. Si concede inoltre una maggiore autonomia agli istituti aumentando così il potere dei presidi, trasformandoli in una sorta di dirigenti aziendali; moltissimo dipenderà dunque dall’iniziativa personale, si creerà
una pericolosa competizione tra gli istituti accrescendo il
divario culturale già presente fra le diverse aree; che cosa
ne sarà allora della nostra già esigua unità culturale?
Si concorda nell’affermare che il grado di civiltà raggiunto da un popolo sia inscindibilmente legato alle sue
condizioni culturali, ma non si ha il coraggio di investire
nell’istruzione, nel futuro del popolo: forse se ne teme
ancora la libertà?
* Studentessa di seconda liceo classico
Riforma
E-Mail (Torino): riforma@alpcom.it
E-Mail (Napoli): riforma.na@mbox.netway.it
Uri: http://www.alpcom.it/riforma
Via S. Pio V, 15 -10125 Torino - tei. 011/655278 - fax 011/657542
Via Foria, 93 - 80137 Napoli - tei. 081/291185 - fax 081/291175
Via dei Mille, 1 -10064 Pinerolo - tei. 0121/323422-fax 0121/323831
Pubblicazlotw settimanale unitaria con L’Eco Mie valli valdesi:
non può essere venduta separaiamentó
DIRETTORE: Eugenio Bernardini. VICEDIRETTORE PER IL CENTRO-SUD: Anna Matfei. IN REDAZIONE: Alberto Corsani, Maria D'Auria, Emmanuele Paschetto, Jean-Jacques Peyronel, Piervaldo Rostan (coordinatore de L'eco delle valli) Federica Tourn. COLLABORANO: Luca Benecchi, Alberto Bragaglia, Avernino Di
Croce, Paolo Fabbri, Fulvio Ferrarlo, Giuseppe Ficara, Giorgio GardioI, Maurizio
Girolami, Pasquale lacobino, Milena Martinat, Carmelina Maurizio, Luca Negro,
Luisa Nitti, Nicola Pantaleo, Gian Paolo Ricco, Fulvio Rocco, Marco Rostan, Mirella Scorsonelli, Florence Vinti, Raffaele Volpe.
DIRETTORA RESPONSABILE Al SENSI DI LEGGE: Piera Egidi.
REVISIONE EDITORIALE:Stelio Armand-Hugon; GRAFICA: Pietro Romeo
AMMINISTRAZIONE: Ester Castangia; ABBONAMENTI: Daniela Actis.
STAMPA: La Ghisleriana s.n.c. Mondov) - tei. 0174-42590.
EDITORE: Edizioni Protestanti s.r.l. - via S. Pio V, 15 bis -10125 Torino.
Tariffe inserzioni pubblicitarie: a modulo (42,5x40 mm) £ 30.000. Partecipazioni: millimetro/colonna £ 1.800. Economici: a parola £ 1.000.
Riforma è il nuovo titolo della testata La Luce registrata dal Tribunale di Pinerolo con il
n. 176 del 1® gennaio 1951. Le modifiche sono state registrate il 5 marzo 1993.
Il numero 39 del 17 ottobre 1997 è stato consegnato per l'inoltro postale all’Ufficio
CMP Nord, via Reiss Romoli 44/11 di Torino mercoledì 15 ottobre 1997.
Compiti del pacifismo e nuovi scenari internazionali
Il tira e molla delle armi
/ processi di disarmo sono maggiormente collegati ai più
ampi problemi della democrazia e delbeconomia planetaria
ALBERTO CORSAMI
Tagli di qua e scopri che
rientrano di là. Ciò che
esce dalla porta rientra dalla
finestra. L’altalena della distruzione e dell’innovazione
nel campo degli armamenti
lascia sconcertati. È di pochi
giorni fa l’attribuzione del
premio Nobel per la pace alla
Campagna per il bando alle
mine antipersona, ma è una
notizia che si accompagna a
quella della sperimentazione
dei sistemi statunitensi orientati alla distruzione dei
satelliti (possibili spie) nemici e di sistemi di bombe che
potranno essere dotazione
anche dei nostri «Tornado».
Un trattato oggi, una sua violazione domani, un embargo
va di pari passo con i cavilli
per aggirarlo. Così, da parte
dei pacifisti, è difficile elaborare delle strategie, forzatamente nuove perché nuovo è
lo scenario, per rispondere o
almeno per denunciare questa nuova condizione del
mondo in cui viviamo. Difficile ma non impossibile.
1) 11 movimento pacifista,
almeno a livello di immagine,
è passato in secondo piano
rispetto alla decisione con
cui altri soggetti hanno condotto alcune battaglie: quella
sulle mine antipersona è il
caso più eclatante: dal «Maurizio Costanzo Show», dove
un medico milanese che si
occupa delle vittime delle
mine fece una drammatica
denuncia, all’impegno convinto del movimento cattolico «Mani tese» a quello di
lady Diana. Seguirono il primo provvedimento italiano,
una moratoria decisa nel
1994, va detto, dal governo
Berlusconi; la rinuncia italiana a produzione e vendita di
mine, contestuale all’impegno per la distruzione delle
scorte, che il ministro Dini
annunciò nell’ottobre 1996;
la mozione sollecitata l’autunno scorso dai Verdi con la
partecipazione di un po’ tutte le forze politicbe, che elimina la distinzione fra mine
normali e «intelligenti», destinate cioè a disattivarsi dopo un certo periodo. Altri
soggetti in campo, dunque, e
ciò è bene, e toglie al tempo
stesso ogni giustificazione a
chi si defila.
2) La medesima vicenda ha
riproposto peraltro, a più riprese, il drammatico conflitto (in qualche caso ricatto)
tra esigenze di disarmo e salvaguardia dell’occupazione.
Ancora all’indomani dell’attribuzione del Nobel, il manager della Valsella, azienda
un tempo leader in questo
Treviso è una linda cittadina del Veneto, tranquilla e laboriosa, dove personalmente sono sempre stato circondato da molta cordialità e
da una naturale giovialità di
carattere. Insomma: una cittadina simpatica. Almeno: lo
era fino a lunedì scorso. Poi
sembra che il sindaco si sia
messo d’impegno per rendere odio.sa la sua città. Infatti,
avendo notato domenica che
le panchine di via Roma erano occupate da immigrati di
colore (e dove devono andare, poveracci?) lunedì le ha
fatte estirpare, sorvegliando
personalmente i lavori degli
operai del Comune.
E così, per merito di questo
incredibile primo cittadino,
quella che era conosciuta come una città ospitale rischia
di venire additata come simbolo di intolleranza. Non solo, ma parlando dei clande
La marcia della pace in prossimità di Assisi (edizione 1990)
settore, ora in liquidazione,
afferniava che «il problema
non è la mina in sé, ma l’uso
che se ne fa...» («La Repubblica», 11 ottobre): qualcuno
conosce un uso costruttivo di
questi ordigni? È indubbio
comunque che alcune aziende devono licenziare, e poco
si fa per promuovere la riconversione di alcuni settori verso altre strategie produttive.
Non è impossibile: la toscana
Galileo lo fece, orientandosi
verso produzioni per la ricerca scientifica e medica.
3) Le mine, come a suo
tempo anche le armi chimiche, sono una tipica arma da
paesi poveri; produrre una
mina costava tre dollari, rimuoverla 500. Strumenti,
dunque, non solo di morte
per gli sventurati che vi camminano sópra, anche a conflitti conclusi, ma anche di
ricatto e di pressione. Era tipico degli Anni 80 che i paesi
arabi rispondessero con la
detenzione di arsenali chimici alla minaccia nucleare
(vera o presunta, poi rivelatasi più vera che presunta)
israeliana. Molti paesi del
Terzo Mondo facevano notare che le superpotenze «ingessavano» la politica mondiale con il cosiddetto equilibrio del terrore degli armamenti atomici, ma intanto le
guerre locali continuavano a
scoppiare.
4) Il punto precedente conduce tuttavia a chiudere il
cerchio. Se per i pacifisti è diventato obsoleto un impegno
privilegiato come fu quello
contro i missili di Comiso e la
minaccia nucleare (ben lungi
peraltro dall’essere disinnescata per sempre), è vero che
proprio dalla condizione dei
paesi poveri, sede di conflitti
e di contraddizioni interne, si
deve ripartire anche per promuovere il disarmo. E lo si
deve fare in tre almeno direzioni, ben evidenti anche alla
recente marcia Perugia-Assisi, che coinvolgono non solo i
pacifisti:
a) l’impegno per i diritti
umani ovunque è fondamentale: sono i governi autoritari a utilizzare più frequentemente l’argomento
dell’«accerchiamento» e del
vittimismo, in virtù del quale
convincono i propri popoli
della necessità del riarmo
(magari con armi «povere») a
danno dello sviluppo: Saddam insegna.
b) in conseguenza del precedente occorre battersi per
una struttura sovranazionale
realmente in grado di sovrintendere al rispetto dei diritti
umani, al contenimento dei
conflitti locali e sempre più
spesso interetnici, sempre
più interni a singoli stati, e al
rispetto dei trattati internazionali. L’attuale Onu non è
in grado di farlo: pesano ancora logiche da guerra fredda
e di schieramento con veti
incrociati.
c) correlato alla mancanza
di democrazia è il problema,
enorme, della giustizia economica. Il divario fra stato
ricebi e poveri, oltre a produrre fisicamente la fame, innesca logiche di rivalsa, di rivendicazione su basi non democratiche ma di regressione
al tribalismo, all’appartenenza e all’etnicità. Finché non si
mostrerà non dico una possibile soluzione (che non appartiene né a questa né alla
prossima generazione) ma
almeno un segnale di comprensione del problema, la
battaglia per il disarmo potrà
vantare successi parziali e
transitori, ma il mondo sarà
sempre esposto a gravi risebi
e, soprattutto, per milioni di
persone quelli che per noi sono rischi sono già realtà.
PiljJdiJliJii 3 IjiJuJlíi/íj-i;
PIERO bensì
Stini il sindaco ha detto: «Se
non sono in regola, io sono
disposto a tornare ai carri
piombati». Era un ragazzino
quando in Italia circolavano i
carri piombati e non ricorda
più quella vergogna: forse,
per fargli ritornare la memoria, bisognerebbe fargli fare
un viaggio in un carro piombato da Treviso alla Siberia.
Non è accettabile ebe in Italia esistano posizioni di questo genere da parte di personaggi che dovrebbero, al
contrario, dare l’esempio di
serietà, di tolleranza, di disponibilità.
Invece di usare gli operai
del Comune per estirpare le
panchine, perché non li ha
usati per creare centri di accoglienza dove far vivere in
modo dignitoso questi disperati che si sono rivolti a noi?
Treviso è una città ricca e privilegiata: ha la possibilità di
aiutare chi soffre. E non ci si
venga sempre a raccontare
che gli immigrati portano
inoi
; P
ytmàmm jgiu |
|rrei i
tito su
[to su
(tto oh
id’a
seced
I terreni dell'etica
[die®
L’economista Paolo s,
Labini sul numero del 13'
tembre del settimanale
nemico contesta Taffe,
zione dei valori morali
posti da papa Wojtyla i
società che ne sembra
Escludendo che esista
vera e propria contrapi
zione tra morale laicaè
tolica, Sylos Labini dice;
il Papa ammette che la
sa ha sbagliato [in rifei
to alle persecuzioni
sato, ndr], lo fa anche pa
il mondo laico non ha
smesso di criticare l’osa
tismo». Se si fa un
morale in un settore, bisi
farlo sempre: «È morale,
esempio, inventarsi tuttii!
villi possibili per
una norma chiara, espi
inequivocabile come fai
lo 33 della Costituzioni
Quanto alla difesa della
Sylos Labini afferma che
giusto lasciar andare a
per fame i bambini
Mondo.
¡stano
i dell!
Toexa
Secolarizzazione
dpe
;zi a 1
stiani
itanei t
loqu
noi
1
iverso
(<
ila dot
sono
isond I
[do mit
8 anni il
evangi
la, otte
ito, 0 Í
msabil
ino sfo:
¡reaimú
D’altra
asituaz
pastori
iiretto
inti a ‘
ITO din
'fsperie
le alcun
urani ai
10 le pi
le di Mi
ma set
sono
lastanz
oao svai
ferien:
ma una è (
Mltial C£
œone cl
tale sforzo
Un dossier sul n. 19(1'| ma parol
tobre) del quindicinalei ^duca
Pro Civitate Cbristiana#
sisi dedicato al Giubileoti
riconciliazione dà voceip
store luterano Hartmjf®'
mann e al pastore ifc
Martin Ibarra y Perez.
mann sostiene l’impoit» manteneri
del dialogo fra cattolici api
testanti con una società®
larizzata: «Questo dialogo) lonaiifles:
cattolici e evangelici] devifeitori i
ir
coniale
cente...
Alla fine
ventare un “trialogo",]
c’è tutta la realtà sociale!
non coinvolta». Si trati
persone che «non credoni
Dio, nel Dio cristiano, ntóf
dono in qualcos’altro. LaU
dizione del dialogo è innai
tutto questo lasciare aU’i»'
locatore la libertà di del»
(...). Il dialogo significac
verità è diffusa, non sta 8
da una parte». Ibarra sosti
che «è nostro compito
darci e ricordare a tutti|
questa società secolarizifl
tecnologizzata è una sof
minoritaria (...), accessi
solo a pochi prmlegiatiaj
si fonda sullo sfruttanient^
altre società che sono 1
periferia». E più avanti:*
azione comune [fra crisfl
e laici] è possibile nel car
della denuncia profetWJ
nuovo sfruttamento^
comporta l’industriai
conoscenza».
ppi? (
Co
fidi
[uello I
a»: pe
isa il p
te), poi
ipritica
to. E se
ösato «
o(al
è 11
®èund
taso c
Itti sia
ave, p
edui
li, ec
iibilit:
eh
ho
istra I
con sé prostituzione, di'
violenza. Come se noi iK
avessimo qualcosa da u
rare su questi tre argo®
Non dimentichiamo cnc
mo la terra della mafia.®
soltanto la Sicilia.
È molto probabile eh®
sindaco rissoso si vanti
sere cristiano. Forse n
ebe l’accoglienza deim
niero era uno degli as
fondamentali della n
primitiva, in ubbidienz
parola di Gesù: «Fui
ro e mi accoglieste; fai
e mi rivestiste, ebbi l ^
mi deste da mangia''®*^,||
glio ritornare a H ..
quando saranno ritot ‘
panchine in via Roma’
(Rubrica «Un fuRR;
mento» della trasmis^’^
Lie eh
Ban
Nu
diouno «Culto cvangdi'^^^M
ta dalla Federazione de
evangeliche in Italica
onda domenica 19 ottoo
tet
«n
 19
19
§5^ li
)ì 24 OTTOBRE 1997
[nostri Centri
l'etica
^aolo Sj
3deli3s
canale (
I l’affet
fiorali
'jtyla iaj
mbra p|
esista!
)ntrapp
laica et
ni dice:^
±ela(
1 riferi]
mi del|
iche pej
lon hai
e l’osc]
an
are, bis«
morale]
rsi tuttiii
er aggiri
a, ei
mel
ituzion
a dellai
ma chei
lare ai
ni
:a
izione
n. 19(1'
cinaleÉlI
itianadili
ubileoà
i voceiljK
rtm#
ire biffl
’erez.i
impoM
ttoliciepi
locietàsd
Lei intervenire nel di¡to sui Centri evangelici
0 sul numero 37. Preche mi trovo abbad’accordo con chi mi
,ceduto: ci sono delle
per cui si mandano i
zi a un campo, e sono:
stiano assieme ad altri
itanei evangelici, che im' 0 qualcosa sulla Bibbia
ja nostra storia, che cofano la vita della chiesa
Everso l’esperienza quojana (dato che talvolta
loia domenicale e catechilosono un po’ astratti). Io
;o mi domando se, manJo mio figlio che ha quaSanni in un qualsiasi Cenevangelico l’estate pros, otterrò quello che de[ero, 0 se perlomeno i reinsabili dei campi si saino sforzati di corrisponte ai miei desideri.
D’altra parte mi trovo in
simazione difficile: sono
astore e la scorsa estate
iretto un campo per ado■nti a Tramonti di Sopra.
0 dire che non è stata
l’ssperienza facile, e temo
alcuni dei genitori dei
ivani a me affidati condivi10 le perplessità delle sole di Milano: per esempio
a settimana i contenuti
sono passati sono stati
istanza pochi. Le ragioni
3 svariate (non ultima
lerienza del sottoscritto)
ialina è chiara: tra i parteciiti al campo c’erano delle
me che richiedevano un
sforzo per trattenerle (in
parola si potrebbe dire
iducate) che la maggior
panedelle energie è stata dedicata a mantenere «l’ordine
pubblico», a far fare alla gente lei^e ovvie (collaborare
conlakina, non fumare in
ICC.), a cercare di far
mantenere un linguaggio decente...
Mafine del campo ho fatto
dialogo! iinafiflessione: perché certi
licil de«j tenitori mandano i figli ai
)go”, pM npi? Con quale spirito? Mi
iocialei ne il dubbio che lo spirito
Si tratì jueiio della «colonia evan1 credo* ica»; per una settimana ci
ano, mal asa il pastore (o equipolItro. LaU te), poi tornano a prenderlo è innai ectiticano l’andamento del
are allrt Ho, e se per caso il pastore
i di dei (¡sato «mettere in castigo»
nificacB ^0 (al di là delle ragioni),
lon stai ^ jyj capisce,
erra SOS* oèun dittatore, ecc.
npito ni fenso che quello dei nostri
: a tutti jtfj yjj problema serio
colarizza perché è lì che venuna soc jg educate le nuove gene
nelT adolescenza può trascinarsi per gli anni futuri. Però
penso anche che la responsabilità sia doppia: i genitori
devono pretendere di più da
noi (per esempio che non
contraddiciamo nei fatti il
messaggio educativo proposto con le parole), ma devono
anche lasciarci pretendere di
più da loro (per esempio che
non tutta l’educazione sia
delegata agli animatori dei
campi).
Gregorio Plescan - Ivrea
Il paese affonda
accessi g^j ^ j- g|^g gjoca la
legiatic dibiiità e la serietà della
ittame* stra chiesa; un fallimento
sono 13
(
Avete visto quando «L’
Unità», ex giornale comunista, ha dedicato in data 1°
settembre ben 17 pagine alla
morte di lady D.? L’operaio
di Altan, se ancora la legge,
deve essere svenuto. Gli altri,
se ancora la leggono, devono
averla scambiata per una edizione in bianco e nero di
«Novella 2000». Questo fa
parte del balletto di balle
quotidiane a cui i media ci
hanno abituato.
Non intendo dilungarmi su
problemi di comunicazione
di massa, né tantomeno sui
problemi di una nazione protestante come la Gran Bretagna, che in quanto a culto
della personalità è riuscita a
fermarsi solo tre volte: alla
morte di Churchill, al massacro di Dunblane, e adesso.
Ciò che preoccupa quando ci
si reca all’estero (in questo
caso la Gran Bretagna) non è
tanto il problema della lingua
o la guida a sinistra: ciò che
davvero angoscia è invece
l’affondamento del nostro stivale nel suo complesso, perché una volta tanto lo si riesce
a osservare con il binocolo.
Un affondamento che fa
paura, specie se messo a confronto con una democrazia
moderna e funzionante. E se
è vero che sull’Inghilterra ci
sono poche cose interessanti
da dire, apparentemente
conservatrice come è sempre
stata, sull’Italia ce ne sono
ancora meno. La stampa italiana è sorda e così l’Inghilterra che finisce sui giornali è
sempre la stessa (i guai dei
Windsor, le loro scappatelle,
ecc.). Ma non si dice che l’Inghilterra è un paese in cui
l’intera umanità è riuscita a
trapiantarsi, seguendo modi
nuovi e diversi, infinitamente
diversi dal nostro.
Sarebbe sufficiente, per capire ciò che sto dicendo, osservare il rapporto che intercorre tra cittadini e politici,
tra cittadini e servizi, tra cittadini e cittadini: quello che
in Italia (completamente assente) corrisponde alla parola «senso civico». Quanta rabbia per chiunque sia mai riuscito a allontanarsi dal «pa
avanti:
fra crisi
; nel c3J
irofetW
nento
istriai
3ne, di”
a noi i®
sa dai®
I argoi®'
mo che
nafia.
)ile che
vanti®!
orse n®
1 dell»®'
egli as|
ella cW
lidien^”
Fui fot”*
te; fui”'
■bbi f®”
igiaf””’«
a Ti”*^
rito®
orna.
wnfix)
i
10
OTTOBRE 1997
Madre Teresa
Santa per i poveri, santa per i potenti
Sviluppo
^ chiese su stato sociale, giustizia, ambiente
Cattolici
Senza la De, in che direzione andare?
Minori
bambini lavoratori. Sfruttati dalla povertà
Pace
^uovo modello di difesa o caschi bianchi?
tw,
«fi
■,ssioni‘\
fedel\^\
Ha aff
J^'^fronti: una copia lire 8.000; abbonamento annuo lire 65.000;>
*?itore lire 120.000 coh libro in omaggio). Versamento sul ccp 61288007
,^^®tato a coop. Com Nuovi Tempi, via Firenze 38, 00184 Roma.
una copia omaggio telefonando allo 06-4820503, fax 4827901,
^dirizzo Internet; Http://hella.stm.it/market/sct^ome.htm)
Pagina Dei
PAG. 1 1 RIFORMA
trio stivale» per osservarlo
con occhi diversi.
Ecco lo spettacolo ridicolo
del bastimento politico, ormai ridotto a segnali di fumo,
con al timone sempre gli stessi, tutti più o meno riciclati,
stremati dai veleni, paralizzati dai ricatti, da questioni inutili; e poi i Tg, tutti più 0 meno schierati, e qui mi fermo.
Tutto ciò ha sempre fatto parte di quella cosa, che noi
chiamiamo teatralità e che ci
ha sempre fatto perdere di
credibilità di fronte alle democrazie di mezzo mondo.
Nel frattempo il nostro paese perde colpi nella produzione di tecnologia, le università
sono dominate da lobby affaristiche che non producono
cultura né ricerca, l’ignoranza
tracima, la maleducazione dilaga insieme a opportunismo
e clientelismo. Il governo ulivista, che non vuole essere da
meno della sua controparte,
stanzia 3.000 miliardi per il
Giubileo romano. Uno stato
moderno e laico?
Il problema è là, dove sappiamo, nel rapporto tra base
e vertice, tra cittadini e politici, a volte torbido, a volte di
comodo, dipende dalle circostanze. Un rapporto sterile,
dal momento che non esiste,
e probabilmente non esisterà
mai la semplice relazione
«volontà della maggioranza»
con «mandato a governare»
che rende la Gran Bretagna
un «paese normale». Intanto
mi si chiede se noi italiani abbiamo un’identità. Loro hanno una democrazia tra le più
antiche, hanno il merito di
aver resistito al nazifascismo
tenacemente. Anche i reali
erano come si dice «in prima
linea», mentre i nostri regnanti la fuggivano. Una bella
domanda, alla quale non ho
saputo dare una risposta.
Pensavo all’italiano, lingua
complicata, pensavo agli spaghetti, alla pizza, che sono i
due stereotipi più positivi.
Stavo per dire: noi italiani
abbiamo avuto la Resistenza,
gli unici due anni di storia decente nell’arco di un secolo.
Ma ho taciuto: in Italia mi
hanno convinto che tutto è
relativo, come il peso a seconda della gravità. Mi hanno
propinato teorie astruse chiamate «revisionismo» e «garantismo», che altro non mi
dicono se non amnesia della
storia la prima e impunità per
i criminali la seconda. E così,
a ribaltoni fatti, non c’è colpa
neanche nel fascismo. Però
un paio di cose rimarranno:
la prima è l’astio contro il nemico ignoranza, la seconda è
la paura, paura di vivere in un
paese che non ha identità né
memoria. E magari anche un
po’ di vergogna.
Un problema all'ordine del giorno
L'Italia ha bisogno degli immigrati?
Leggo su Riforma del 22
agosto, nella pagina dei
commenti, l’articolo di Giorgio Gardiol «Immigrato,
clandestino, delinquente?».
Lo scritto espone obiettivamente dati e considerazioni
su cui dovremmo riflettere
tutti, ci piaccia o no. La definizione «L’immigrazione,
non emergenza ma realtà
del 2000» è realistica. Di
questo ci dobbiamo rendere
conto.
C’è un punto alla conclusione dell’articolo in cui viene affermato che «l’economia italiana ha infatti molto
bisogno degli immigrati.
Perciò vanno loro riconosciuti i diritti e richiesti i doveri di tutti gli altri cittadini».
Il seguito non lo cito perché
su quello sono sostanzialmente d’accordo. Ciò che
non capisco è propriamente
in che modo l’economia italiana abbia bisogno degli
immigrati. A scanso di equivoci dico subito che riconosco la mia poca sensibilità al
secondo comandamento cristiano, perché è di questo in
fondo che si tratta anche se
Giorgio Gardiol dice che il
problema non è tanto di legalità e di solidarietà.
Io credo che questo sia il
punto fondamentale: la solidarietà che manca; penso
però anche che dove si mangia in sei, bene o male, si può
mettere un piatto in più e accogliere un altro alla mensa
(con diritti e doveri come gli
altri membri), scusate la similitudine. Ben altra cosa è
affermare che quella famiglia, per restare alla similitudine, abbia bisogno di quest’ultimo membro. Se però ci
sono altri motivi inerenti al
rapporto immigrazione-economia devono essere messi
ben in chiaro.
Mario Brusadin - Zurigo
Risponde
Giorgio Gardiol
L’economia italiana ha bisogno degli immigrati. L’affermazione è paradossale visto che nel nostro paese ci
sono 3 milioni di inoccupati.
È un ragionamento che molti fanno. In fondo se il milione mezzo di stranieri fosse
rimandato a casa, magari
creando nel loro paese di
origine posti di lavoro,
l’inoccupazione sarebbe ridotta a metà.
Purtroppo la realtà non è
così semplice. Gi studi economici e sociali più seri (ad
esempio Alessandra Vittorini, Le migrazioni nei paesi
Sud europei, Università di
Bergamo, 1996) mettono in
rilievo gli aspetti strutturali
dell’immigrazione. Gli impieghi degli stranieri sono
ormai prevalenti nei servizi
nei grandi aggregati metropolitani, nel lavoro industriale della piccola e media
impresa nel Nord-Ovest, ma
anche 1’esistenza di un lavoro autonomo (artigiani e
commercianti) che non sono solo più un espediente
per vivere, ma un progetto
economico.
In più ci sono i numerosi
studenti, che dopo il loro
periodo di formazione si affacciano nel mercato del lavoro con qualifiche, anche
superiori a quelle degli italiani, nel campo scientifico,
della ricerca, della sanità.
Da questi studi è evidente
che il lavoro è complementare e aggiuntivo a quello
degli italiani. Sicuramente
non alternativo. In prospettiva: nel 2015, se le tendenze
demografiche degli italiani
non cambieranno, gran parte del lavoro di cura degli
anziani sarà un compito degli immigrati, di prima o seconda generazione.
Il problema dunque è
quello di avere leggi che favoriscano l’integrazione economica dello straniero
nel nostro sistema economico (che ormai è europeo):
occorre perciò riconoscere
allo straniero i diritti e i doveri di cittadinanza (che sono altra cosa dei diritti di
nazionalità), (g.g.)
Flavio Mieoi - Pomaretto
Un libro pieno
di imprecisioni
sui metodisti
Ho letto sul n. 38 di Riforma la segnalazione del libro
di Giordano Berti Gli eretici,
edizioni Xenia, Milano, 1997.
Mi permetto di confutare la
validità di questo libro e di
non concordare con la recensione pubblicata, dato
che l’autore in alcune sue
pagine è tratto in inganno da
conoscenze più che superficiali, soprattutto riguardo al
protestantesimo.
Io personalmente ho già
scritto all’editore informandolo di gravi errori apparsi
nel libro, come per esempio
a p. 97 e 98, dove si parla dei
metodisti e si dice: «Costoro,
di fronte al rigido formalismo
della Chiesa anglicana predicarono la ricerca della salvezza attraverso “speciali”
metodi: lettura comunitaria
della Bibbia, conversioni spirituali...».
Ritengo che quanto scritto,
in particolare per i metodisti.
Nella collana «Meditazioni bibliche» è uscito
Carlo Gay
Il canto della fede
prefazione di Giorgio Tourn
nota biografica di Luciano Deodato
pp. 198, L. 23.000
Questa raccolta di sermoni, che spaziano dal 1937 al ’78,
è un importante e significativo documento dì prima mano sulla predicazione delia seconda metà del
nostro secolo, di quella generazione di pastori che ha vissuto le vicissitudini legate al fascismo e alla
guerra e che si è riconosciuta nella teologia di Karl Barth e nel nascente movimento ecumenico.
Colpisce la coerenza interiore del
discorso teologico al cui centro c’è
sempre la fede in Gesù Cristo, la
comunione con lui.
m mmedhriee
Claudiana
VIA PRINCIPE TOMMASO, 1 -10125 TORINO
TEL. 011/668.98.04 - FAX 011/650.43.94 - C.C.P. 20780102
http://www.arpnet.lt/-valdese/claudlan.htm
sia qualcosa di errato e di orrendamente errato. Recensire in positivo questo libro
non mi è sembrata una felice
iniziativa.
Giovanni Anziani - Bologna
Gesù Cristo
e Í potenti di
ieri e di oggi
Sono abbonato da alcuni
anni a Riforma, che leggo volentieri pur non essendo
membro effettivo di una
chiesa protestante. Credo
però in Gesù Cristo, tanto
che se non ci fosse stato bisognerebbe inventarlo per il
bene dell’umanità. Si dice
che è morto per noi, ma non
è morto per il freddo... c’è
qualcuno che l’ha ucciso.
Questi erano i ricchi e potenti
di allora, il potere politico,
militare e religioso: anzi, quest’ultimo era il più accanito
per farlo fuori, perché Gesù
aveva chiamato ipocriti e sepolcri imbiancati i suoi detentori. Poi la croce da sim
bolo di supplizio è diventato
simbolo di potere. Infatti si
vedono croci d’oro sui petti
dei porporati, croci di guerra
sul petto di generali, croci di
diamanti sulle teste coronate
dei regnanti.
Io penso che se Gesù Cristo
tornasse sulla terra al giorno
d’oggi, tenterebbe forse ancora di scacciare dal tempio
queste persone, ma farebbe
la stessa fine di allora. Sono
un operaio che ha fatto solo
la V elementare ma anche 40
anni di fabbrica, 5 di guerra,
2 di prigionia in Germania:
un po’ di esperienza Tho fatta
e di cose storte ne ho viste
abbastanza.
Nicolò Rosà - Rovereto
Errata
Avventisti
Incontri
sui fenomeni
paranormali
La Chiesa awentista di
Mestre organizza dal 26
ottobre al 1° novembre,
nella sala conferenze di
via Manin 48, un ciclo di
incontri presentato da
Luigi Caratelli sui «fenomeni paranormali».
Questi i temi trattati:
domenica 26 ottobre, con
inizio alle ore 18, «Attenzione! Ghiaccio sottile»;
lunedì 27 ottobre alle ore
20.30 «Angeli di quale
Dio?»: martedì 28 alle ore
20.30 «Possiamo parlare
con i nostri morti?»; mercoledì 29 alle ore 20,30 «Il
mistero di Orione», giovedì 30 ottobre «La mappa», venerdì 31 ottobre alle ore 20,30 «Quando appare la madonna?», sabato 1° novembre alle ore 18
«Mistero in astronave».
Nell’articolo pubblicato a
firma di P. Gajewski in Riforma n. 37 del 3 ottobre 1997,
nella terza colonna, nona riga, la frase va letta «Una parte dei partecipanti...». Ce ne
scusiamo con l’autore e con i
lettori.
«lo ho pazientemente aspettato
l’Eterno ed egli si è inclinato a me
ed ha ascoltato il mio grido»
Salmo 40,1
Il 13 ottobre a Roma è mancata all’affetto dei suoi cari
Rita Venditti ved. Celli
Lo annunciano con dolore agli
amici che l’hanno conosciuta, Anna Celli con Daniele Di Gennaro
e tutti i parenti.
Roma, 24 ottobre 1997
Librerie
CLAUDIANA
MILANO:
via Francesco Sforza 12/A;
tei. 02/76021518
TORINO:
via Principe Tommaso 1;
tei. 011/6692458
TORRE PELLICE:
piazza della Liberi, 7;
tel.0121/91422
ROMA:
Libreria di cultura religiosa
piazza Cavour 32;
tei. 06/3225493
 20
20
PAG. 1 2 RIFORMA
Il parco «sognato» dalTingegnere Jimmy Jacumin sta sorgendo a Valdese
Il «Sentiero della fede» dalle Valli agli Usa
Il progetto sognato quattro anni fa durante una visita alle Valli si realizza a pochi
passi dal tempio di Valdese. Ricostituiti alcuni luoghi legati alla storia valdese
PAOLO NASO
IL monumento di Chanforan, che ricorda l’adesione del movimento valdese
alla Riforma protestante nel
1532, e il tempio valdese del
Ciabàs; una scuola Beckwith
e il collegio dei Barba in cui si
formarono i primi «pastori»
valdesi; la «chiesa della tana»,
dove secondo la tradizione i
valdesi celebravano il culto
durante le ricorrenti persecuzioni, e un campo di bocce. Il
tutto in una «valle» che si
estende per duecentocinquanta metri protetta dalla
ricostruzione del profilo delle
Alpi Cozie: è il «Trail of faith»,
il «Sentiero della fede», che
sta sorgendo a Valdese nel
Nord Carolina come un «parco tematico», uno dei tanti
degli Stati Uniti.
Così come i mormoni dello
Utah o i fratelli moravi della
Pennsylvania, anche i valdesi
del Nord Carolina avranno
quindi una sorta di museo
all’aperto che ricostruisce
monumenti ed ambienti legati alla loro storia.
Dalle valli valdesi
alla Carolina del Nord
I lavori sono già in fase
avanzata ed è possibile visitare alcuni dei monumenti, tutti in grandezza naturale e, in
un caso, addirittura originale:
è la «Casa Tron», una delle
prime abitazioni costruite dal
gruppo di immigrati italiani
delle valli valdesi che nella
primavera del 1893 giunse in
Nord Carolina alla ricerca di
una terra che offrisse loro opportunità di lavoro e di sviluppo della loro comunità.
«Qualche mese prima avevano mandato due esploratori - racconta con ironia «Gus»
Tron, figlio di uno dei pastori
italiani che seguì la comunità
negli Anni 30 - e al loro ritorno nelle Valli presentarono il
loro rapporto: come spesso
accade tra i valdesi, uno disse
che aveva visto un bel paese,
della buona terra fertile e che
il clima era mite; l’altro disse
più 0 meno il contrario... ma
ormai la gente era pronta a
partire e aveva già iniziato a
vendere le proprie terre e il
ÎSejsalïÂi
V'-. ’ : ^
V ■ ■
Il percorso del «Sentiero della fede»
poco bestiame di famiglia. E
così un primo gruppo di 17
famiglie, per un totale di 29
persone, partì ai primi di
maggio ed arrivò a Valdese,
in treno da New York, il 29 di
quel mese». «Il “parco” intende raccontare questa storia, ma soprattutto la storia
dei valdesi, della loro perseveranza, della loro resistenza, della loro fede», spiega
Jimmy Jacumin, l’uomo che,
solo quattro anni fa, durante
una visita alle valli valdesi
«sognò» questo progetto.
Il «sogno»
di Jimmy jacumin
Un «sogno» che ha preso
corpo in pochissimo tempo
«perché Dio lo ha accompagnato e me ne ha dato continui segni attraverso veri e
propri miracoli», sottolinea
Jacumin che, benché di origine valdese, è attivamente impegnato in una Chiesa battista del Sud e nel movimento
dei Gedeoni.
Tra i tanti, il «miracolo»
che Jacumin ama raccontare
più spesso è quello della storia dell’acquisizione della terra su cui sorge il parco: da
bravo ingegnere e da fortunato imprenditore qual è, Jacumin cercava un’area strategica e l’aveva trovata a pochi passi dal tempio e dal curatissimo museo valdese della città, in una posizione facilmente accessibile e vicina
ad un teatro all’aperto. Sul
terreno designato, inoltre,
sorge un vecchio opificio dismesso «che sarà trasformato
in un hôtel per accogliere i
visitatori». Ma il proprietario
del terreno non sembrava
avere alcuna intenzione di
vendere; «Sono andato a
chiederglielo quattro volte, e
ogni volta facendo capire che
ero disposto a pagarlo ade
Dopo rimmenso raduno del 4 ottobre a Washington
I «Promise keepers» intendono diventare
un movimento mondiale nel Duemila
Il movimento americano
dei «Promise keepers», cioè
di «coloro che mantengono le
loro promesse», composto
essenzialmente di uomini
cristiani, ha dato vita ad un
enorme raduno a Washington sabato 4 ottobre. Ora il
suo obiettivo è di diventare
un movimento mondiale nel
2000: lo ha dichiarato il suo
fondatore. Bill McCartney.
Per sei ore, centinaia di migliaia di uomini hanno ascoltato appelli al pentimento;
hanno pregato, mano nella
mano, hanno alzato le braccia al cielo, si sono inginoccbiati, hanno pianto e cantato lungo il «Mail», l’immensa
spianata di fronte al Campidoglio di Washington. Erano
venuti per fare atto di espiazione per le promesse che
non avevano mantenuto (nei
confronti delle mogli, dei figli
e dell’America) e per impegnarsi ad assumere nuovamente le proprie responsabilità nei confronti delle loro
famiglie, delle loro chiese e
delle loro comunità, e a cambiare la loro condotta morale.
Nell’annunciare i progetti
mondiali dei «Promise keepers», Bill McCartney ba dichiarato: «Da nessuna parte
nel mondo si trovano uomini
che proclamano l’Evangelo
di Gesù Cristo. È ora. Dovete
inviarci nel mondo affinché
Dio si serva di noi per radu
nare gli uomini del mondo
intero». Bill McCartney ha
inoltre annunciato che il movimento cercherà, nei prossimi due anni, di promuovere
la «riconciliazione razziale»,
organizzando manifestazioni
nelle capitali di tutti gli stati
americani, dove pastori testimonieranno quello che hanno fatto per promuovere la
riconciliazione razziale.
Bill McCartney, ex allenatore di football dell’Università del Colorado, ha lanciato
«Promise keepers» nel 1990
quando, rendendosi conto di
avere privilegiato la propria
carriera a scapito della propria famiglia, ha deciso di
cambiare vita. Da allora, il
movimento non ba smesso di
svilupparsi ed è diventato
una vera e propria impresa
nazionale, con più di 300 collaboratori che operano a partire da Denver, dove si trova
la sua sede. Il suo bilancio
nazionale è passato da 26 milioni di dollari nel 1994 a 177
milioni di dollari quest’anno.
Se il movimento si rivolge
specificatamente agli uomini, spiega Bill McCartney, è
perché sono loro che hanno
trascurato le loro responsabilità nei confronti delle loro
famiglie e delle loro chiese,
lasciandole alle donne. Sono
loro che commettono più delitti e che proteggono attività
degradanti quali la prostitu
zione e la pornografia. Alcuni
osservatori hanno espresso
dubbi nei confronti del movimento, facendo notare che
esso si situa nella tradizione
della destra religiosa.
Inoltre ricordano che Pat
Robertson, presidente della
«Coalizione cristiana», appoggia il movimento. Ma i
leader dei «Promise keepers»
negano di avere intenzioni
politiche. Secondo alcuni
media. Bill McCartney è vivamente contrario all’aborto e
in Colorado fa campagna
contro i diritti degli omosessuali. Parlando in televisione,
McCartney ha ribadito l’opposizione del suo movimento all’omosessualità dichiarando che «il peccato
dell’omosessualità non può
essere scusato».
Alcune femministe, che vedono nel movimento una minaccia, hanno organizzato
una manifestazione per denunciare ciò che, ai loro occhi, è una reazione contro il
movimento a favore dell’uguaglianza delle donne. Secondo McCartney, tocca all’
uomo esercitare l’autorità, «in
modo tenero e affettuoso».
Secondo un funzionario, il raduno del 4 ottobre era il più
importante che egli avesse
mai visto in 25 anni di servizio
a Washington. Due sociologi
hanno ipotizzato la cifra di
480.000 partecipanti. (eni)
guatamente - racconta Jacumin - ma ogni volta incontravo un fermo rifiuto. Il terreno
non era in vendita. Poi ho voluto tentare un’ultima volta
e, prima di incontrare il proprietario, ho chiesto ai miei
fratelli del movimento dei
Gedeoni di pregare intensamente perché cambiasse
idea. E quando sono andato a
trovarlo per rinnovargli la
mia richiesta mi ha risposto:
“Il terreno non è in vendita.
Per questo te lo regalo”. Ed io
ho pianto, ho davvero pianto». Un altro «miracolo» è
stata la scoperta del numero
delle stanze della vecchia costruzione da ristrutturare per
ricavarne l’albergo; «29, esattamente quanti erano i primi
valdesi giunti qui nel maggio
del 1893. Un altro segnale
che il Signore accompagnava
questo progetto».
Due miliardi di lire
Il «parco» costerà quasi
due miliardi di lire, più di un
terzo dei quali già messi a disposizione da Jacumin che,
sviluppando una delle prime
attività della colonia di Valdese, opera nel campo delle
macchine tessili; in particolare le sue officine producono
Jimmy Jacumin sul cantiere dei «Sentiero della fede» a Valdese
Trail of Fail h
‘Mñaí Mean These Stones? "
II logo del «Sentiero della fede»
un sistema che lavora più
della metà delle T-shirt prodotte negli Stati Uniti. Il «trail
of faith» è gestito da una società senza fine di lucro e raccoglie fondi da enti e privati,
tutti fiscalmente deducibili; è
quindi un progetto di privati,
anche se la locale comunità
valdese-presbiteriana vi contribuisce finanziando uno dei
15 monumenti del parco.
L’apertura ufficiale è programmata alTincirca tra un
anno e si prevede un afflusso
quotidiano di centinaia di visitatori: una volta avviato, il
«Sentiero della fede» sarà insomma una delie mete turistiche del Nord Carolina, un
ulteriore «business» della cittadina di Valdese legato alla
sua tradizione storica e culturale. Intanto «Big Waldo», una
antica sega a motore rimessa
in funzione da Jacumin, lavora le assi necessarie per gli
edifici ancora da costruire; si
stanno anche preparando gli
abiti tradizionali valdesi che
saranno indossati dalle guide
e dagli impiegati nel «parco»;
così come si sta lavorando a
un nuovo allestimento di uno
spettacolo teatrale che, dopo
aver ripercorso le tappe essenziali della storia valdese,
racconta la nascita e lo sviluppo della comunità immigrata in Nord Carolina.
Una «Valdesyland»?
Valdesyland? Uno strumento di divulgazione storica? Un programma di protezione della tradizione valdese nella comunità locale? Ed
sarà modo di presentare la
storia valdese «oltre le Valli»,
la storia dell’evangelizzazione nel Mezzogiorno e nel resto dell’Italia? Vi sarà una
spazio sulla Chiesa valdese di
oggi, i suoi programmi di testimonianza nel contesto
della realtà italiana e sudamericana? Molto dipenderà
dai programmi culturali che
il «parco» offrirà ai suoi visitatori «anche se - spiega Gus
Tron - qui la gente è molto
legata alla sua specifica tradizione che è quella dell'
emigrazione dalle valli valdesi e con queste coltivai
rapporto particolare». Ovviamente anche Jacumin, «l’uomo dei miracoli» come è stato definito, ha la sua risposti
sul futuro del «parco» e sull
sua finalità: «La gente uscm
dalla visita con una fedi
rafforzata, una fede cheli
renderà testimoni di quello
che avranno visto ed uditoafferma con l’entusiasmo eia
sicurezza tipica di una certa
spiritualità battista -. Dio
può fare un grande uso del
“Sentiero della fede”».
Addis Abeba: Conferenza delle chiese di tutta l'Africa
Per il pieno rispetto dei diritti dei bambini
Ogni giorno, nel mondo,
35.000 bambini muoiono
inutilmente; ogni anno, 13
milioni di bambini muoiono
di malnutrizione e di malattie cbe si potrebbero prevenire; un terzo di loro è africano. Questa è la triste constatazione fatta da una ragazza
di 16 anni durante la VII Assemblea generale della Conferenza delle chiese di tutta
l’Africa (Ceta), che si è svolta
dal 4 al 10 ottobre ad Addis
Abeba, capitale dell’Etiopia.
Theresa Siila è una delle sei
adolescenti che hanno partecipato alla presentazione
«Let thè children speak» (Lasciate parlare i bambini)
svoltasi nel quadro dell’Assemblea.
Nel mondo 130 milioni di
bambini in età scolastica non
possono andare a scuola; e «i
due terzi sono bambine», ha
aggiunto Theresa Siila. Questa questione della disuguaglianza tra ragazzi e ragazze
è stata spesso evocata durante la presentazione. Così, in
molte culture, ha precisato
un altro adolescente, Elezar
Asmalesh, le madri nutrono
meno a lungo le femmine e,
più tardi, danno loro meno
cibo solido che non ai maschi, il che spiega il tasso di
mortalità infantile più elevato fra le femmine. In alcune
zone del mondo, si lasciano
morire le femmine alla nascita perché i genitori preferiscono avere maschi.
Ilda Kuleba, delTAngola,
ha ricordato che in questi
dieci ultimi anni, 2 milioni di
bambini sono stati uccisi in
conflitti armati e tra 4 e 5 milioni sono stati gravemente
feriti. Parlando delTAngola,
Ilda Kuleba ha dichiarato che
uno studio fatto nel 1995
aveva concluso che il 60%
dei bambini angolani era stato testimone di un’uccisione.
«Come si possono valutare le
conseguenze psicologiche in
bambini che hanno visto
membri delle loro famiglie
assassinati o aggrediti sessualmente?», ha chiesto. Lamentando gli effetti disastrosi della guerra, Ilda ha ricordato che ci sono «150 milioni
di mine antipersona in 68
paesi, e altri 2 milioni vengono piazzate ogni anno.
È allarmante pensare che
una mina piazzata oggi potrebbe mutilare un bambino
cbe camminerà su questa
mina fra cinquant’anni». Bisogna sperare, ha aggiunto la
Kuleba, che la Conferenza
internazionale sulle mine
prevista per il prossimo dicembre riuscirà a proibirle.
«Sarebbe un meraviglioso regalo di Natale!».
Theresa Siila ha fatto notare che la presentazione degli
adolescenti dimostrava che
la Convenzione delTOnu sui
diritti del bambino, firmata
dai governi di tutto il mondo,
non viene rispettata. La Convenzione garantisce il diritto
dei bambini alla sopravvivenza e alle cure sanitarie.
alla protezione contro lo
sfruttamento e gli abusi,
all’educazione e allo sviluppo. Alcuni delegati, ha detto,
pensano probabilmente che
un giovane di 16 anni non
abbia nulla di importante ffl
dire ma, ha aggiunto, la Convenzione delle Nazioni Unite
ha conseguenze per le chiese
e per i genitori e non solo per
i governi. Essere «sensibiU^;
zati» al problema dei diritti
del bambino ma non far®
nulla in questo senso non
basta: «Non è a causa di coloro che fanno del male che
il mondo è pericoloso, ma®
causa di coloro che lascian
fare», ha aggiunto Siila citando Albert Einstein.
Nel corso del dibattito successivo si è parlato della posi
zione delle chiese
all’uso dei preservativi, u
membro di un gruppo di st
denti etiopici invitati al
battito ha rimesso in disc
sione l’opposizione di alcu
chiese all’uso dei preserva
che, ha detto, potrebbe co
sentire di limitare il f
di bambini nelle famigli® P,
vere. Per alcuni deleg '
l’astinenza sessuale è n
glior modo per assicutat®jj
controllo delle nascite '
prevenzione dell’Aids. Ma®.
pastore ba incoraggia^^^j.
chiese a mostrarsi piu
che!'
stiche e a riconoscere gente ha un’attività 2®
qualunque sia Timpot
che le chiese danno mi®
zione dell’astinenza.
to cotti
Diano
TfAl
Jj ro,
Molti I
intnoi
■egli an
parola
Memo
ìtimmc
la pan
sùCrii
cpnesta
re è pr
imini, ì
ra più
^evc
Dioei
prola
■astaco,
LEr
COI
li, pen
imon
ste,
niapr
codec
certi d
mper
da COI
campi
Soavi
preti
storne
ñecos
promt
rispen
parole
vitti. 1
che Di
nostre
liberte
spezzi
della
tenza
in un
nessu
Neppi
legare
hente
Scora
tediq
TL3
ifigi
stello
ne COI
perto
di Di
ttffert
grazi!
toGe
conti!
Dio e
Sorte
verso
erac,
ma e
nonj
tellar
annu
Era i
delle
schia
nodi
ntna,
la di
kdi
tupe
Una
talve
tcate
nede
lise
9ues
Pare
forte